Il Centro Studi Nigra possiede una vasta collezione di materiali su Costantino Nigra, parte in originale e parte in copia.
busto Nigra dell'artista ceramista Roberto Perino
La catalogazione delle molte migliaia di documenti disponibili nel Centro Studi è iniziata negli anni '70 ed è in fase di aggiornamento continuo, grazie anche alla donazione di molti collezionisti privati.
Il lavoro è stato eseguito inizialmente da Loris Sapia e Luigi Verretto Perussono, a cui va il sincero ringraziamento del Consiglio Direttivo, e poi dai soci Roberto Favero, Franco Macocco e Marco Marcon. Man mano in questa sezione verranno inseriti nuovi documenti catalogati, che potranno così venire individuati ed eventualmente scaricati dagli interessati.
Nel Centro Studi sono conservati i seguenti documenti storici (riportati integralmente nel seguito):
- atti parlamentari - commemorazione Nigra del Presidente del Senato Tancredi Canonico, il 2 luglio 1907
- commemorazione 50 anni dalla morte tenuta dal Ministro degli Esteri Giuseppe Pella, il 20 ottobre 1957 a Castellamonte
- commemorazione 50° della morte tenuta dal Conte Prof. Carlo Toesca di Castellazzo, il 27 dicembre 1928 a Torino
- commemorazione Nigra di Francesco D'Ovidio, filologo ed ex-senatore, articolo pubblicato sulla rivista Archivio Glottologico Italiano - Vol XVII° - p.1 Torino - Loescher - 1910
- commemorazione Nigra di Carlo Trabucco sindaco di Castellamonte, Scuola di Applicazione dell'Esercito a Torino, 15 febbraio 1968
- commemorazione Nigra di Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon - senatore del Regno d'Italia, pubblicata su Corriere diplomatico e Consolare - Roma, 1928
- discorso, per la partenza da Parigi di Costantino Nigra a fine mandato, pronunciato dal Cavalier Angelo Toffoli a nome della Giunta della Società di Beneficienza parigina - 28 giugno 1876
ATTI PARLAMENTARI - COMMEMORAZIONE NIGRA AL SENATO IN ROMA - 2 luglio 1907 Tancredi Canonico, Presidente del Senato

Signori Senatori! (Vivissimi segni di attenzione).
È col cuore profondamente commosso che annunzio al Senato la morte del nostro egregio collega Costantino Nigra, avvenuta ieri notte a Rapallo, ove erasi recato per ritemprarsi alle aure marine di quella incantevole spiaggia.
Quando, nel 1843, al Collegio delle provincie di Torino, cominciavamo a studiar leggi insieme, leggevamo romanzi, facevamo versi, giocavamo nelle ore libere con la franca e spensierata allegria dei nostri quindici anni, poteva io pensare che, dopo tanto tempo, avrei qui dovuto commemorarlo?...
Egli nacque a Villa Castelnuovo (Canavese) l'11 giugno 1828. Di elettissimo ingegno, nel quale si contemperavano mirabilmente la nota geniale dell'artista, lo spirito osservatore, il retto ed equilibrato criterio nel giudicar delle cose - agevolato da una serie di circostanze favorevoli - Costantino Nigra percorse rapidamente una splendida carriera, nella quale rese all'Italia servigi eminenti in tempi non facili.
Nel concorso d'ammissione al ministero degli esteri, il Nigra fece un lavoro stupendo, che entusiasmò Massimo d'Azeglio, il quale dirigeva allora quel dicastero. Succedutogli Camillo Cavour, che aveva il fiuto giusto del vero valore, se lo ebbe carissimo, lo portò seco quel segretario al Congresso di Parigi, dove - ancora in età giovanile - fu più tardi ambasciatore fino alla caduta del secondo impero.
Altamente apprezzato da Luigi Napoleone, egli si adoperò con fine accorgimento a promuovere tutto ciò che potesse agevolare la nostra ricostituzione politica; specialmente quando si trattò della cessione della Venezia, avvenuta in momenti in cui meno la si poteva aspettare.
L'importanza dei servigi da lui resi all'Italia si farà vieppiù manifesta quando potranno venire in luce i documenti e le memorie, che il dovere del segreto diplomatico e la sua modestia tennero finora in gran parte celati.
Nelle ambasciate di Londra, di Pietroburgo, di Vienna, come già in quella di Parigi, egli seppe sempre tener alta la dignità del nostro paese ed acquistarsi particolare stima dai vari Sovrani presso cui fu accreditato, e la massima considerazione dai loro Governi.
Nominato senatore il 4 dicembre 1890, dovette alcuni anni dopo - a motivo dell'età e della malferma salute - ritirarsi dalla diplomazia, tornando con più vivo zelo ai suoi lavori prediletti di lettere e di storia, che, anche in mezzo alle cure politiche, non aveva mai abbandonato.
Basti ricordare la sua Fonetica del dialetto di Val Soana, le Reliquie celtiche, le Glossae hibernicae veteris codicis Taurinensis, Le comte de Cavour et la comtesse de Circourt (lettres inedites), la sua versione dell'ode di Callimaco, I lavacri di Pallade, la Rassegna di Novara, in cui spira il verso che fa santa la tomba, ed immortale Il lauro ai forti per la patria estinti, e che si sente sgorgare dal cuore dell'antico volontario del 1848, ferito nelle prime battaglie per l'indipendenza italiana.
Socio di molte insigni Accademie scientifiche nazionali e straniere, nominato dottore honoris causa dall'Università di Edimburgo, fu dal nostro Sovrano decorato dell'ordine supremo della SS. Annunziata.
Fiore di montagna gagliardo e vivace - trapiantato in mezzo alle più splendide Corti di Europa, ne acquistò tutto il garbo e la scioltezza signorile, ma nulla perdette in quell'ambiente della gagliardia e della vivacità nativa. In mezzo alle riunioni mondane ed alle note diplomatiche, egli non cessava dal coltivare i cari suoi studi, dal raccogliere canzoni popolari (in cui si conservano per lo più le tradizioni leggendarie su fatti d'arme patrii, su celebri capi guerrieri, su amori infelici), raffrontando quelle dei vari paesi sul medesimo soggetto. Mi ricordo, fra le altre, di un'interessante leggenda,che egli poté trovare quasi identicamente ripetuta in versi provenzali, piemontesi, e di due altri dialetti, e che mi mandò in dono quand'era ambasciatore a Londra.
Al disotto del Nigra diplomatico, vi era sempre il Nigra poeta, artista, spesso entusiasta: ed è da questo Nigra interiore che irradiava quell'indefinibile vezzo gentile, che lo rendeva singolarmente simpatico.
Fedele quale egli era alle amicizie - la nostra durò senza nube per oltre sessant'anni: ed ogni volta che ci vedevamo, erano sempre i due compagni di collegio che si trovavano insieme, con la stessa gaiezza e fidente espansione d'allora. Perdonate se ho forse troppo parlato di ricordi personali. Ma essi sono per me inseparabili dalla figura di Costantino Nigra: e desidero che, nella corona d'affetti deposta oggi dal Senato sulla tomba dell'illustre e profondamente compianto nostro collega, non manchi il fiore semprevivo di una schietta ed inalterata amicizia. (Vivi e prolungati applausi).
TITTONI, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
TITTONI, ministro degli affari esteri. Quale vita operosa e quanto nobilmente spesa per la patria si è spenta con Costantino Nigra! Essa è così intimamente collegata al nostro risorgimento nazionale che per ritrarla non basterebbero pochi cenni di biografia ma occorrerebbe un volume di storia.
Il nostro Presidente ne ha tracciata una sintesi che comincia dal 1848 quando egli volontario nel Corpo dei bersaglieri durante la guerra dell’indipendenza fu ferito alla battaglia di Rivoli, e giunge ai nostri giorni attraverso memorabili
avvenimenti. Dovendo scegliere tra questi, a me piace ricordare quattro momenti della vita di Costantino Nigra che segnano inestimabili servigi da lui resi al paese, e cioè la parte notevolissima che egli ebbe nei negoziati confidenziali che precedettero la guerra del ’59; la sua efficacissima azione diplomatica nel periodo che precedette la guerra del ’66; l’azione sua decisiva presso il Governo francese dopo il 4 settembre 1870 per le risoluzioni immediate in vista dell’occupazione di Roma; l’opera sua assidua a Vienna per stabilire intimi e cordiali rapporti tra l’Austria- . Ungheria e l’Italia.
Ed altro non dico, poiché troppi ricordi si affollano alla mia mente, troppi ricordi si affollano alla mia mente, troppi sentimenti tumultano nel mio animo , nel quale il dolore è associato alla riverenza ed alla ammirazione.
In nome del Governo, io partecipo al lutto del Senato e della Nazione.
(Approvazioni vivissime. Bene, benissimo). DE SONNAZ. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
DE SONNAZ. Io certo non voglio fare la storia del senatore Nigra; ma mi limiterò ad associarmi a quanto l’illustrissimo nostro Presidente e l’onorevole ministro degli affari esteri hanno detto di tanto uomo.
Il rimpianto senatore Nigra per più di mezzo secolo servì fedelmente e lealmente l’Italia nelle circostanze più delicate e più difficili: dal giorno in cui venne ferito sulle alture di Rivoli, il 22 luglio 1848, quale bersagliere nella compagnia degli studenti di Torino, nell’ultima vittoria delle armi subalpine nella prima guerra dell’Indipendenza (vittoria che fu capitanata dal generale senatore De Sonnaz mio padre) sino al dì in cui lasciò l’ambasciata di Vienna.
Io rammenterò soltanto un fatto che prova il suo gran cuore. Il senatore Nigra era di una bontà e di una gentilezza senza pari con tutti coloro che avevano l’onore di essere del suo personale nelle varie ambasciate. Egli li trattava con la massima cortesia, talché poteva essere considerato come un amico, anzi come un parente. Il Nigra si era acquistata una tal fama fra noi, che abbiamo servito al suo fianco, che lo consideravamo come il nostro illustre maestro e avevamo per lui una profonda venerazione. La storia della sua vita è splendida. Egli non solo era un gran diplomatico e un grande letterato, storico e poeta, ma anche un gentiluomo perfetto e un nobilissimo cuore. (Approvazioni vivissime).
Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 2 luglio 1907.
COMMEMORAZIONE 50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE di COSTANTINO NIGRA
Ministro Esteri Giuseppe Pella, Vice Presidente del Consiglio - Castellamonte 20 ottobre 1957

Sigg. Sindaci, Eccellenze, Onorevoli Colleghi ed Amici, Signore, Signori,
Quando, come oggi accade a noi, ci si trova riuniti a commemorare, in un'atmosfera che ha il carattere della celebrazione, un personaggio, che ha lasciato più o meno marcata una traccia di sé nel campo del sapere umano, in quello della scienza, o in quella degli avvenimenti umani, che spesso con una generosa interpretazione usiamo chiamare Storia, e questa commemorazione si svolge nel luogo, dove la vita del personaggio si è sviluppata, ovvero là, dove la Sua anima ed il Suo spirito si sono formati, comunque là, dove il segno del Suo passaggio è stato più diretto ed immediato, è estremamente difficile sfuggire ad una sorta di commozione, che vorrei dire locale e che ha il senso genuino e caro delle cose di famiglia.
E Voi, amici di Castellamonte, amici di questo splendido Canavese, mi potete rendere testimonianza di questo sentimento in questo momento.
Voi, che ogni giorno ripercorrete le strade lungo le quali si avviò alla vita il giovane Costantino Nigra che oggi riposa, ancora una volta, in mezzo ai Suoi a Castelnuovo; Voi, che dalla voce dei vostri padri avete raccolto la narrazione testimoniata per diretta conoscenza di quanto questo vostro conterraneo ha compiuto per la Sua e per la nostra grande Patria; Voi, che avete ricevuto, lasciata da Lui dopo paziente ed amorosa ricerca, la raccolta delle Canzoni della vostra terra; Voi, sentite che qui c'è aria di una festa di casa, direi di più, la gioia di una festa casalinga e ciò anche se siete ben consapevoli che, mentre il ricordo si muove verso un uomo della vostra terra, è verso orizzonti più larghi, non solo regionali, non solo nazionali, anzi che si proietta a cercare testimonianza, il senso e la concreta realtà della celebrazione odierna, perché, e desidero affermarlo subito, in Costantino Nigra sono due gli aspetti della personalità che immediatamente vengono alla luce: l'aspetto nostrano, piemontese, ma direi, più canavesano del letterato e dello studioso; quello nazionale e, forse, ancor più internazionale del diplomatico, e, notatelo, sono due aspetti che nel loro coesistere non si sovrappongono, non si intralciano, anzi, si completano a vicenda nella figura di Costantino Nigra.
II primo è alimento del secondo, e, questo ultimo, parametro sicuro per una più serena, ponderata e sicura del primo, perché, e non sembri, o Signori, assurda e forzata l'interpretazione, penso si possa ben affermare che il Nigra filologo ebbe giovamento dal Nigra diplomatico, e ciò non solo in sede di classificazione e di permanenza storica, così come il Nigra diplomatico ebbe alimento e sostegno dal Nigra filologo, e ciò non soltanto per la inscindibilità dei diversi aspetti della Sua personalità, che pure era una nel suo assieme, come è una per ogni uomo che vive su questa terra, ma perché, e ciò può essere monito ed insegnamento per tutti noi per la interdipendenza dei sentimenti, non può essere vero un amore del proprio paese, delle cose del proprio paese, delle tradizioni della propria Patria, quando non si abbia altrettanto vero e profondo l'amore per il più ampio consorzio civile: per l'umanità tutta intera.
Cosi come non può durare, perché superficiale e non nutrita di quella linfa vitale, che solamente matura nel giro delle cose che ci toccano da vicino e che amiamo, perché abbiamo imparato a conoscerle con amicizia fin dal primo momento, non può durare, dicevo, se non in sede astratta e perciò non fruttifera, né moralmente valida, un sentimento di fraternità e di convivenza internazionale, quando esso non sia affiancato da un altrettanto valido e forte sentimento di fraternità locale.
Viviamo oggi in un mondo, nel quale le frontiere dimostrano ogni giorno più la tendenza ad unire, ancor più che a separare; viviamo un'epoca in cui sopra di noi si intrecciano ad una velocità, che fatichiamo ad immaginare, le orbite di satelliti artificiali, e le traiettorie di missili intercontinentali, eppure, mentre siamo convinti che i discorsi della Storia si muovono su prospettive mondiali, siamo altrettanto convinti che è ancor sempre con le parole che hanno permesso a noi di decifrare le cose e di coordinare i nostri primi pensieri con le parole di casa nostra, che questi discorsi hanno la proprietà veramente di compiersi; ed è per questo che noi Piemontesi siamo stati capaci di intendere la portata ed il significato dell'unità italiana! Così come è per questo motivo che oggi noi Italiani siamo capaci di intendere e sinceramente operiamo per l'unità europea, guardando la nostra casa, la nostra Patria, come ad un porto a cui fare ritorno per rifornire il nostro spirito, per salpare ogni volta verso l'ampiezza di collaborazione e di intese più larghe senza il timore che lungo il viaggio ci manchino le forze e le persuasioni.
In questo spirito, Signore e Signori, io intendo qui ricordare Costantino Nigra piemontese ed europeo, l'uno e l'altro aspetto in funzione della missione che Gli fu commessa di servire l'Italia.
La Sua vita è, pur nella complessità delle vicende che lo ebbero partecipe e in quelle degli interessi che si affacciarono via via al Suo spirito, tutta nella traiettoria segnata da questa concezione unitaria ed interdipendente degli aspetti locali e degli aspetti universali della Storia e del costume, concezione che è innata in Lui, trovò senza dubbio vigore e forza nella consuetudine di lavoro con l'altissimo spirito che fu il Conte di Cavour, perché, e diciamolo pure qui nella Sua casa, Nigra,non sarebbe stato Nigra, se non avesse avuto la fortuna e, soprattutto, la capacità di vivere accanto a Camillo Cavour, poiché non a tutti è dato di avere la capacità di vivere accanto ai grandi.
Soldato, diplomatico, poeta, uomo di studio e di azione, personaggio complesso e di molteplici capacità, Egli si distinse, fra quanti ebbero una parte di rilievo nella storia del nostro Piemonte, per avere ricevuto più di ogni altro, Lui, metallo di ottima lega, l'impronta di Cavour.
"C'est, come ebbe a scrivere il giornale "Le Monde" di Bruxelles pochi giorni dopo la morte, a cette école, et il est de ces maitres qui revivent dans leurs disciples'" nessuno più di Costantino Nigra si è formato giorno per giorno, con pazienza ed intelligenza estreme, alla grande scuola di ardimento umano oltre che di diplomatico e politico del grande statista.
Insieme al Visconti di Venosta e Isacco Artom, Egli ha ricevuto direttamente come metodo, come stile, come sensibilità, l'eredità cavouriana, sempre più affinandosi con gli anni e con l'esperienza; cosicché, noi lo possiamo, senza dubbio, considerare certamente uno dei più grandi ambasciatori; forse, il più grande ambasciatore che abbia servito in questo secolo di storia lo Stato unitario.

il ministro Pella in visita alla mostra della ceramica di Castellamonte col Sindaco di Castellamonte
Signori, ho volutamente detto: servito, perché questa è stata la caratteristica fondamentale della Sua azione; questo è stato lo spirito e l'impegno con il quale Egli si muoveva in campo internazionale.
II senso dello Stato, quel senso dello Stato, che mai come oggi sentiamo indispensabile, era in Lui profondissimo, e nessun interesse personale di carriera o diverso, potè mai anche lontanamente, offuscarlo. E ciò, anche quando la salute e gli anni e le inevitabili amarezze che una carriera, lunga come la Sua, reca con sé; amarezze che in altri, meno di Lui temprati, potevano segnare un umano lasciarsi andare.
Tutto questo non può suonare a meraviglia; basti in fondo, per capirlo, guardarci un poco tutti negli occhi, in questo nostro vecchio Piemonte, in questo Canavese, che il Nigra ha sentito vibrare vivo e partecipe continuo della Sua avventura terrena, dalle origini sino al letto di morte.
Ho accennato alla inscindibilità dell'amore verso la propria terra dall'amore verso più ampie zone umane, e vorrei ora, proprio qui, abusando forse della vostra pazienza, mentre mi è venuto caro accennare al senso dello Stato, profondissimo e totale nel pensiero di Costantino Nigra, vorrei, proprio a questo punto, rifarmi, per un brevissimo momento, al senso del Canavese, così prepotente in Lui.
Egli, infatti, si è sempre sentito intimamente legato alla Sua terra e poco fa ne abbiamo sentito i Suoi canti. A questa terra del Canavese, a questo angolo di terra piemontese, ad essa è sempre ritornato in tutti i momenti liberi dal Suo snervante lavoro, ma il Suo, appunto perché era vero e sincero, non è stato un amore platonico puramente georgico, un amore letterario o di posa, secondo certe costumanze ancora oggi in atto; al contrario, Egli ha saputo e voluto penetrare a fondo le pie intime fibre di questa nostra terra, di questa nostra piccola Patria, ha voluto conoscerla e farla conoscere.
I Suoi studi eruditi su Ivrea, sulle origini della Casa Marchionale, che congiungono all'attenta ricerca delle tradizioni popolari, di cui, anche come metodo, è il bellissimo Saggio, che Carlo Trabucco ha dedicato nel suo volume "Questo verde Canavese" al Nigra, ne documenta le tappe e ne descrive il cammino, di cui, ripeto, Egli fu, senza dubbio, un pioniere.
Quel suo andare per le nostre campagne a raccogliere dalla bocca stessa dei vecchi contadini i canti dialettali, che altrimenti sarebbero andati perduti; quel Suo descrivere puntuale, con attenta'cura del particolare, antiche cerimonie e consuetudini popolari del Canavese, legate come origine alla Sacra rappresentazione con i riti religiosi per il Natale e per la settimana santa, tutto questo testimonia come Costantino Nigra sentisse vivere dentro di sé, nel profondo, lo spirito della Sua terra, di questa terra del Canavese, della gente alla quale Egli apparteneva,
Ed è da questa conoscenza dello spirito locale, fatta di rispetto verso alcuni principi ben definiti, chiaramente individuati, non discutibili, quali: la famiglia, il lavoro, la fedeltà, la parsimonia, la concretezza, e da questa conoscenza profonda e meditata, dicevo, é perciò diventata patrimonio dello spirito, che Egli costruì per il proprio impegno morale, la regola del servizio, perché Nigra univa ad eccezionali doti fisiche, ad uno spirito permeato di mondanità e di buon gusto, tutte le ca-ratteristiche e le qualità di un uomo estremamente serio.
Era un uomo che prendeva la vita sul serio, come è abitudine da queste parti; lo dimostrò appena ventenne, quando lasciò gli studi per battersi a Rivoli come bersagliere e vi rimase ferito il 21 Luglio 1848.
Ne diede conferma più tardi, pochi anni dopo, in un episodio che gli aprì dritta dritta la strada all'affetto e all'ammirazione del Conte di Cavour.
Ciò avvenne quando il Conte, una, domenica, si trovava al Ministero solo a lavorare (qualche volta succede). Ad un certo momento della mattinata, Cavour chiese all'usciere se vi fosse presente qualcuno al Ministero, che gli potesse dare una mano per stendere un suo rapporto. Gli fu risposto che di là, c'era un biondino, un giovanotto appena entrato in carriera, che compiva, come tutti in quell'epoca, i due anni di servizio volontario gratuito.
Cavour lo fece chiamare, fu soddisfatto della Sua opera, e, da quel momento, Nigra fu il più intelligente esecutore, interprete, spesso anticipatore degli ordinamenti e delle direttive del Maestro, il quale dal 1855 lo prese interamente al suo fianco e diede all'uomo e al negoziatore, intera la sua fiducia e giunse a dire di Lui: "Egli ha più talento di me (ed era Cavour che parlava) conosce perfettamente le mie intenzioni, le sa eseguire come nessun altro"
Questa sintesi spirituale ed affettiva, prima ed oltre che di indirizzo politico, era destinata a rimanere come l'elemento di fondo, personale ed umano, dell'azione diplomatica di Cavour presso Napoleone III, dal 1855 fino alla morte.
Fu infatti il Nigra, e non certo il Villamarina, nostro rappresentante ordinario a Parigi, colui che rappresentò sulle rive della Senna, di fronte all'iniziativa personale di Luigi Napoleone, la controparte: sarda prima, italiana poi.
L'opinione degli studiosi, d'altra parte, suffragata dalle testimonianze documentarie, è precisa su questo punto, e la scelta di Cavour non poteva essere migliore.
La presenza della duplice politica della Francia dell'epoca, quella di Napoleone e quella sfocata e sempre scavalcata, anche se ufficiale, del conservatore Walewsky, aveva reso necessario rispondere attraverso un plenipotenziario, ufficioso questi.
II Nigra teneva i rapporti direttamente ed esclusivamente con il Cavour, saltando tutti i canali ufficiali. La stessa corrispondenza gli veniva inviata attraverso messaggeri speciali e segretissimi, cosicché il Nigra divenne, per forza delle circostanze, il vero rappresentante del Re di Sardegna.
Ed è qui che si manifesta un altro carattere, che oserei dire, tipico del Piemonte: il saper stare al proprio posto.
Non fu mai il Nigra, pieno di riguardo e delicatezza come era, non fu mai il Nigra a farsi avanti, anzi, quando con il Villamarina alla fine si dovettero mettere le carte in tavola, fu proprio Costantino Nigra che ne soffrì maggiormente.
Purtroppo si trattava in quei tempi ed in quella situazione, di circostanze obbligate, di necessità dettate dalla particolare politica napoleonica così complessa e personalissima ed ogni riguardo privato doveva passare in ultima linea di fronte all'interesse supremo della causa italiana.
Villamarina lo capì ed il Nigra poté continuare la Sua opera, ormai, senza sotterfugi.
Questa particolare posizione ufficiosa ed ufficiale di vero uomo di fiducia di Cavour a Parigi, consentì al Nigra di farsi, nel senso esteso del termine, una propria personale posizione nella capitale francese e presso la Famiglia Imperiale.
La Sua sincerità di sentimenti, la Sua schiettezza, il Suo tratto cavalleresco e romantico, piacquero a Napoleone III ed all'Imperatrice, cosicché essi ricambiarono con la più aperta fiducia i sentimenti del giovane emissario di Cavour.
Egli venne poi accusato in Italia d'essere stato più il rappresentante del Bonapartismo, che non il portavoce della Nazione italiana; ma nessuna accusa è più falsa dì questa. I risultati acquisiti stanno a dimostrarlo.
Caduta la Dinastia dopo la guerra del '70, spettò al Nigra di sottrarre l'Imperatrice Eugenia alla calca della folla in rivoluzione, e, se continuò a rimanere legato ai due ex Sovrani, fu in grado di iniziare, subito ed efficacemente, fiduciosi rapporti cogli esponenti della Terza Repubblica dal Pierre al Gambetta. Ai primi lo legava, romanticamente, il passato; a questi ultimi, il dovere di rappresentante della Nazione italiana.
Nessun contrasto per un uomo e per un ambasciatore della statura di Costantino Nigra, fra questi due sentimenti egualmente nobili, non rinnegando il passato, Egli poteva, tuttavia, tener conto della realtà del presente.
In verità le relazioni che gli riuscì di coltivare nell' ambiente dei due Napoleonidi, il fascino, la mondanità, e soprattutto, i legami di saldo affetto che Egli stabilì con l'Imperatore e colla Famiglia imperiale, la stima che riscosse poi, dopo il '70, presso gli esponenti del nuovo regime, da Lui conosciuti nel salotto della contessa di Circourt, tutto venne da Lui messo al servizio del Suo dovere, cioè, in concreto, della Sua azione diplomatica, perché Egli, alla scuola di Cavour, e grazie alle Sue doti eccezionali, fu e rimase fino all'ultimo il diplomatico classico.
Avvertì cioè tutto il peso e tutta l'importanza delle relazioni personali del muoversi attivo e disinvolto nell'ambiente dirigente del 2° Impero e, più tardi, in quello della Repubblica e, infine, dopo il '76, nelle sedi di Vienna, di Londra, di Pietroburgo. Un muoversi sorretto da idee molto chiare e dall'impegno che divenne in Lui, quasi una seconda natura di conferire, alle relazioni fra l'Italia ed il Paese in cui era accreditato, un clima di lealtà e di chiarezza come era normale per la Sua anima di piemontese; e ciò non sembri in contraddizione coll'affermazione che ho fatto precedere: essere il Nigra un diplomatico classico.
Attorno alla parola "diplomatico" si muove spesso la fantasia popolare a cercare chissà quali immaginose storie di misteri e di giochi complicati; di parole non dette, perché siano intese, di costruzioni fascinose perché vestite di impalpabilità, facendo di determinate necessità tecniche e tattiche, la sostanza di un servizio che è, invece, ancorato alla più determinata realtà, anche se misurata in particolari prospettive.
Io sono convinto, e penso in questo momento di potere responsabilmente affermarlo, che un'azione diplomatica, o meglio ancora, un'impostazione di politica estera è tanto più producente e valida, quanto più lo è lineare e schietta, e ciò, non soltanto a lungo, ma anche a breve termine.
I problemi che costituiscono il fondo della politica estera sono sempre, non dimentichiamolo, Signori, problemi umani che si rifanno direttamente od indirettamente a determinate esigenze, a diritti o a doveri dell'uomo. Sono i problemi della libertà, della convivenza, dei rapporti sociali e dei rapporti economici: facce diverse di quel prisma a basi multilaterali, che è la personalità unitaria e complessiva degli esseri che vivono su questa terra. Ora, come avviene nei rapporti privati tra uomo e uomo, anche in sede di politica estera, anche in sede di diplomazia, che della politica estera è lo strumento, alla base del reciproco comprendersi sta un sentimento di fiducia e questo sentimento nasce e dura dalla constatazione di una reciproca lealtà e dalla conferma di una capacità di manifestare chiaramente e semplicemente questo sentimento; lealtà e chiarezza, virtù di sempre. La seconda, virtù dello spirito che presuppone ordine nelle proprie idee, capacità di sintesi, sicurezza di ancoraggi spirituali e filosofici. La prima, virtù dei rapporti umani, virtù sociale, veicolo della presupposta ed indispensabile chiarezza. Lealtà e chiarezza, l'una e l'altra reciprocamente necessarie, dal momento che la vita umana è costituita nella società; è stabilita, cioè, in sede comparativa come lo è in sede di sintesi. Lealtà e chiarezza che a loro volta determinano la capacità di operare delle scelte ed è questa, la capacità di scelta, un'altra delle doti del Nigra diplomatico.
Tempista eccezionale, munito di un senso storico di prim'ordine, Egli sentiva che non tutti i problemi potevano essere affrontati e risolti; altri problemi con la Francia, prima, coll'Austria, poi, dovevano subire un indispensabile processo di maturazione. Forzare i tempi verso una soluzione, sarebbe stato non diverso che precluderla. Per questo Egli esortò sempre il Governo a rifuggire da machiavellismi che lasciavano a desiderare, consentitemi la parola, e volle che venisse fatto ogni sforzo per imprimere alla politica estera italiana una chiarezza di idee e di propositi, e, pur attraver-so le oscillazioni ed i mutamenti tattici imposti dalle circostanze, ne facesse salvi i permanenti interessi in campo internazionale.
A questo proposito è qui necessario dichiarare che quando si considera la figura e l'opera di Costantino Nigra, come politico e come diplomatico, è necessario, per sincerità, distinguere in essa i tempi dell'epoca cavouriana dai tempi successivi alla morte di Cavour.
Ed è a questo riguardo che viene a stabilirsi nella valutazione del Nigra una, forse, limitazione che, se nulla toglie alla realtà dei Suoi meriti, li circoscrive tuttavia e li determina rispetto a quelli di altre figure che, in questo od in altri campi, hanno segnato di per sé, con il loro passaggio, un'epoca.
Nel periodo cavouriano, che coincide con la Sua piena giovinezza e la Sua prima maturità, Nigra ha sentito veramente di avere dietro di sé qualcuno, un cervello vulcanico, una molla potente, da cui partivano impulsi e direttive.
Riscaldato dalla grande fiamma cavouriana, Egli rispose con una iniziativa personale così intimamente connessa a quella del Conte, che è ben difficile, anzi, impossibile, operare una distinzione.
Tutto questo si avverte già nel '55-'56, poi nella preparazione dell'alleanza per la guerra del '59 e, infine, in tutti i complessi negoziati relativi alle Annessioni, alle impostazioni dei due problemi di Roma e di Venezia ed altri ancora.
E, come il Piemonte che, in fondo, non aveva molto da rischiare e poteva lanciarsi allo sbaraglio, così Nigra, sostenuto dall'ardimento consapevole e geniale di Cavour e dalla conoscenza di Napoleone III e dell'ambiente dirigente del 2° Impero, sentì di poter osare e rischiare, recando la Sua azione in Francia sino a raggiungere, per così dire, il limite di rottura.
Inserito nel clima cavouriano e ancora fremente dalle audacie di guerra del '48, il giovane Nigra non esitò a spingere ed a spronare lo stesso Cavour in modo da porre innanzi a Napoleone III dei fatti compiuti altamente impegnativi.
"Così ha fatto l'Imperatore, scriveva da Parigi nella primavera del '59, bisogna pigliarlo com'è e costringerlo con i fatti a non deviare ed a rientrare nella nostra via". Più tardi, nella piena crisi delle Annessioni, fu sempre il Nigra che pungolò e sospinse ad attuare queste Annessioni, senza farsi deviare dal pensiero e dalla preoccupazione dell'atteggiamento francese.
"Io non so cosa farà l'Imperatore, scrive a Cavour nel '60, ma questo è certo: che egli non potrà fare più del male che non ce ne saremmo fatti noi colle nostre mani, seguendo i suoi timidi consigli".
Rischio, ardimento naturalmente, ma non certo azione alla cieca, senza sapere prevedere le conseguenze. Vi fu, anzi, in Lui un vedere lontano, un sapere trarre dal Suo intimo contatto con Napoleone III, un chiaro giudizio della politica francese e, di conseguenza, la forza di spingere con decisione, sicuro del fatto Suo.
In questo, Signori, sta il valore come diplomatico di Costantino Nigra, perché un ambasciatore, o comunque un rappresentante di una Nazione in un'altra Nazione, intanto serve veramente il paese che rappresenta e insieme la stessa convivenza internazionale, in quanto riesce a chiaramente sentire e comprendere lo spirito della Nazione che lo ospita ed a farsi interprete degli orientamenti di fondo del suo ceto dirigente.
Nigra era di questa stoffa, inserito e ben inserito, grazie alle Sue qualità personali di cultura, di mondanità, di fascino anche, o Signori, nell'ambiente direttivo del 2° Impero prima, della 3a Repubblica, poi. Egli fu il tramite ideale tra l'Italia e la Francia, sia durante la crisi del '59 - '60, che durante i primi passi del giovane Stato unitario. Morto Cavour, Egli rimase, sì, al Suo posto, divenuto poi posto normale di ambasciatore a Parigi per altri 15 anni, ma in questa seconda fase, che proseguirà dal '76 in avanti, a Londra, a Vienna, a Pietroburgo, la Sua azione potrà avere una freschezza diversa.
La scomparsa di Cavour dalla scena politica, insieme alle maggiori responsabilità internazionali del nuovo Stato unitario, non era più soltanto il Piemonte che poteva tutto rischiare perche non aveva nulla da perdere; tutto questo aprì la strada ad un nuovo modo di fare ed anche di comportarsi. Egli cessò di essere l'uomo di fiducia personale di Cavour presso Napoleone, ebbe veste ufficiale di ambasciatore; la lettura dei rapporti di prima e di dopo, rapporti che Egli mandava da Parigi, dà netto il senso di questo cambiamento. Ad un tratto si avverte il prevalere in Nigra del personaggio ufficiale, forse la consapevolezza di questa particolare responsabilità ufficiale; in fondo Egli rifletteva in pieno quelle che erano le esigenze di un paese come l'Italia, che aveva così gravi problemi di assestamento interno da risolvere e che non poteva e non doveva compromettere i risultati raggiunti con avventure e passi arrischiati.
Ai giorni della conquista erano succeduti i giorni della organizzazione impaziente ed intemperante che avrebbero potuto essere fatali al giovane Stato italiano.
Dall'osservatorio di Parigi, dotato di una percezione di prim' ordine, il Nigra fu portatore sempre, Egli, che era stato cosi audace, ora era portatore di moderazione e di prudenza dimostrando una chiara conoscenza di situazioni ed avendo netto il senso di quello che era possibile fare. Così ad esempio, ancora nel Maggio del '65, Egli esorta il Lamarmora alla prudenza, a non compiere passi falsi in direzione di Roma e della Venezia. E testualmente scrive: "Il solo programma savio, pratico e possibile (notiamo l'aggettivazione che da sé può caratterizzare un temperamento, e non dimentichiamo che Nigra fu letterato fine e delicatissimo, perché cesellava quindi gli aggettivi), il solo programma savio, pratico e possibile, parmi sia il seguente: non fare pazzie per la Venezia, cioè, non fare una guerra che siamo ancora incapaci di sostenere e non provocare inutilmente l'Austria con discorsi o manifestazioni vane e pericolose. Quanto a Roma, attendere l'iniziativa dell'Imperatore, non insistere tanto da far credere che vogliamo forzargli la mano e domandare, quanto più forte si può, che Gujon impieghi più energia nel reprimere il brigantaggio alla frontiera. Intanto, armare e disciplinare l'esercito e procedere nell'applicazione delle misure unificatrici. Con questo programma avremo l'apporto della Francia senza il quale non potremmo mai giungere alla meta".
Successivamente la guerra del '66, le stesse vicende del '70, trovarono in lui da Parigi, lo stesso artefice che aveva contribuito a tessere la tela del '59.
Trasferito poi a Londra, a Vienna e quindi a Pietroburgo, con l'età e con gli anni, divenne, sul punto politico, anche più, profondo, seppure, forse, più disincantato. Soprattutto dopo la caduta della Destra storica, alla quale per tradizione cavouriana apparteneva, il Nigra avvertì la necessità per il Paese, come del resto avviene per qualsiasi Stato, di vedere appoggiata la realtà diplomatica ad un peso reale.
"La nostra azione diplomatica, scriveva da Pietroburgo nel Dicembre del 1882, se può essere, com'è talora, aiutata dalla posizione personale, vale, però, in sostanza, se non quello che vale la forza morale e materiale che sta dietro di noi, cioè l'autorità e la forza del Governo e del Paese che rappresentiamo."
E quest'espressione, Signori, non è soltanto da cogliere come il frutto di un' esperienza che si maturò in periodi particolarmente difficili ed in zone di vitalissimo interesse, essa è la testimonianza di un modo di pensare, per il quale anche la condotta di uno Stato ha un proprio codice morale che nessuna, anche clamorosa avventura, può ignorare ed accantonare.
E' un codice che si rifà, ancora una volta, a quelle due virtù di cui ho parlato: la lealtà e la chiarezza. Lealtà, verso l'esterno nell'azione diplomatica, verso se stessi, verso la condotta negli affari di uno Stato; chiarezza di idee sempre, sia verso l'esterno che per il reggimento interno; lealtà, cioè capacità e forza di misurare, senza deformazioni sentimentali, il proprio peso; virtù difficile, soprattutto in tempi di estesa ed imperante demagogia, quando sembra che l'azione sia determinata più dalle passioni che dal raziocinio, ma virtù essenziale per non dover scontare, nell'amarezza della delusione, l'arroganza della presunzione. Esempi non lontani nel tempo, ci ammoniscono a questo effetto; è la chiarezza, capacità e forza; cioè mai impostare, in rapporto alla portata reale delle proprie responsabilità, un'azione coerente e precisa e di mantenerla, perché fa parte della chiarezza anche la perseveranza e sono anche queste due: la chiarezza e la perseveranza, virtù rare o comunque faticose in questo periodo di tempo nel quale viviamo; altro rare e faticose, forse, più che in qualunque periodo della storia, ma sono le componenti necessarie, Signori, per determinare nell'ambito più o meno vasto, che le vicissitudini dei tempi assegnano alle Nazioni. Sempre notiamo una logica ferrea secondo la quale emergono, nel concerto dei popoli, quelli che possiedono un corredo di idee, di concetti, in cui saldamente e permanentemente credono; sono queste la lealtà e la chiarezza e la perseveranza, le componenti necessarie per determinare, nell'ambito più o meno vasto delle vicissitudini dei tempi assegnate alle Nazioni per determinare una reale necessità di presenza. Tutto quanto viene costruito fuori di esse e contro di esse, non può germogliare in frutti di bene duraturo, ed anche qui, a quest'effetto, avvenimenti ancora più recenti confortano la nostra certezza che soltanto in sede morale una Nazione, come un'ideologia, può diventare attiva al di là dei propri confini o al di là della cerchia dei propri sacerdoti.
"Non avventure, ammoniva il Nigra, non passi falsi, ma un continuo e completo adeguamento dell'azione internazionale dell'Italia alla sua effettiva consistenza senza l'albagia di alcuna presunzione, ma anche senza l'ombra di alcuna rinuncia", e noi, oggi, possiamo ripetere che dobbiamo prima creare all'interno con la concordia fra di noi, coll'ordinato procedere della nostra vita di nazione, che ha certamente i propri grossi problemi, ma che dimostra di saperli adeguatamente affrontare e coraggiosamente risolverli.
Dobbiamo creare, col prestigio del Governo, la premessa insostituibile per un muoversi efficace in campo internazionale; la possibilità di un'azione in sede internazionale è direttamente e indiscutibilmente subordinata alla capacità morale di stabilire all'interno le regole di una pacifica ed ordinata convivenza.
A questa moderazione, che noi riconfermiamo valida per tutti i tempi e per tutti i paesi, e della quale mai come oggi l'Italia deve rimanere fedele, Costantino Nigra giunse al termine della Sua carriera. A guardare la quale, a considerarla nel suo complesso, a valutarne la somma di energie spese, vi è da rammaricarsi che Egli non abbia voluto lasciare la sede diplomatica all'estero per attendere alla Consulta, allora sede del Ministro degli Esteri, a dirigere la politica estera della Nazione.
Due volte, nell'85 e nell'87, gli giunsero pressanti offerte di Depretis, di Crispi, dello stesso Re Umberto, ma Egli, dopo il '70, ebbe sempre meno fiducia nelle proprie forze, si rinchiuse a poco a poco in una sorte di fatalismo e di scetticismo, che nulla toglie alla Sua grandezza, e, se non riuscirono ad allontanarlo dalla responsabilità, finirono per togliergli, forse, ogni gusto della politica, che fu da Lui sempre intesa in un senso molto elevato, e alla quale aveva, forse, sacrificato anche il concreto formarsi dì una famiglia, intesa nella completezza dei Suoi impegni e nella vicendevole subordinazione della responsabilità.
Ma per noi, l'immagine vera e valida di Costantino Nigra, direttamente legata alla Storia d'Italia, è quella che emerge al fianco di Camillo Cavour, ed è quella che è testimoniata con amore continuo, con passione, non mai diminuita dall'amore per questa nostra terra piemontese.
Per avere certezza del primo aspetto, basta che si scorrano le prime pagine del carteggio intercorso fra il Nigra ed il Cavour. Si avrà il senso vivo, direi fisico, della presenza Sua come individuo nello sforzo collettivo, gigantesco del Risorgimento. Per avere la certezza del secondo, l'amore per questa Sua terra piemontese, è sufficiente scorrere i titoli dei volumi che Egli ha dedicato alla nostra vecchia terra piemontese.
"I Canti Popolari del Piemonte" è stato un bene che fossero ristampati, e, ancor oggi, costituiscono il lavoro più notevole sulla poesia popolare neolatina secondo gli studiosi specializzati, che furono la prima raccolta italiana di canzoni epico-liriche. "Le Rappresentazioni popolari" in Piemonte, alle quali ho già avuto modo di richiamarmi, e le Sue "Poesie" piene e pure, nell'impostazione classica dello stile, di infiniti richiami locali, storici e provinciali, dalle quali la dolce terra del Canavese è sempre direttamente o indirettamente presente.
Così a noi, oggi, Signore e Signori, ritorna il ricordo di Costantino Nigra, così lo sentiamo, oggi, nostro, di noi, qui, di questa terra, e ci piace prendere congedo da Lui riascoltando le parole che, quasi come in un testamento spirituale, Egli accompagnò alla consegna di una onorificenza ad un celebre attore della Comedie Francaise: "Siate il buongustaio della intellettualità, ma concedete la vostra ammirazione al carattere e alla qualità, che sono il frutto dello sforzo; se nel mondo incontrerete la virtù o il merito (e qualche volta, ciò succede ) fate loro riverenza, e, se del caso, andate loro in aiuto; siate in arte sincero come in ogni cosa; evitate la volgarità come delitto e sprezzate il denaro. Vi abbia Iddio nella santa Sua guardia". Così, Egli diceva.
Noi, oggi, le raccogliamo, queste parole, lieti di sentire in esse il suono casalingo di concetti, che il nostro spirito ha imparato a riconoscere subito, come la voce della mamma, carattere, qualità, sforzo, virtù, merito, sincerità: un metodo ed un programma di vita, al quale ci convoca la sacra tradizione che abbiamo avuto in consegna. La tradizione, che mosse da queste virtù per costruire l'Italia, oggi ci impegna tutti insieme ed uno per uno alla conquista di più larghe e necessarie solidarietà. E' un impegno, Signori, al quale non possiamo mancare.
Aveva ragione Costantino Nigra nel dire dei suoi conterranei: "Vi abbia Iddio nella Sua santa guardia!"
COMMEMORAZIONE del NIGRA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
tenuta dal Conte Prof. Carlo Toesca di Castellazzo il 27 dicembre 1928 a Torino
Premessa
II conte prof. Carlo Toesca di Castellazzo, dell'Università di Torino, aveva il 27 dicembre 1928, — in occasione del Centenario della nascita di Costantino Nigra — tenuto, nella sede della « Colonia Canavesana » di Torino, una Conferenza intitolata « Costantino Nigra e il Canavese », nella quale — accanto a rapidi ed efficaci cenni della figura del Nigra, come uomo di Stato e diplomatico espertissimo — era specialmente ricordato e tratteggiato il letterato, studioso della storia e della leggenda del Canavese, ed il cittadino innamorato e fedele della sua terra. Questa conferenza — ripetuta poi, successivamente, nel 1929-1930, ad Ivrea ed in altri importanti centri Canavesani — non era stata fin qui pubblicata, per ragioni varie.
Siamo grati al prof. Toesca per aver consentito di riprodurla nel nostro Nazionale: e non crediamo, malgrado che qualche anno sia passato dal detto Centenario, che la parola, ed ora lo scritto, del prof. Toesca perdano di attualità: le memorie storiche (specialmente se riferite a uomini politici) si rafforzano e si consolidano col tempo.
In questo momento poi la figura del Nigra, come diplomatico, acquista un ulteriore risalto dai nuovi cenni che ne da S. E. il conte De Vecchi di Val Cismon, in un altro bellissimo articolo pubblicato nella «Nuova Antologia» del 16 gennaio (1934-XII) dal titolo « Dai Ricordi Diplomatici di Costumino Nigra », in cui ci offre finalmente notizia dei suoi « Ricordi Diplomatici », ri-producendone un nuovo capitolo inedito.
(Nota del Direttore del «Nazionale»
I). — Non mi propongo qui di rievocare la grande, radiosa figura politica e diplomatica di Costumino Nigra.
Ha già assolto a questo altissimo ufficio da pari suo — nel Centenario dalla nascita del Nostro — S. E. il Quadrumviro Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, nella solenne commemorazione del Nigra da Esso tenuta il 1° luglio 1928 in Torino a Palazzo Madama, all'augusta presenza delle Loro Altezze Reali, il Principe di Piemonte ed il Duca d'Aosta, sotto gli auspici del Comitato Piemontese della Società nazionale per la Storia del Risorgimento (Nota 1).
Basti a me — in questo Circolo Canavesano, ove aleggia il più intenso e vibrante spirito di nostra gente e di nostra terra, di cui siamo figli devoti — ricordarlo e celebrarlo precipuamente come figlio della nostra ridentissima, verde e fiorita Prealpe, e come memore ognora — pur fra le agitazioni materiali e spirituali della sua intensissima vita politica e diplomatica, tutta spesa per l'unificazione e l'elevazione della patria — della sua origine schiettamente Canavesana; e infine come appassionato studioso — nella poesia, nella storia, nella lingua e nelle più inleressanti espressioni folkloristiche del costume — della sua diletta terra natale.
Parmi così — con questa modesta, ma appassionata esaltazione di Costantino Nigra canavesano — di portare ad Esso — a nome di tutti i conterranei, che vivono e lavorano a Torino, in Italia e nel mondo — un postumo tributo di devoto omaggio e di viva riconoscenza che sia tutto nostro, che sappia il profumo dei nostri fiori (specialmente spirituali), l'alito delle nostre brezze alpine, il candore delle nostre nevi, e l'azzurro intenso dei nostri cicli primaverili.
Certo quanto dirò di Lui, quale studioso del Canavese, è una meno appariscente (se pur ugualmente degna) parte della sua meravigliosa e multiforme attività, della sua poliedrica vita, tutta materiata di manifestazioni insigni dell'ingegno e del sapere: ma è parte che più direttamente ci tocca e ci conquide, quali suoi conterranei.
Un qualche pensiero, uno sguardo — a così dire — panoramico, occorre però pur qui rivolgere alla maggior fatica del Nigra. Essa fu — tutti lo sappiamo — la costruzione (di cui fu magna pars, accanto al genio di Cavour) dell'edificio italiano unitario !
La collaborazione sua a Camillo Cavour, dal giorno in cui questi — scopertolo al lavoro in giornata festiva, ancora modestissimo funzionario del suo Ministero — lo provò, e lo volle subito accanto a sé, facendolo ben presto depositario fedele, appassionato e consapevole dei suoi più intimi pensieri politici e dei suoi più alti ideali ed intuiti ricostruttivi della Patria: — la collaborazione sua (ripeto) all'insigne Statista piemontese nell'unificazione del Paese nostro, fu intensissima di giorno in giorno, vorrei dire, di ora in ora, con incessanti, unissone vibrazioni dei due poderosi cervelli e dei due cuori ferventi, fino alla morte immatura del grande Uomo di Stato che ancor rivolgeva al Nostro, fra i vaneggiamenti dell'agonia, parole profetiche, vaticinatrici dell'unità della Patria!
E' celebre — infatti — il giudizio di Cavour sul Nigra: « egli ha più talento di me, conosce perfettamente le mie intenzioni e le sa eseguire come niun altro » « II carteggio Cavour-Nigra », I, p. 4; e Chiala, «Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour », III 124, 224).
Con felice incisiva sintesi ha pertanto detto di Esso, Emilio Pinchia (altro insigne Canavesano da poco scomparso) nel suo dotto « Itinerario Canavesano », che « Costantino Nigra fu l'uomo rappresentativo del Risorgimento. Volontario bersagliere nel 1848, poeta della Patria, ascese per armi ed inni ad alti gradi, negoziatore politico, seducente e perspicace, coltissimo. Riprodusse nel suo spirito l'Italiano del 1400, con l'onesto taglio subalpino, sul modello degli Ormea e dei Bogino » (p. 329).
Ripeto, come sia appena possibile sfiorare qui, negli accenni, l'opera poderosa, politica e diplomatica (magistralmente ricordata e riassunta nella rievocazione testé ricordata di Cesare Maria De Vecchi) e di cui sono monumento e dimostrazione insigne i volumi or pubblicati del « Carteggio Cavour-Nigra », dal 1858 al 1861, ad opera della casa Zanichelli di Bologna, e per cura della R. Commissione Editrice dei Carteggi Cavouriani.
La lettura dei detti quattro volumi (Plombiéres, — La campagna diplomatica e militare del 1859, — La cessione di Nizza e Savoia e le annessioni dell'Italia Centrale, e La liberazione del Mezzogiorno) è sommamente interessante: bastano (infatti) i titoli dei Volumi, per far comprendere come il carteggio Cavour-Nigra, e cioè la copiosa, densa, nitida e nervosa corrispondenza epistolare scambiatasi fra Cavour e Nigra (nel duro ed incessante travaglio di quegli anni della riscossa nazionale) — e già prima raccolta, in parte, dal Canavesano Luigi Chiala, dal Bianchi, dal Mayor, dal Bollea, ecc. — non sia che il nocciolo della storia degli avvenimenti descritti nei detti volumi, in cui passano — attraverso alle lettere, anche più intime (e quindi più vicine all'anima degli insigni scriventi) — gli uomini più noti (italiani e stranieri) del patrio Risorgimento, e ne balzano fuori, in più netto e preciso contorno, fatti ed eventi.
Questi volumi — dice giustamente il Bosdari, nel numero del 16 novembre 1928 della Nuova Antologia (numero dedicato al Centenario di Costantino Nigra) ritornano più esattamente e più completamente « sul « grande periodo storico a cui si riferiscono, e ne riscrivono le vicende con ormai perfetta conoscenza di ogni recondito pensiero che guidò gli attori (tra i primi, il Nigra) dal dramma della formazione del Regno d'Italia, ed in modo speciale del suo protagonista, il Conte di Cavour ! ».
II). — Costantino Nigra nacque a Villa Castelnuovo (nella bella Valle di Castelnuovo, da Esso descritta nel suo « Natale » come vedremo) l'11 giugno 1828 dal Dottor Lodovico, di antica e distinta famiglia del luogo.
Suo avo materno fu l'insigne Prof. G. Bernardo De Rossi, docente espertissimo di lingue orientali, che trasfuse certo nel pronipote la passione alle ricerche linguistiche.
Bello, il Nostro, svegliatissimo d'ingegno, studiò alacremente — dopo i primi rudimenti elementari al Paese nativo — ad Ivrea, e poi a Torino, nel benemerito Collegio delle Provincie: uscì brillantemente laureato in legge, dopo avere valorosamente combattuto, quale volontario bersagliere, nella guerra del 1848-49, ed esser rimasto ferito nella battaglia di Rivoli il 21 luglio 1848.
L'11 luglio 1851, ventitreenne, venne assunto come volontario nel Ministero degli Esteri. Era, nel vecchio Piemonte, la via segnata ad ogni aspirante d'impiego: obbligato a prestare servizio non retribuito per molti mesi, talvolta per un biennio. E così il Nigra fu promosso applicato di quarta classe, con annue L. 1000 di soldo, nell'agosto 1853!
Non sdegnò il Nigra quel duro tirocinio, fidando — come avvenne — per una rapida e luminosa carriera, nella sua tenace volontà di lavoro, nella solida e svariata coltura, nel forte e duttile ingegno, assistito anche da elementi estrinseci non trascurabili mai: una bella presenza fisica, ed una grafìa stupenda che rispecchiava la chiarezza, sicurezza ed eleganza del suo spirito prodigioso.
« Alto della persona » — lo descrive infatti brillantemente Delfino Orsi in un interessante scritto sul Nostro (a cui l'Orsi fu legatissimo), nella citata nuova Antologia del 16 novembre 1928 — « sottile, spigliato, camminava a capo eretto, il busto svelto e snello e la ricca chioma inanellata, gli occhi brillanti, la fronte ampia e la ricercatezza signorile dell'abbigliamento, fecero presto di lui un irresistibile ».
Sono di quell'epoca le sue prime poesie, tra cui quella del 1854 — lodata da Alessandro d'Ancona — al suo cavallo, quando trascorreva con esso, i piani ed i colli del suo Canavese e...
« Allor che uditasi la sua pedata,
Sotto una cara finestra amata,
Una fanciulla pudica e mesta,
Gittava un fiore sulla sua testa! »;
e due anni prima (1852) quella ben nota, in occasione delle nozze di Alessandrina d'Azeglio — figlia di Massimo d'Azeglio, allora Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri (al cui Gabinetto apparteneva il Nigra) — col Marchese Matteo Ricci. La descrizione del Canavese, che egli fa in detta poesia (e che ricorderemo più avanti), è fra le più belle e suggestive, che io abbia mai letto della mia Terra. (Costantino Nigra, «Poesie originali e tradotte» a cura di .D'Ancona, Firenze 1914).
Questa poesia fruttò al Nigra la considerazione e simpatia di Massimo d'Azeglio, che lo raccomandò poi al Cavour. L'episodio che si narra sulla fortuna del Nigra presso il Cavour è però il seguente: In un dì festivo — come già si accennò — il Cavour, che lavorava (come al solito) al Ministero, aveva bisogno di finire un rapporto urgente, e mandò un usciere a vedere se per caso vi fosse qualche impiegato in ufficio. «L'usciere tornò» (ricorda Delfino Orsi) « dicendo che gli uffici erano deserti, e che « vi era soltanto un biondino, un giovinetto volontario. Cavour lo fece venire e lo pregò di coadiuvarlo nell'urgente lavoro, e poiché alla sera non era terminata l'incombenza, lo ritenne con sé il giorno appresso. Cavour, conoscitore rapido e profondo degli uomini, intuì subito il valore non comune di quel segretario fornitogli dal caso, e quando ne seppe il nome, ricordò il buon conto che ne faceva il D'Azeglio, e la raccomandazione di questi: lo tenne subito al suo Gabinetto, e ne fece in brevissimo tempo il suo più fido collaboratore ».
Cavour lo prescelse infatti, come suo segretario particolare, nell'autunno del 1855, allorché, pel viaggio a Londra e Parigi, il grande Ministro accompagnò Re Vittorio Emanuele a visitare gli alleati della guerra di Crimea, e cioè la Regina Vittoria e l'Imperatore Napoleone III. Viaggio trionfale fu quello che — se fece sacrificare a Re Vittorio dieci centimetri dei suoi lunghi baffi (taglio... cesareo impostogli da Cavour, perché gli Inglesi non parevano assuefatti a tanta abbondanza), gli valse però la completa simpatia dei Sovrani e popoli visitati, per la nobile franchezza del suo regale contegno.
E il conte di Cavour poi, che aveva già frequentato i Circoli parigini durante il regime orleanista, ottenne un vero successo in tutte le riunioni a cui intervenne. I parigini, com'è noto, sono grandi estimatori dello spirito, cioè di quella qualità che i Romani definivano : « argute loqui ». E questo dono, a tacere d'altri eguali e maggiori, il Cavour (e del resto, anche il fido suo Nigra) possedeva in altissimo grado.
Il risultato più importante della visita del futuro Re d'Italia a Parigi fu questo: in una riunione dopo pranzo alle Tuileries, l'Imperatore rivolse di botto al Conte di Cavour questa domanda: « Que peut'on faire pour l'Italie »? Cavour rispose non potergli dare una risposta immediata (data la importanza della domanda, e di chi la faceva) ; ma promise che l'avrebbe inviala da Torino. E la inviò tosto, sotto forma di Memoria.
La Memoria fu compilata da Camillo Cavour, che la fece copiare dal Nigra, il quale scrive (in una primizia dei suoi Ricordi diplomatici, concessa per la pubblicazione alla Gazzetta del Popolo, l'11 novembre 1903):
« II Cavour me la lesse, guardandomi sovente in faccia, come se volesse spiare l'impressione fatta in me da quella lettura. Suppongo che in quel momento io facevo la parte della serva di Molière. Detta memoria fu mandata per corriere al Marchese di Villamarina, e posta sotto gli occhi dell'imperatore Napoleone. Essa è pubblicata e non ho a giudicarla. Le conclusioni erano assai modeste. Ma, nel copiarle, io vedevo disegnarsi tra le righe la grande figura dell'Italia unita! ».
Anche Costantino Nigra — sebbene in allora modesto segretario — si ambientò subito brillantemente a Parigi, in quella grande capitale francese, nella quale la sua figura doveva poi dominare eminente nel campo politico e diplomatico fin dopo la caduta del secondo Impero.
Ed a Parigi il Nigra ritornò, tra il 1856 e 1857, per temporanei incarichi: e poi fu magna pars, — pur rimanendo abilmente fra le quinte della ben riuscita scena — di quella famosa missione del 1858 (che prende il nome da Plombières) presso Napoleone III, anzi presso la Corte Napoleonica, che fruttò al piccolo Piemonte l'alleanza colla Francia e la gloriosa guerra del 1859!
Il lavorio diplomatico intensissimo del grande Ministro, mirabilmente assecondalo dall'abilità di Costantino Nigra (che compì la sua missione non ufficiale, e singolare nella forma e ardita nei mezzi, in modo preclaro: mentre sospettoso e quasi dolente ne era il rappresentante ufficiale a Parigi (marchese dì Vìllamarina), fu tale, ed il successo così meraviglioso, che Napoleone, quasi adirato, nei primi di quell'anno (per l'attentato Orsini), contro Vittorio Emanuele, che voleva indurre ad inaccettabili misure restrittive nel piccolo Piemonte, finì — per la fiera risposta del Re galantuomo (di cui nella celebre lettera 1° febbraio 1858 di Re Vittorio a Napoleone, tutta minutata da Cavour), e per l'abilità del grande Statista, dal Nigra coadiuvato alla perfezione — per diventare l'alleato del Piemonte nella grande guerra di riscossa nazionale. E fu suprema gioia pel Nigra annunciare al Cavour — da Parigi — che gli ostacoli erano vinti, e concordare il discorso di Re Vittorio Emanuele, collo squillo di tromba del « grido di dolore » !
Venne la guerra del 1859, e vennero le inebrianti vittorie di Solferino e S. Martino, e la inconcepibilmente affrettata pace di Villafranca, voluta da Napoleone III (trascinatovi forse dalle suggestioni dell'Impera-trice lontana) e subita con eroico sforzo dal nostro Re: venne l'accorato risentimento di Camillo Cavour e la nota drammatica scena del 10 luglio 1859 a Monzambano, alla presenza del Sovrano — narrata da Delfino Orsi nel citato suo scritto —; vennero le dimissioni di Cavour, e poi il suo ritorno al potere, la delicata questione della cessione di Nizza e Savoia, e le prime entusiastiche annessioni delle Regioni dell'Italia Centrale.
Sempre il Nostro fu a collaborare col grande Statista Piemontese, nello svolgimento laborioso e difficile di siffatte scabrose questioni e di così importanti avvenimenti !
Ed altri delicati incarichi, per le provincie novellamente annesse, (furono dal Cavour affidati al Nigra, e così poi anche a Napoli, nel periodo delicatissimo — mirabilmente e favorevolmente risolto dal conte di Cavour — delle ire Napoleoniche contro Garibaldi, e dalla leale consegna da parte del Leone di Caprera a Re Vittorio Emanuele della Sicilia e del Napoletano, da Esso fulmineamente conquistati. (V. Carteggio, vol. IV).
Dopo la morte del grande suo Ministro (6 giugno 1861), Costantino Nigra, nominato poi rappresentante ufficiale della novella Italia a Parigi, ebbe ancor là un periodo faticoso e luminoso, e diventò il principale artefice della diplomazia Europea, conducendo le pratiche fortunate dell'alleanza dell'Italia colla Prussia contro l'Austria. Egli, colle sue elette qualità di mondano, di letterato e di artista, mentre era ascoltatissimo dall'Imperatore, cercava dì avvincere pure alla sua azione diplomatica la potenza maliarda dell'Imperatrice. Con essa — scrive e documenta argutamente Emilio Pinchia (vedasi la lettera 16 dicem-bre 1863 del Nigra all'Imperatrice) ei si faceva modestamente premuroso della reputazione gastronomica subalpina (ad esempio, coll'offerta di magnifici tartufi e colla ricetta per cucinarli !') ; ma pure ad Essa — in un coi frivoli complimenti e coi doni — cercava far sentire la voce della Patria nostra, non ancora tutta redenta!
Una sera, nel giugno 1863, nel laghetto di Fontainebleau, accanto alle altre imbarcazioni di vari Paesi, vi era pure una gondola veneziana procurala dal conte Sormani-Moretti, segretario della legazione Italiana a Parigi. L'Imperatrice chiese al gondoliere di cantare una canzone veneziana: ma il gondoliere non ne sapeva. Nigra, che era presente, propose di scriverne una. E scrisse quella famosa « Barcarola » che fu poi messa in musica e venne largamente distribuita dal Comitato segreto per Venezia. Diceva la barcarola, cantata sulla mandola del galante ambasciatore :
Me battezzò dell'Adria
l'irata onda marina,
Me la Fatal Regina,
dei Dogi a te mandò.
Ire, speranze e lacrime
d'un popolo infelice,
o bionda Imperatrice,
innanzi a te porrò...
Il fier leone aligero
d'aspre catene è carco,
la terra di San Marco
calpesta lo slranier...
E così finisce la barcarola
Sovra il suo letto d'alighe
Posa il leone, e aspetta
che il dì della vendetta
lo venga a ridestar...
Donna, se a caso il placido
tuo lago, a quando a quando,
teco verrà solcando
il muto Imperator,
Digli che in riva all'Adria
Povera, ignuda, esangue
Geme Venezia e langue,
Ma è viva... e aspetta ancor!
E' poi troppo noto — perché sia il caso di specialmente ricordarlo qui — l'aiuto personale, coraggiosamente e cavallerescamente dato nel 1870 dal Nigra alla bella e sventurata Imperatrice, perché potesse fuggire viva da Parigi che — in preda alla rivoluzione — abbattute ed incendiate le Tuileries — voleva fra le mani la consorte dell'Imperatore (indubbiamente consigliera e compartecipe della sua politica), quando questi, dopo Sédan, era già prigioniero dei Tedeschi !
Caduto il secondo impero (della cui Corte imperiale il Nostro era stato l'enfant gaté), continuò il Nigra a rimanere a Parigi ancora colla nuova Repubblica: passò poi — rifiutando anche altri importanti incarichi di politica militante — ambasciatore a Pietroburgo, indi a Vienna, dove fu custode vigile ed attento di quella Triplice Alleanza, assai difficile nel suo equilibrio, e che ruinò poi repentinamente allo scoppio dell'ultima grande guerra mondiale!
Anche in questa seconda parte della sua vita diplomatica il Nigra rese segnalati servigi al Paese: nel suo Epistolario, dal trentennio che va da oltre il 1870 all'epoca in cui lasciò l'Ambasciata di Vienna, per ritrarsi a vita privata e al meritato riposo (troncato il 1° luglio 1907 da repentina morte a Rapallo) — epistolario che viene, a quando a quando, in parte alla luce (vedansi le lettere inedite stampate ora nel citato numero della « Nuova Antologia » da Carlo Richelmy) —, si vede quanto fossero desiderati ed ascoltati la sua parola ed il suo consiglio da uomini, come Pasquale Stanislao Mancini, Emilio Visconti-Venosta e Francesco Crispi: e come, sulle direttive politico-diplomatiche del suo Paese — ad esempio nel periodo specialmente triste della politica africana — preciso e severo fosse il suo pensiero ed il suo giudizio. (In una lettera dell'agosto 1896 al Marchese Visconti Venosta egli scriveva infatti: « La cosa è dura per il nostro amor proprio, ma ormai il nostro paese deve persuadersi che quando si adoperano diplomatici come Antonelli, generali come Baratieri, e Ministri come Mocenni, non si possono avere pretese soverchie »).
Certo è però che — senza accogliere sic et simpliciter il pensiero di E. M. De Vogué, quando scrisse nel Figaro (6 luglio 1907), all'epoca di sua morte: « En 1870, la làche de Nigra était accomplie: l'instrument, dont s'était servi l'habile artisan, l'Empire francais, était brisé. Nigra pouvait étre utile encore pour orner et consolider la maison qu'il avait bàtie, mais l'instinct populaire, fait d'une crucile et sagace ingratitude, l'écartait de la direction de cette maison » — all'intensità travolgente della prima parte dell'opera politico-diplomatica del Nigra, succedette per Esso un secondo lungo periodo di raccoglimento.
Fu detto che il suo ciclo era chiuso e oltrepassato: ma sembra ora, invece, a parecchi, che il Nostro, assuefatto ad elevati concetti di dignità, forza e lealtà diplomatica al servizio di un piccolo Stato, ma di un grande Uomo di Stato, non abbia più potuto acclimatarsi alla debole, incerta e fatua politica estera di uno Stato, reso bensì grande pure da Esso, ma governato, per troppo lungo tempo, da assai piccoli uomini, o da solo grandi burocratici, che coprivano la loro debolezza all'estero colla furberia del viver tranquillamente alla giornata, all'interno!
Se oggi Costantino Nigra rialzasse il bel capo, dormiente nell'avello di Villa, ritroverebbe certo se stesso, in un nuovo grande Capo della nuova Italia !
Fu colmato in vita, il Nigra, di onori: Senatore, Collare dell'Annunziata, decorato delle più alte onorificenze italiane e straniere, amico e consigliere devoto di Re Umberto, ospite del quale era ogni anno ai Reali Castelli.
Ei preferì tornare però — dopo lasciata la vita diplomatica militante —, e purtroppo per assai breve volger di anni, alla tranquillità degli studi prediletti (morte, infatti, lo colse mentre correggeva le bozze di un suo studio di filologia), ed amò andar peregrinando, anche in cura della malcerta salute, tra le stazioni climatiche (morì infatti a Rapallo), Roma, il suo bel palazzo di Venezia ed il dolce suo Canavese, la quiete della sua Villa Castelnuovo, dove volle tornare, per il riposo che non ha fine, nella tomba familiare che è diventata meta di pellegrinaggio e di culto per i suoi compaesani e per i canavesani !
III). — a) Specialmente nei suoi studi e nelle ricerche storiche e scientifico-letterarie, Costantino Nigra predilesse ed illustrò il Canavese!
Di detti studi or dirò brevemente, perché si è — per essi — che il Nigra è essenzialmenle nostro, ed illustratore della nostra Terra!
L'erudizione del Nigra, come filologo, linguista e traduttore (preciso ed elegante ad un tempo) dal greco e dal latino, fu grande, profonda ed acuta: degno pronipote del sommo De Rossi, pur fra le fatiche snervanti della diplomazia, trovò tempo e modo di pubblicare opere che lo portarono a fama, anche in questo campo scientifico. Così nel 1896 diede alla luce, con erudita prefazione (in cui si fa pur cenno del dialetto canavesano) il libro « Glossae Hibernicae veteris Codici Taurinensis Lutetiae Parisiorum », illustrando un vecchio e prezioso codice ibernico del secolo IX, conservato nella Biblioteca Nazionale di Torino; mentre già fin da assai prima (dopo il 1850), il Nigra aveva iniziato la pubblicazione — dapprima nella rivista // Cimento, e poi anche in studi a parte, con ampie e dotte note — di alcune sue traduzioni dal greco e dal latino: e così la Chioma di Berenice, l'Inno di Callimaco, i Lavacri di Pallade, ecc.: ed ora — nel citato fascicolo della « Nuova Antologia » — il prof. Spezi ci riporta altri interessanti ed inediti brani di traduzione dell'Odissea, e lettere eruditissime (e pur inedite) del Nostro. Certo è però che — ripeto — precipuamente nel suo e nostro Canavese si moltiplicarono ed approfondirono i suoi studi storici, linguistici e folkloristici (o di costume) — come maggiormente inspirati dall'amore del natio loco —; ed abbiamo così una sua dotta dissertazione Sul Nome d'Ivrea, un'altra Sulle origini e sulle ramificazioni della Casa Marchionale di Ivrea in relazione alla Casa di Savoia: e, per la parte linguistica, un suo Studio sul dialetto di Viverone, parecchi studi sull'aspro dialetto della bella Val Soana, — e soprattutto l'opera sua veramente magistrale Canti popolari del Piemonte, che ei cominciò a pubblicare a brani nel Cimento (1854), poi nel 1858-1862 nella « Rivista Contemporanea »; e infine raccolse in edizione com-pleta, dividendo la raccolta in Canzoni storiche, romanzesche e diverse. Orbene in tutti questi studi dialettali, — nei quali il Nostro non riproduce soltanto la canzone, ma ne analizza il metro, ne paragona il soggetto con i canti di altre nazioni, talvolta riproducendola (in caso di comunanza di fonti) in più lingue e dialetti, e s'addentra a trame (acutamente e con grande erudizione) l'origine storica, — il Canavese fu il campo delle sue più diligenti investigazioni: curioso e desideroso, com'era, di trarre dal dialetto la storia e il costume di nostra gente. Egli andava perciò peregrinando pel Canavese (nelle ore lasciate libere dalle sue cure d'ufficio), e raccogliendo il materiale dalla bocca stessa dei vecchi cantori: ad es. percorse tutta la Val Soana, e del suo astruso dialetto locale formò, per uso suo, una grammatica.
E scrisse, al proposito di queste canzoni popolari: «o m'illudono l'amore grande che ho delle cose nostre, e l'orecchio da lunga mano assuefatto a queste rozze e commoventi armonie, — o la poesia popolare del Piemonte (e in specie del Canavese) merita di esser raccolta con cura e studiata ».
b) E non solo i dialetti, ma i costumi del vecchio Piemonte, e specialmente del suo Canavese — e con specialissimo filiale riguardo alla sua Valle di Castelnuovo col bel paese di Villa (nel cui castello, ora elegantemente rimodernato, egli nacque) e con Cintano e Sale (i tre Comuni - allora - della Valle, così bene da Esso descritti, quasi a prefazione del suo Natale) — II Nigra diligentemente studiò e pubblicò così, coll'affettuosa e dotta collaborazione di Delfino Orsi, nel 1894 II Natale in Canavese, nel 1895 La Passione in Canavese e nel 1896 II Giudizio Universale nel Canavese, con indagini storico-filologiche interessantissime e colla riproduzione del testo dei Manoscritti, contenenti le parole delle rappresentazioni di detti drammi, che si tenevano in questi suoi paesi della Val di Castelnuovo, e specialmente nella sua « Villa » natia.
Non posso trattenermi — come saggio del contenuto di queste pubblicazioni (così folkloristicamente canavesane) — dal riportare qui la magistrale descrizione della recita del Natale fatta da Costantino Nigra nel primo di questi bei volumetti:
« II Natale » — son sue parole — « si recita sempre in chiesa durante la messa di mezzanotte, fra il 24 e il 25 dicembre. La descrizione qui fatta si riferisce alla rappresentazione del 1838 in Villa Castelnuovo, nella quale sostenni, fanciullo, la parte di uno degli angeli minori. In un canto della Chiesa Parrocchiale, presso l'altare laterale, a destra di chi entra, era stata costruita la capanna. Dentro alla capanna, visibile, era stato posto il Bambino, fatto di cartapesta, cerata e colorata. Il reggente della Parrocchia diceva la Messa di mezzanotte. Dopo il Credo, due fanciulli, vestiti da Angelo (uno dei quali « ero io), vennero, con un cero in mano, a mettersi alla balaustra, uno a destra, uno a sinistra. In quel momento si udì picchiare alla porta maggiore della chiesa. Il celebrante salì sul pulpito, dove rimase seduto fino alla fine della recita. I due angeli dissero pochi versi a guisa di prologo, che erano una parafrasi del Gloria in excelsis Deo et in terra pax. Si picchiò di nuovo alla porta. I due angeli andarono allora ad aprire. Undici pastori, con larghi cappelli bianchi e mantelli formali da coperte bianche di lana, con lunghi bastoni e colle rispettive offerte sotto il braccio, entrarono e si fermarono in mezzo alla navata della chiesa. Essi si erano radunati in casa di mio padre, e di là si erano recali alla vicina chiesa con fiaccole e al suono del piffero. Giunti in mezzo della Chiesa, Montano, uno dei pastori, cominciò la sua parlata: Perdona, o Melibeo, io non t'intendo ecc. Quando Melibeo pronunciò le parole : Mirate il clivo, il monte, il fiumicello, il fonte, come del vago april..., l'angelo maggiore uscì dalla sacrestia con un gran cero in mano e venne incontro ai pastori. Dopo aver loro annunziato la nascita del Salvatore, li condusse alla capanna, dinanzi alla quale, rispondendo alle loro osservazioni e all'espressione della loro pietà e meraviglia, spiegò la moralità del Natale di Gesù in così umile luogo, e ne predisse la passione, come sta scritto nel testo. Per aiutare la sua memoria, l'angelo maggiore aveva scritto la sua parte tutt'intorno al cero.....
... Fu già descritto il vestimento dei pastori. Quello degli angeli consisteva in una tunica bianca con ali al dorso. Io ero stato vestito con cura dalla mia buona mamma, con una bella tunica candida, cinta d'un nastro, con corone di rose sui capelli, e con due magnifiche ali di penne di pavone alle spalle...
Alla recita assisteva tutta la popolazione valida della parrocchia. Nella notte oscura, per i sentieri alpestri, coperti di neve, gli abitanti dei più lontani casali eran venuti in lunghe processioni... Lo spettacolo era grandioso e commovente... ».
Basti il qui detto sugli Studi dei costumi e delle tradizioni del Canavese, compiuti dal Nigra.
c) Ma si è l'anima poetica del suo Canavese che egli pure sentiva vibrare in sé, e che gli dettò versi squisiti.
Costantino Nigra fu vero Poeta, degno (per me) di stare accanto ai nostri maggiori e migliori Poeti Canavesani.
Ed Emilio Pinchia — sempre nel suo Itinerario Canavesano — bene fece a porre il Nigra accanto ai Giacosa, ai Gozzano, ai Cena, oltre agli ottimi dialettali Giuseppe Riva, Fulberto Alarni ed al ruegliese Pietro Corzet Vignot; ed a riprodurre brani bellissimi dei suoi Idillii dai quali spira il fremito gentile e la luminosa e varia bellezza della nostra terra.
Ma dove la descrizione del Canavese (nella storia e nelle cose) assume, nel verso di Costantino Nigra, mirabile e degna forza di espressione e di rilievo, si è nella nota (già ricordata) poesia per le nozze di Alessandrina d'Azeglio (1852) che, se valse al Nostro la simpatia di Massimo d'Azeglio e il benevolo augurio di Alessandro Manzoni, per noi Canavesani è sommamente suasiva e suggestiva. Ad Alessandrina d'Azeglio, che va sposa a Firenze ( ad altre terre il fato or ti concede: e te chiama alle sue splendide mura, la di fiori altrice, bella sposa dell'Arno...), ricorda il Poeta:
Però la tèrra dei tuoi padri antica
Non obliar, benché lontana. A Lei,
Se mai ti fu di pure aure cortese,
E di bei Soli, e di stellate notti,
Col memore pensier spesso ritorna.
Fra l'Alpi e la maggior Dora, e la sponda
Del superbo per molte acque Eridano,
Ove, mugghiando, le dorale arene
Disdegnoso di ponti Orco rivolve,
Bellissima fra quante il sol riscalda,
E' una Terra di pampini e di messi
E di greggi feconda. Ivi leggiadre
Le donne, e amico ai pellegrini il tetto,
E la coppa ospitale, ed esultanti
Di vendemmie, di cacce e di canzoni,
Le colline e le valli. Ivi severa
Di studi ed armi disciplina.
Caro L'onor più che la vita. Intemerata
Lealtà. Fiero, indomito, operoso
Amor di patria, e nei securi petti,
Come l'Alpe natia, salda costanza.
A me fu Patria, e Canavese ha nome
La superba contrada. In su la riva
D'un queto lago, di ridenti ville
Coronato e di selve, antiquo s'alza
Un castello, di mura ardue e di fosse
Un dì cerchiato; a tergo alta gli sorge
Folta d'ombre la Serra, e di lontano
Le sue merlate torri sospinge
La domatrice di cavalli Ivrea.
Qui giovinetta, delle grazie alunna,
Ebber la culla i padri tuoi. Sovente
Questa terra li vide aspri d'acciaro
Seguir la savoiarda Aquila, scudo,
Spada e vessil d'Italia nostra! A lei,
Se mai ti fu di pure aure cortese,
E di bei soli e di stellate notti,
Col memore pensier spesso ritorna.
E non è certo irriverenza verso il nostro grande Pin Giacosa supporre che questi versi del Nigra non gli siano stati forse ignoti, quando nel Conte Rosso (1880) descrisse pure, con accenti e versi felicissimi, il Canavese nostro.
Oh veramente questo
Bel Canavese è una terra d'incanti!
Estrema balza dell'Alpi, preludia
Con degni accordi al magico concento
Dell'Itale bellezze, e non ha voce
Che non sia di tripudio e di speranza!
Qui il sole innamorato indugia in lunghi
Crepuscoli l'occaso, e impaziente,
Quand'è ancor negro il pian, le immacolate
Cime col mattinal bacio saluta...
Vo' far di questa terra un Paradiso
Ove l'ordin civile e la nativa
Beltà concordi fioriscano!
Ho voluto avvicinare queste due mirabili descrizioni poetiche di nostra terra, perché le ritengo fra le più belle e suggestive: e certo, anche nella luce della poesia, Costantino Nigra può ben stare vicino a Giuseppe Giacosa!
Maurizio Dumoulin infatti, nel «Figaro» del 6 luglio 1907 — appena morto il Nostro scrisse a suo riguardo: « On dit couramment que les poetes, gens d'esprit peu pratique, n'arrivent a rien dans la vie: l'exemple de celui qui vieni de mourir, Comte, Senateur du Royaume d'Italie, grand Collier de l'ordre de l'Annoncada, (mais qui, pour nous, est reste le chevalier Nigra, titré sous lequel le connut le Tout-Paris du second Empire), est la preuve du contraire».
Aggiunge il Dumoulin — traendolo da un'espressione della contessa Di Circourt, l'amica di Camillo di Cavour, — che il Nostro univa alla luce dell'Arte e della Poesia, la beltà d'Alcibiade e tutta la prudenza d'Ulisse...
Nigra fu prima poeta e letterato, poi storico e filologo e — in alto grado — politico e diplomatico : per noi, fu pura gloria Canavesana, e figlio innamorato della sua terra. Le sue poesie che — lo si è visto - vibrano di tanta luce, passione e bellezza di forma, furono raccolte da Alessandro d'Ancona in un bel volume già citato (Costantino Nigra, Poesie originali e tradotte, Firenze 1914).
Un postumo, ma sintomatico omaggio del suo Canavese e del Governo (che ha perciò felicemente interpretato il pensiero dei conterranei) — quello si è, che la valle di Castelnuovo, dal Nostro descritta e celebrata nei suoi tre Comuni di Villa, Cintano e Sale, è stata di recente riunita in un solo, più grande Comune, con tradizioni e finalità unissone: e quest'ultimo Comune or si chiama — in omaggio al suo figlio più grande ed illustre — Castelnuovo-Nigra.
Si è là — nella sua ridente valle — che Costantino Nigra riposa: e la sua «Villa» che lo adorava, vi ha eretto un bronzeo ricordo e, nel cuore di tutti un monumento « aere perennius », più duraturo del bronzo !
Numerosi ricordi, anche preziosi, doni, documenti, oggetti di valor storico ingente, — in sintesi — molto di quanto un diplomatico della levatura del Nostro può raccogliere nella sua lunga carriera, è pur stato adunato nel bel Castello di Villa, e amorosamente custodito prima dal figlio Conte Lionello — immaturamente rapito alla vita, e autore pur esso di pregiate poesie, pubblicate in bel volume (« Poesie postume » di Lionello Nigra) — e poi dalla vedova Contessa Teresina Nigra Martin Perolin, che degnamente seppe mantenere e proseguire — fino alla sua morte — le nobili tradizioni di Casa Nigra.
IV). — Una cosa però non si è più trovata: e cioè il manoscritto dei «Ricordi diplomatici », a cui il Nostro accudì, con lavoro intenso e con materiale di ricordi, memorie e documenti prodigioso, per anni ed anni, fino a permettere al suo fido collaboratore, conte Delfino Orsi, di annunziare sulla Gazzetta del Popolo, nel 1903, che essi eran condotti a termine: ciò che voleva dire che dovevano già essere stati da esso riveduti e corretti col più rigoroso scrupolo.
Dai pochi Saggi pubblicati (di detti Ricordi), e da quelli letti agli amici (traendo egli a quando a quando una parte del copioso manoscritto da un suo prezioso forzierino ad hoc) si può comprendere la gran-dissima importanza dell'opera. Detti Ricordi dovranno venir fuori dopo la sua morte. Orbene il Nigra morì nel 1907: siamo a 27 anni dopo, e non è venuto fuori né il manoscritto delle memorie, né il suo testamento.
Delfino Orsi ha ognor negato la possibilità della distruzione, che altri invece preferiscono di pensare. «E' assurdo il supporre» — scrive il conte Orsi — «che un uomo tanto meticolosamente ordinato in tutte le sue cose, preparato da tempo alla morte, non abbia messo in carta i suoi pensieri, e dichiarato per iscritto le sue volontà, sia circa la destinazione a scopi sociali di qualche parte delle sue cospicue sostanze, sia circa la conservazione o il passaggio ad archivi dei molti e molti importanti documenti che, — oltre i manoscritti dei ricordi — erano nei suoi forzieri. Non voglio avventurarmi in supposizioni: ma non si può a meno di intravvedere un nesso tra queste due lacune; quella dei Ricordi e quella del testamento. E naturalmente non concludo: ma resto ancora nella speranza che, com'è stata misteriosa la sparizione di uno degli scritti più organici, più schietti e perciò più preziosi, della Storia del nostro Risorgimento, così, magari per un impensato e misterioso dono della sorte, ci si annunzi un giorno che è stato ritrovato il Manoscritto dei Ri-cordi diplomatici di Costantino Nigra ». (V. DELFINO ORSI, II Mistero dei « Ricordi Diplomatici » di Costantino Nigra in Nuova Antologia, n. 16, nov. 1928, cit.).
Questo è pur il voto nostro e di ogni Italiano! (Nota 2)
V). — Come è eziandio nei voti nostri, o nel più vivo desiderio e nella più fervida nostra speranza, (che potremmo già conclamare come radiosa realtà) che il Centenario della nascita di Costantino Nigra — dell'uomo insigne, che illustrò il Canavese colla poesia e colle lettere, e servì l'Italia, nel periodo di sua vita più periglioso, con intelletto ed acume altissimi, e l'uno e l'altra onorò ed esaltò coll'opera sua veramente memorabile — non sia da qualche po' trascorso senza aver tratto con sé i migliori auspici !
Costantino Nigra combattè, come bersagliere, per l'indipendenza del suo Paese, e collaborò poi, in intima ed incessante comunione di fede e di opere, con un grande Uomo di Stato, che seppe unificare l'Italia con una meravigliosa politica all'estero ed all'interno! Più tardi, di fronte ad una politica successiva, debole ed incerta, così all'esterno che all'interno, egli si appartò, e quasi sdegnoso si ritrasse.
In oggi — già accennai — Costantino Nigra ritroverebbe alla testa del paese nostro Chi combattè, con esso, tra i bersaglieri, per la piena redenzione della Patria: e Chi essenzialmente ritorna a svolgere una politica estera fatta di lealtà, dignità, ma pure di forza come quella del grande Statista piemontese.
Certo — Nigra redivivo — (lo sentiamo tutti) ritroverebbe il suo Uomo !
Voglia il Suo spirito elettissimo ciò vedere dall'al di là misterioso, e benedire ancora una volta all'Italia nostra, divina e possente, e «novella assunta fra le genti»!

il rifugio intestato a Carlo Toesca nel Comune di Bussoleno (TO)
COMMEMORAZIONE DI COSTANTINO NIGRA - Francesco D'Ovidio -filologo e critico letterario - Articolo pubblicato sulla rivista Archivio Glottologico Italiano - Vol XVII° - p.1 - Torino - Loescher - 1910
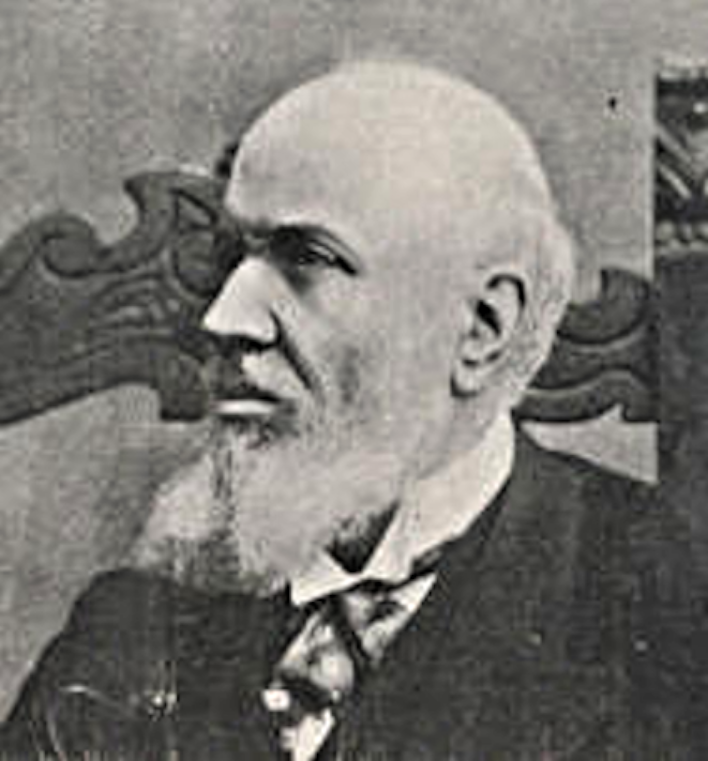
La morte di Costantino Nigra, avvenuta a Rapallo nella notte del 1°" luglio 1907, arrecò gran dolore a tutti, ma niuna sorpresa a quanti l'avevano visto negli ultimi anni invecchiare rapidamente e negli ultimi mesi star sempre con un piede nella Inumi. Non aveva ben toccato gli ottant'anni, e per più rispetti pareva atto a trascorrerne parecchi altri ancora, ma un'infermità cardiaca e l'indurimento delle arterie gli minavano l'esistenza. In una notte a mezzo il dicembre del 1906 il suo cuore, quel uni cuore, aveva quasi cessato di battere, e solo gli sforzi disperati dei famigliari e dei medici riuscirono a richiamarlo in vita. Pur era tanta la gagliardia della sua fibra, che, recatomi ni ansiosamente a vedere s'egli avesse superata l'altra notte, lo trovai così ben vivo da venirmi incontro, con volto ilare, col mio solito fare amabile, amichevole, cavalleresco: e da intrattenermi per più d'un'ora leggendomi una celebre poesia d'un celebratissimo poeta, chiosandola con singolare vivacità. Sennonché pochi giorni dopo, durante le feste natalizie, quando la di partita sembra più amara pel contrasto tra il fato d'un uomo o la, comune gaiezza, ei si trovò di nuovo sospinto a un passo dalla sua fine, e tutta Italia allora lo seppe e ne trepidò. Che so ancora la solerzia altrui e l'ingenita vigoria sua valsero per sei mesi a soffermarlo, com'ei diceva, nell'anticamera della tomba, non poterono più restituirgli l'umore antico. Lucido restò sempre il suo intelletto, lesta e fida la memoria, elegante la loquela, aperto il cuore ai più gentili affetti; ma ei sentiva come il vivere fosse per lui niente più che un arduo problema da risolvere ad ogni ora, ad ogni momento. " Colei che per certo futura portiam sempre vivendo innanzi all'alma „, ei se la ve-deva assisa al fianco, pronta a ghermirlo ; e di rado al posto di quel tetro spettro si collocava la larva della speranza. Da ultimo, staccatosi da quella Roma, che non doveva più rivedere; navigando pel mar Tirreno, fulgido de' suoi più bei colori estivi, verso la ridente spiaggia ligure; parlando con tenerezza patriottica alla ciurma della regia nave che lo aveva portato a quella spiaggia; posando sopra essa il piede, — si sentì come rinascere, gli parve di aver ricuperato forze che credeva irreparabilmente perdute. Ma era come l'estremo guizzo della grande fiamma che si spegneva. Però, se fu malinconico il tramonto della sua vita, se l'esordio n'era stato ben modesto, la vita, stessa fu fortunata assai.
Nato a Villa Castelnuovo, nel circondario d'Ivrea, l'11 giugno 1828, a vent'anni s'arruolò nell'esercito durante la guerra d'indipendenza; e dopo la guerra lasciate le armi, si laureò subito in legge, e, per concorso, fu addetto al Ministero degli Esteri. Divenuto segretario particolare del D'A/egli o e poi del Cavour, l'ingegno vivo, il carattere saldo, il senno precoce, il garbo dell'uomo di lettere, la singolare bellezza dell'aspetto così maschio eppur cosi, leggiadro, richiamarono l'attenzione di quei sommi ; il secondo dei quali non dubitò di elevarlo in pochi anni a uffici sempre più alti. Il Cavour scrisse una volta come il Nigra aveva più ingegno di lui. Fu una di quelle esagerazioni magnanime a cui l'uomo di genio trascorre, ma per un certo rispetto non era un'esagerazione: il Nigra aveva anche nei momenti più dolorosi una calma e una padronanza di sé, che il bollente ministro gli avrà qualche volta invidiata. Certo, chi legge le note diplomatiche, i dispacci, le lettere confidenziali, che il Nigra inviava da Parigi, vi scopre immancabile rettitudine di giudizio, sobrietà perfetta di stile, intuizione pronta, animo risoluto, tatto squisito, conoscenza profonda degli uomini e delle cose, serenità senza freddezza, zelo senza smanie: tutto quello insomma che rende prezioso un informatore e un consigliere e ne fa quasi uno strumento di precisione, o una bussola che in qualsivoglia tempesta ti addita il polo. Neppur la febbre delle speranze e delle angosce patriottiche valeva a farlo trascendere in eccessi di ottimismo o di pessimismo; come d'altra parte neppure la sua grande intimità con quel paese, con quella capitale, con quella corte, dov'egli era tanto festeggiato e prediletto, bastava a fargli mai guardare le cose da un punto di vista che non fosse strettamente italiano. Il pericolo degli ambasciatori assai bene accetti al paese presso cui sono accreditati, è che, se dall'un canto col favore che vi godono riescono a richiamare sulla loro patria condiscendenze straniere che altrimenti non si avrebbero, dall'altro però, col divenir troppo domestici al paese in cui vivono, risicano di veder qualche volta più con gli occhi del sovrano o del governo straniero che non con gli occhi propri o della nazione che li ha inviati. Quel pericolo il Nigra lo seppe schivare, che restò sempre autonomo, sempre indipendente da passioni o ubbìe francesi: non ingrato alla benevolenza francese e imperiale verso l'Italia e verso la persona sua, ma non mai accecato dalla gratitudine. Un gran personaggio di Francia, commemorandolo, disse ch'egli era compiacemente arrendevole negli accessori e inespugnabile nella sostanza, ritroso a promettere quel che non fosse sicuro di poter mantenere e fermissimo nel mantenere quel che aveva promesso. Fu detto ch'egli fosse un affascinatore, ed è notevole a questo proposito l'affetto vivo che l'imperatore Francesco Giuseppe ebbe negli ultimi anni pel nostro rappresentante, che pur aveva cominciata la sua carriera di patriota col buscarsi nella battaglia di Rivoli, da caporale dei bersaglieri, una palla austriaca nel braccio destro. Ma di quel suo fascino nessuno si dolse mai, poiché nessuno egli ingannò; anzi una delle più seducenti sue attrattive era appunto la lealtà incrollabile. L'Italia aspettava ora di legger alla fine tutto il racconto dei cinquant'anni della sua vita diplomatica, nel quale si sarebbero rinnovati tanti ricordi di giorni ansiosi, di audacie sapienti, di sforzi eroici di prudenza e pazienza. Delle sue Memorie ei parlava come d'un libro già compiuto e limato, qualche tratto ne aveva già donato al pubblico, di altri aveva concesso che qualche amico facesse uso, o gliene aveva egli medesimo dato lettura; o lasciava solo intendere di volere o ritardata o postuma la pubblicazione del libro per ragioni di convenienza cortese. Ma nel settembre del 1906, preso da non so quale sconforto, mi accennò il proposito di darlo invece alle fiamme; ed io naturalmente mi adoperai a rimuovernelo ; e vogliamo ancora sperare (anzi un'attestazione dell'Artom relativa agli ultimi mesi relativa alla vita del Nigra ce ne dà quasi la certezza) ch'egli non sia stato così crudele con l'opera sua. La quale aveva fra gli altri questo gran pregio, che d'ogni cosa arrecava possibilmente le prove autentiche, i documenti ineluttabili, sì da riuscire una storia prammatica del nostro risorgimento e di altri grandi fatti europei, assai più che una rievocazione di reminiscenze e impressioni personali.
Ma, oltre il resto, oltre le tante ragioni di gratitudine che abbiamo verso il Nigra come cittadini, una ve n'è che più ci tocca come cittadini e come uomini di studio, la quale più vuol essere propriamente richiamata qui. A lui dobbiamo se anche l'Italia può vantarsi d'essere stata alcuna volta rappresentata da un ambasciatore della specie dei Niebuhr e dei Bunsen: di uomini cioè che all'abilità diplomatica unirono l'abilità o la fama di dotti, rappresentando del proprio paese non solo la potenza e la fortuna ma la sapienza e la scienza, non solo il valore pratico ma il valore ideale. E dico di dotti veri e propri, non di dilettanti più o meno imbevuti di dottrina o d'arte, alle cui velleità intellettuali si applaude sol perché sono un di più, e perché si considera il bene che alla schietta arte e alla seria dottrina può pur derivare dai gusti dilettanteschi di un personaggio mondano.
No, il Nigra è stato, oltreché un poeta valente, un filologo diligentissimo e un glottologo davvero. Se si fosse consacrato unicamente agli studi, la suppellettile dei suoi volumi o monografie sarebbe pur bastata ad assicurargli un posto cospicuo fra gli studiosi italiani e fra i dotti d'Europa; tanta è la molteplicità della dottrina, la precisione, l'accuratezza, l'acume, la curiosità indagatrice, la limpidezza di pensiero, che brilla nelle sue pagine. Certo, nella pienezza stessa delle informazioni, come nella pazienza indefinita delle ricerche, ed in altre virtù, si scorge manifestamente lo scrittore vissuto in alte sfere, a cui tutti i mezzi di studio erano accessibili, e che non lavorava sotto il pungolo delle necessità professionali; ma fu semplice dono del suo spirito quello scrupolo di esattezza e di chiarezza, e altri pregi, diciamo così, didattici, che senza dubbio avrebbero all'occorrenza fatto di lui un cattedratico di prima riga. La celebratissima raccolta dei Canti popolari del Piemonte è un modello del genere, un monumento imperituro. Tra letterario o filologico, tra adorno e severo, è il volume sulla Chioma di Berenice, ov' è ripubblicato criticamente il testo latino, e tradotto bellamente, e v'è discussa con molta finezza la versione e il commento del Foscolo; come un ottimo proèmio vi oltrepassa anche i limiti dell'unico carme, anzi per più rispetti abbraccia tutta la materia catulliana. La metodica esposizione del Dialetto di Valsoana, che trent'anni fa arricchiva uno dei primi volumi dell'Archivio, conformandosi agli schemi austeri di questo, è, come disse il Rajna, " testimonianza insigne d'una coscenziosità, docilità, tenacia scientifica, che sarebbero degne di lode in chicchessia, e che in un uomo posto in così alto grado e occupato in cosi gravi affari sono addirittura mirabili „.
Il Nigra, che negli anni giovanili, a Torino, tra il primo fervore degli studi sanscriti, vicino al Gorresio e al Flechia, aveva amoreggiato ei pure col sanscrito e con la linguistica comparativa, nel decennio posteriore al 1870 s'era volto agli studi celtologici, di cui l' Italia era tuttora digiuna, salvo qualche bell'accenno del Flechia.
Un po' l'esempio di quest'ultimo e la generale astinenza degli altri dotti italiani, un po' il trovarsi egli ospite della più celtica fra le nazioni neolatine, un po' il concetto ch'ei s'era formato della ripartizione e propagazione dei canti popolari in Italia e negli altri paesi romanzi, — dal qual concetto, come ha rilevato il Rajna, era invitato a fermar lo sguardo sul substrato celtico delle regioni cisalpine, transalpine e transpirenaiche, — lo indussero a divenir celtologo valente: quale si mostrò nel 1869 colle Glossae hibernicae reteres codicis taurinense, e poi con gli articoli nella Revue celtique, e colle Reliquie celtiche del 1872. Di lì s'accingeva a passare alle Glosse Ibernicae del manoscritto ambrosiano; ma l'Ascoli volle attendervi lui, e il Nigra, che sapeva trattar con le grandi potenze anche d'ordine intellettuale, vi rinunziò di buon grado. E per la trafila della ricordata monografia sul dialetto di Valsoana, passò più di proposito agli studi neolatini e dialettologici, ai quali del resto e l'Ascoli stesso e il Flechia e gli altri glottologi italiani si venivano sempre più stringendo. Accumulò tesori di ricerche etimologiche, e di recente li smaltì nell'Archivio Glottologico, nella Romania, nella Zeitschrift fur romanische Philologie. Fu una sequela di pagine ove molto materiale di studio è adunato, molte verità sono acutamente scoperte ed efficacemente dimostrate, molte ipotesi sottili e ingegnose vengono messe in campo. Talvolta son troppo sottili o ingegnose, e, mentre applicano a rigore le leggi della fonologia, non riescono persuasive, non han l'aria della verosimiglianza; tal altra volta le leggi stesse della fonologia vi son intese in modo non abbastanza rigido, con una libertà che ricorda più antiche fasi della scienza glottologica. Sennonché un carattere notevole hanno le ricerche del Nigra quando son applicate a vocaboli indicanti oggetti materiali, piante, animali, cose di caccia, industrie e costumi villerecci: a base della speculazione idiomatica v'è la cognizione realistica delle cose; una cognizione esatta, precisa, minuta, della quale i più degli etimologi sentono in sé il bisogno senza poterlo appagare. Egli è che il Nigra, qual uomo di mondo ed esperto di tanti paesi, aveva avuta l'opportunità di bene apprender le cose innanzi di scrutarne i nomi; e, vissuto nella prima gioventù tra i monti e i campi del suo Canavese, aggirandosi tra gli umili, umile in parte ancora egli stesso, come aveva raccolto con amore l'eco dei canti del popolo, così ne aveva osservato i costumi o i mestieri, e s'era affiatato direttamente con la natura. Il gran signore ch'egli era divenuto, e il buon borghese di campagna ch'egli era stato, cospiravano ora a illustrargli i nomi delle cose. Un altro studio lo attirò da ultimo, riconducendolo all'amatissima regione nativa. Scorse con infinita pazienza gli Statuti Latini del vecchio Piemonte, per rintracciarvi i riverberi latineggianti di voci dialettali, ossia il primo apparir di queste sotto le simulate spoglie della bassa latinità. Questo lavoro interessantissimo lo donò agli Atti del congresso storico subalpino, ed è già tutto in stampa: speriamo venga presto a luce. Il Monaci ne corresse con lui le prime bozze; come con pia sollecitudine riordinerà le altre carte scientifiche lasciate dal Nigra.
Ultimamente egli s'era volto con zelo e affetto sempre più intenso agli studi, e pareva cercare in questi la ragione del continuar a vivere e quasi una seconda gioventù. Dopo aver tanto veduto e operato, dopo un così lungo per quanto splendido esilio dalla patria, vagheggiava di trovarvi un lieto e non ozioso riposo. Il Sovrano presso cui
rappresentava l'Italia non si sapeva rassegnare a vederlo partire, il Sovrano d'Italia non si sapeva rassegnare a lasciarlo tornare; ed egli s'arrendeva a così alti voleri e a così alti doveri, ma in cuor suo non bramava che il ritorno alla patria: il ritorno, se non forse " a così riposato e bello viver di cittadini „, certo " a così dolce ostello „.
Una parte della degnamente accumulata ricchezza aveva spesa nell'acquistare una casa a Roma ed una a Venezia. Tra queste due città anelava di poter venire a dividere gli anni suoi estremi.
Roma e Venezia! Quanta poesia, e quanta storia, v'era in fondo a questa predilezione! Predilezione quasi simbolica: come s'egli avesse voluto prender ben bene possesso delle due città tanto desiderate ne' suoi anni giovanili. Roma e Venezia, il sospiro del patriota e del diplomatico, erano ora il sospiro dello stanco vecchio, avido di requie, d'un pacato rifugio dopo una vita fulgidamente avventurosa. Ma in ciò la sorte fu a lui e a noi crudele: poco più che due anni lasciò a lui godere la patria finalmente ricuperata, e a noi la gioia di veder tra noi aggirarsi il reduce glorioso, l'alunno di Camillo Cavour, il vivente simulacro dell'età eroica, che par tanto lontana, della nuova Italia!
COMMEMORAZIONE NIGRA DI CARLO TRABUCCO sindaco di Castellamonte

- 15 febbraio 1968 - Conferenza alla Scuola di Applicazione dell'Esercito a Torino
COSTANTINO NIGRA - Fuori della Leggenda (e del Romanzo)
Eccellenze, Signori Ufficiali, Autorità, Signore e Signori,
Gli uomini sopravvivono nel tempo per le loro imprese memorande; fra queste, per lo più, non figurano le azioni galanti. Tuttavia qualche eccezione esiste; Casanova può essere considerato un esemplare di questa categoria. L'avventuriero veneziano si raccomanda ai posteri - una raccomandazione poco edificante ... - per le sue imprese amatorie e truffaldine. Casanova ebbe ingegno versatile, fu a volta a volta poeta, matematico, traduttore di Omero, storiografo e critico. E, aggiungiamo, per colorire meglio il quadro, baro e spia.
Questo può essere il caso limite di un personaggio che passa alla storia prevalentemente per le imprese amorose; si deve tuttavia riconoscere che nella vita degli uomini importanti, anche dei politici, l'amore o l'avventura amorosa, hanno avuto la loro parte.
La mia introduzione ha lo scopo di gettare un tenue sprazzo di luce, dirò, in via preventiva, sul tema da me scelto: "Costantino Nigra fuori della leggenda (e del romanzo)"; aggiungo: romanzo sentimentale.
Osservo che colui il quale fu luce e guida per Costantino Nigra - alludo al Cavour - ebbe egli pure le sue vicende amatorie, ma le donne del Conte non ebbero alcuna incidenza sulle vicende politiche di cui egli fu protagonista.
Cavour non ebbe una vita familiare felice e serena. Le donne furono un .... ingrediente sentimentale e complementare della sua dinamica attività ma non ebbero peso determinante nelle imprese politiche a cui lo Statista pose mano. Così l'azione della Contessa di Castiglione che si dice Cavour avesse cacciato tra i piedi di Napoleone III come pedina di un suo gioco diplomatico, non ha dato risultati apprezzabili.
Altrettanto si potrebbe affermare dell'allievo Costantino Nigra -parecchie donne sulla sua strada ma nessuna Ninfa Egeria - se uno scrittore, il mio conterraneo Salvator Gotta, non avesse colorito una pagina della vita del diplomatico canavesano a tal segno da far sorgere un intrigo, che anche a giudizio di persone assai vicine alla famiglia Nigra, non ha mai preso corpo. Cosicché, dopo il romanzo "ottocento" , la Televisione adiuvante, è nato un personaggio politico che lavorò per le fortune d'Italia anche attraverso un'alcova imperiale ....
Vediamo da vicino l'uomo della . . . leggenda e inquadriamolo in una cornice storica che gli fa molto onore, se si pensa che egli è venuto alla ribalta della politica europea provenendo non - come in uso allora- da un ceppo nobiliare, ma da una modesta famiglia della piccola borghesia abitante in Canavese a Villa Castelnuovo (oggi Castelnuovo Nigra), a poco più di quaranta chilometri da Torino.
Egli nasce nel 1828: è chiusa la parentesi napoleonica a cui il padre aveva preso parte quale medico dell'esercito (la qualifica esatta è "cerusico" che deriva dal francese "chirurgien" ) ed è chiusa la parentesi dei moti del '21, avvenuti prima della nascita di Costantino. Ma quando, vinta una borsa di studio del Collegio delle Province viene a diciassette anni a Torino, nella capitale tira aria di carboneria e di congiure. E se non risulta abbia preso parte a cospirazioni, risulta che nel 1848 a vent'anni, si arruola volontario nella terza compagnia dei bersaglieri composta esclusivamente di studenti; combatte a Peschiera, S. Lucia, Calmasino, Coito, Rivoli dove il 22 luglio 1848 riporta una brutta ferita allo avambraccio destro. Durante la convalescenza il Nigra si addestra a scrivere con la sinistra e vi riesce così egregiamente che userà da allora in poi, indifferentemente, l'una o l'altra mano.
L'anno seguente, il 1849, conclude gli studi di giurisprudenza; la signorina Maria Barello, laureatasi recentemente con una tesi sul diplomatico canavesano, è riuscita a reperire e a far fotografare la pagina del registro universitario che contiene il verbale della seduta del 12 giugno 1849 dalla quale risulta che lo studente Costantino Nigra ottenne quarantun punti su cinquanta ossia una media di poco superiore all'otto.
Conseguita la laurea pensa a campare . . . Approfitta del primo, concorso bandito dal Governo, vi partecipa e nel 1851 entra come volontario, senza stipendio, al Ministero degli Esteri.
Il giovanotto, serio e volitivo, riesce ad emergere e ad accattivarsi la simpatia del D'Azeglio, allora Presidente del Consiglio. Un episodio ci dice in quale conto il superiore tenesse il subalterno . . . senza stipendio. Si celebrano a Lesa, sul Lago Maggiore, le nozze di Alessandrina D'Azeglio con il Marchese Matteo Ricci. D'Azeglio che avendo sposato Giulia, la figlia del Manzoni, ne era genero, portò con sé al matrimonio della figlia il giovane segretario il quale aveva scritto una poesia in onore della sposa. Nell'epitalamio vi è un cenno con il quale il giovane poeta si rivolge al Manzoni :
".......la persona veneranda del maggior vostro sacerdote.
O sommo cantor d'Adelchi, o pio Manzoni, a Lei
sangue del sangue tuo, candidi giorni
prega e gioie feconde e degna schiatta
del tuo nome immortal. Giunge più grata
al ciel la prece che il tuo labbro innalza".
Reso omaggio allo scrittore, Nigra presenta la terra della giovane Alessandrina:- "Fra l'Alpi e la maggior Dora, e la sponda
del superbo per molte acque Eridàno,
ove, mugghiando, le dorate arene
disdegnoso di ponti Orco rivolve,
bellissima fra quante il sol riscalda
è una terra, di pampini e di messi
e di greggi feconda. Ivi leggiadre
le donne, amico ai pellegrini il tetto,
e la coppa ospitale, ed esultanti
di vendemmie, di caccie e di canzoni
le colline e le valli......"
L'avvio, come si vede, attinge a una tavolozza pittorica che delinea la terra canavesana forse meglio di quanto non avrebbe saputo fare il D'Azeglio con il suo pennello. Nigra continua con il ritmo dell'endecasillabo incisivo e ... solenne
"A me fu patria, e Canavese ha nome,
la superba contrada. In su la riva
d'un quieto lago, di ridenti ville
coronato e di selve, antiquo s'alza
un castello, di mura ardue e di fosse
un dì cerchiato: a tergo alta gli sorge
folta d'ombre la Serra e di lontano
le sue merlate al ciel torri sospinge
la domatrice di cavalli Ivrea.
Qui, giovinetta delle Grazie alunna,
ebber la culla i padri tuoi".
In una lettera all'avv. Antonio Talentino di Castellamonte, in data 9 ottobre, si legge che il poeta non è contento dei versi, perciò non li aveva inviati all'amico. Tuttavia annota: "Essi caddero sotto gli occhi di Manzoni e il buon vecchio fu così mite nel suo giudizio da lodarmeli".
E' pressapoco di quel tempo l'Ode al mio cavallo che ha un andamento bersaglieresco.
"Alta la testa, mio bel Leardo,
le nari aperte, fosco lo sguardo,
tu squassi all'aure lucida e nera
superbamente la tua criniera;
il suol battendo coll'arid'ugna
cerchi la pugna, cerchi la pugna".
Siamo nel 1846 e Nigra è dunque studente universitario; la poesia però sarà resa nota solo nel 1854, dopo il carme in onore di Alessandrina d'Azeglio. Poiché siamo in tempi risorgimentali l'Ode finisce con questa sorta di invocazione a cui egli due anni dopo darà una coraggiosa conferma partendo volontario.
"Oh, se una volta lasciati i carmi
andrò alla pugna, stringerò l'armi- con te mio fido compagno antico,
- avventerommi contro il nemico;
- io pur difendere vo' il suol natìo
- nacqui in Italia, son forte anch'io.
Alza la testa mio bel Leardo,
apri le nari, sia foco il guardo,
squassa per l'aure lucida e nera
ferocemente la tua criniera,
batti la terra con l'avid'ugna
corri alla pugna, corri alla pugna".
Non stupisce che, con questi precedenti, quando il D'Azeglio cede il posto a Cavour, segnali il Nigra con particolari parole al successore e infatti il giovane impiegato si guadagna ben presto la stima del nuovo superiore e ne diventa segretario particolare. Cosicché nell'agosto del 1853 viene promosso applicato di quarta classe con L. 1.000 annue di stipendio e due anni dopo prende parte al viaggio di Vittorio Emanuele II alle corti di Parigi e di Londra; viene nominato console di prima classe,
II giovanotto - e che giovanotto! - è ormai noto anche fuori degli uffici ministeriali.
Come uomo ha tutte le doti per far girare la testa alle fanciulle sia per l'eleganza che in lui è naturale, per la conversazione piacevole e suadente, per la testa eretta, ornata da una capigliatura, oggi diremmo "beat", che conferisce al volto qualcosa fra l'artistico e il romantico.
Un profilo di Vittorio Bersezio ce lo presenta nelle vesti di un "dandy" perfetto; perfino con calzoni da cavallerizzo, speroni e frustino (il tutto . . . senza possedere il cavallo: si limitava a frequentare la scuola di equitazione) e con un certo mantello rigettato sulla spalla che doveva dare alla persona alta e slanciata, un fascino da ammazzacore.
Tutto questo mentre è studente e si guadagna qualche soldo come ripetitore; poi dopo la ferita a Rivoli, dopo l'assunzione al Ministero, le cose cambiano: è in vista il matrimonio che viene celebrato il 17 settembre 1855, l'anno del viaggio con il Re a Parigi e a Londra. Sposa Emerenziana Vegezzi Ruscalla, la figlia di Giovenale, uomo colto, ricco e introdotto nel mondo politico. Nigra ha ventisette anni, la ragazza, dieci meno. Che lei potesse essere innamorata si spiega; si spiega meno lo amore di lui. Probabilmente non furono estranei il calcolo e le possibilità della carriera: diventava egli genero di un uomo autorevole e nipote di quel Francesco Saverio Vegezzi che già deputato, diviene ministro delle finanze nel 1860 nel Gabinetto Cavour.
Di questi giorni mi è capitato fra mano un fascicolo, curato dal prof. Corrado Grassi dell'Università di Torino, che riproduce uno scritto del 1862 di Giovenale Vegezzi Ruscalla sulle origini di Guardia Piemontese in Calabria. Il fascicolo mi ha svelato la passione di glottologo del Vegezzi Ruscalla e per Nigra la glottologia era la passione prima; è probabile essa sia stata il punto di partenza per un contratto che dal piano dialettale passò a quello . . . matrimoniale. Se ci fu calcolo Nigra sbagliò perché ben presto gli eventi dimostrarono come egli fosse in possesso di carte che gli avrebbero concesso di giocare da solo, senza aiuti di terzi, la sua fortuna personale.
Tant'è. Matrimonio poco felice, che si dissolse praticamente in poco tempo e non fu la nascita, il 17 luglio del 1857, del figlio Lionello a saldare i due coniugi, tanto più che il carattere nevrotico della moglie andò sempre peggiorando.
Il diplomatico lontano dalle rive del Po e la moglie nella sua villa sulla collina torinese, chiusa in sé stessa, lontana da lui e da tutto il suo mondo. Risulta che i rapporti con la famiglia Vegezzi Ruscalla il Nigra li tenesse tramite la cognata Isa in Melisurgo, scrittrice.
Nel 1856 la prima impresa di uomo di fiducia di Cavour che lo porta con sé a Parigi al Congresso delle Grandi Potenze, dopo la campagna di Crimea. Lo statista piemontese ha vinto la rischiosa partita e a Parigi gioca la grossa carta nel concerto europeo dei leoni. Egli è appena, a giudizio del plenipotenziario austriaco Conte di Beust, "le petit chien hargneux"; però il piccolo cane rognoso darà del filo da torcere alle Grandi Potenze e sarà suo collaboratore il giovane capo di gabinetto Costantino Nigra.
Cavour ha il suo progetto; legare la Francia alle sorti del Piemonte per liberare la Penisola dalle forze austriache e dai satelliti. L'impresa, tenuto conto del peso dello Stato piemontese è da ritenere pressoché folle, ma Cavour già era stato un folle avveduto quando mandava 15.000 uomini in Crimea a dispetto di tutti coloro che lo accusavano di sanguinosa megalomania. Egli è un sottile psicologo; sa che Napoleone III vagheggia grandi cose in Europa; il nome lo richiama al Primo Napoleone di cui ambisce essere degno della stirpe, anche se qualcuno ne contesta la legittima discendenza. Parigi è un faro che illumina tutta l'Europa, e tutta l'Europa guarda a Parigi; Cavour asseconda l'Imperatore nel gioco; se la Francia vuol essere veramente la potenza determinante della politica europea deve mettere in ombra la potenza dell'Austria. L'Italia, egli suggerisce al terzo Napoleonide, può essere il terreno sul quale egli potrà ripetere le gesta dell'avo che con la campagna d'Italia iniziò la sua fortuna.
E Torino muove le fila; da Torino Nigra parte, attraversa il Moncenisio e arriva a Parigi. Il Piemonte ha colà, quale rappresentante, un uomo di poco conto: il Marchese Pes di Villamarina. Cavour non è per niente entusiasta del diplomatico; ci vuole ben altro per agganciare Napoleone III. Ci vuole Nigra che possiede una intelligenza aperta e duttile, una dialettica sottile e cattivante, la prestanza fisica, la cultura, la finezza di un nobile e gli accorgimenti di un vecchio del mestiere ( e questo "vecchio" non ha ancora trent'anni).
Possiede inoltre una discrezione che gli consente di non dare troppo nell'occhio. Lo stesso Villamarina si accorge tardi della sua azione circospetta e silenziosa. Prima protesta e poi si rassegna; riconosce che il giovanotto sa pilotare la barca meglio di lui. Cavour tesse la sua tela; ha stabilito di incontrarsi con Napoleone III a Plombières e a Plombières, il giorno 11 luglio 1858, Napoleone si impegna a venire in Italia ad aiutare il Piemonte con 200.000 uomini: chiede, oltre al Nizzardo e alla Savoia, una principessa di sangue reale per suo cugino Gerolamo Napoleone. La dinastia napoleonica è di data recente mentre i Savoia si appoggiano a otto secoli di storia; la principessa Clottide di sedici anni sposerà il trentaseienne Principe Gerolamo Napoleone detto "plon plon".
Le trattative per il perfezionamento dell'accordo si svolgono attraverso il Re, Cavour e Nigra. Villamarina, il quale resta appena una facciata dietro la quale si muove il canavesano, scrive al Cavour il 4 settembre 1858 che il giovanotto possiede "une modestie rare par le temps qui court".
Cinque giorni dopo questa lettera, Cavour ne scrive una al collaboratore in cui dice: "Non le dò ulteriori istruzioni, perché a quest' ora ella sa condurre la barca al pari per non dire meglio di me".
L'entusiasmo del maestro per l'allievo era tale che giunge a scrivere queste altre parole: "Egli ha più talento di me, conosce perfettamente le mie intenzioni e le sa eseguire come niun altro".
Ancora: "Je suis sur de lui comme de moi mème".
A Parigi se avesse dovuto operare Cavour di persona probabilmente le cose sarebbero andate male; aveva molti nemici poiché aveva attraversato con la sua politica la strada a tanta gente; godeva fama di anticlericale e di appartenere alla massoneria, titoli sgraditi all'Imperatrice e al partito cattolico .
Fisicamente poi non era quel che si dice un bell'uomo e anche questo conta; l'allievo esattamente l'opposto. Nigra è un signore nel gesto, nel portamento: Cavour un tracagnotto, punto elegante, la cui furberia alimenta sospetti, inoltre lo si considera uomo di pochi scrupoli. Nigra è meno scaltro ma più penetrante, non ha forse l'abilità del maestro ma lo supera nello stile, in quelle che i francesi definiscono le "nuances". L'uno completa l'altro e si direbbe che l'ingegno dell'uno integra quello dell'altro. Un binomio perfetto .
Nigra ha lavorato egregiamente e segretamente; torna a Torino ma a Parigi verso la fine del 1858 le cose si complicano. Il Principe Gerolamo Napoleone scongiura Cavour di rimandare in Francia il suo allievo e Cavour per quanto spiacente di doversi privare "dell'aiuto immenso che egli gli da" acconsente. In una lettera di quel tempo si legge: "Poiché è una necessità, mi rassegno a lasciarla a Parigi finché non siano spianate le difficoltà che le negoziazioni faranno sorgere. Questo sacrificio mi costa molto, poiché quando ella è lontano da me, mi sento mancare il mio più valido appoggio: ma lo faccio senza esitazione qualunque siano le conseguenze per me. Dal canto suo sacrifichi la modestia e le considerazioni personali al supremo interesse della Patria".
Che le cose a Parigi non procedano lisce lo prova un brano della lettera che Cavour scrive al Nigra in data 1 gennaio 1859: "Io non sono senza inquietudine; finché lei sarà a Parigi terrà testa a Walewsky, ma quando lei non ci sarà più come farà cotesto povero Villamarina? Io fatico molto a marciare senza di lei".
Il 13 gennaio il giovane diplomatico poteva scrivere al suo Capo queste parole: "Qui termina la mia missione. Essa non è sempre stata facile né comoda. Ma ho trovato nella fiducia del Re e di V. E. e nella mia profonda devozione alla nobile causa italiana, la forza necessaria per adempierla degnamente e con coraggio. Ho la coscienza di avere fatto tutto il mio dovere. Io l'ho informata di tutto ciò che sono venuto a sapere e di ciò che ho creduto di potere indovinare ed ho tenuto, povero ed oscuro impiegato, all'Imperatore ed al Principe, un linguaggio che molti ambasciatori non avrebbero avuto il coraggio di tenere. Ecco infine il Principe a Torino munito di istruzioni e di pieni poteri dell'Imperatore". Tono e parole non prive di un certo orgoglio; ingiustificato? Non direi. Questa non è immodestia, è consapevolezza del proprio valore. Nigra riprende la strada di Torino; poiché è inverno scende sulla costa Azzurra, raggiunge Nizza e di qui Torino.
Gerolamo Napoleone sposa la principessa Clotilde il 28 gennaio. Matrimonio gelido. La Marchesa d'Azeglio scrive al figlio Emanuele -ministro a Londra del Re di Sardegna - : "Ce mariage a soulevè d'abord une opposition generale dans toutes les classes de la population. La noblesse l'a manifestée en n'allant point a la première du théàtreet au bai Cavour". E precisa il padre Roberto al figlio, che a questo ballo di Cavour "il n'y avait que cinq dames appartenant a l'aristocratie. Ce qui a resolu le Roi a n'en point donner, disant qu'on l'avrait traité de mème".
Vittorio Emanuele amava la sua Clotilde e il sacrificio gli costò molto. Egli rinunciava alla parte migliore della sua famiglia. Il dolore e l'angoscia sono avvertibili nella seguente lettera diretta all'Imperatrice.
"Mia cara sorella e Madama, io vi faccio un dono di mia figlia. Prego la Vostra Maestà Imperiale, che è così gentile e che, nella sua gentilezza, ha avuto pietà del padre, di prenderne sotto le sue ali la figlia, perché la poverina è assai giovane e ha bisogno di una sorella così buona che l'aiuti con i suoi consigli. Io spero che vi piacerà: essa è come una pernice e non ha altra ambizione che quella di esservi gradevole. Perdonate queste mie parole: ma io sono sempre, mia cara sorella e Madama, con molto affetto e con grande rispetto della Vostra Maestà Imperiale Affezionato fratello Vittorio Emanuele II".
Diremo subito che la "pernice" non si trovò mai a suo agio nell' ambiente parigino, anzitutto per ragioni di tradizione; ella era fiera della sua ascendenza nobiliare e sdegnava una Corte che di ascendenti nobili non ne aveva e poi per ragioni di cultura e di severità di costumi, severità inesistente alla Corte Imperiale - dove regnava la mondanità - rigidamente coltivata a Torino .
Lo storico Roberto Sencourt postilla: "Tutta la sua vita era passata in un grigio pietismo e, nel compiere con tanto fervore i suoi doveri cristiani, così come essa li concepiva, pareva una figlia di Calvino messa di fronte a una maestra di ballo sivigliana". Nessuna meraviglia quindi se Clotilde fu una "parigina" fuori corrente e non riuscì mai a inserirsi nell'alveo ambientale delle Tuileries.
Gerolamo Napoleone arriva dunque a Parigi con la principessa sabauda; ciò non basta a placare le avversioni per il Piemonte dell ' ambiente di Corte: Imperatrice e Walewski, Ministro degli esteri, sono nettamente contrari all'intervento in Italia e Napoleone tentenna.
Nigra, che era ritornato a Parigi, quando avverte che la situazione sta peggiorando invoca la venuta di Cavour, il quale confida al D'Azeglio: "Nigra essendo a Parigi,ho sulle spalle una montagna di lavoro che minaccia di schiacciarmi moralmente e fisicamente" e scrive al collaboratore "di sentire crudelmente la di lei assenza. Perché ella è stato il solo a sostenermi. Lamarmora ha degli alti e dei bassi che mi fanno disperare. Ci sono dei giorni e delle notti in cui sono veramente tentato di battere la testa nel muro. Ma spero che ella ritorni presto, coperto dagli allori diplomatici e che io possa di nuovo appoggiarmi a lei".
Le cose andavano male: le Potenze si muovevano per indire un Congresso al fine di scongiurare la guerra e richiedere il disarmo del Piemonte; un dispaccio di Villamarina al Cavour da per perduta ogni speranza.
Ma in mezzo a tanto caos l'unico che non perde la testa è Nigra che ha il titolo di "Consigliere di legazione", titolo scelto dal Cavour perché "non deve dar noia a nessuno, perché rimane mio capo di gabinetto e mette piedi nella legazione solo quando ci conviene". Egli ha sufficienti elementi in mano per scrivere al suo Capo: "Si faccia dunque coraggio, signor conte, e perseveri. Se l'occasione favorevole si presenta non se la lasci sfuggire e dia fuoco alle polveri. Non si consigli che con il suo cuore e la sua alta intelligenza. Tutti gli uomini di Stato dell'Europa, presi insieme, non valgono V. E. I fatti finiranno per prevalere, ma io credo che il tempo urga e ritengo che non bisogna lasciare all' Inghilterra il mezzo di imporci un disarmo forzato". Parole di coraggio del subalterno al superiore, il quale ne aveva bisogno perché ora a Torino ha contro anche il Re.
"E' ora abbattuto e irritatissimo; quest'oggi mi disse con molta amarezza che egli era deriso e tradito, che ciò che aveva preveduto accadeva, che l'Imperatore, una volta ottenuta la mano di sua figlia, non si curava più di serbare le date promesse, aggiunse che aveva ceduto alle mie istanze ed ai miei consigli e
che ora doveva pentirsene". Commenta Cavour: "In altre condizioni di cose non avrei sopportato pazientemen te questi amari rimproveri. Li ho deposti ai piedi dell'orribile Calvario
nel quale la diplomazia si prepara a crocifiggere di nuovo l'Italia .'...... Sono anch'io dell'opinione che il momento di agire sia giunto e la ringrazio del consiglio di non perdere la testa. Ma la tengo, di quando in quando fra le mani, perché non fugga" .
Nigra non ha motivi per essere tranquillo, tuttavia intuisce che non bisogna scoraggiare oltre il Conte e scrive: "Sia fermo, coraggioso, grande fino in fondo e soprattutto verso tutti. Finché l'Italia resta unita non è il caso di disperare" . E soggiunge: "E' per noi necessità e prudenza a un tempo il tenerci armati e respingere arditamente ogni intimazione da qualunque parte venga. Vi sono momenti nella vita di un popolo in cui l'audacia è prudenza" . Cavour aderisce ai solleciti che gli giungono da Parigi, parte mail viaggio è senza fortuna e torna a Torino amareggiato. La progettata conferenza è la spada di Damocle che sta sul capo de1 Piemonte: si chiede al Nigra un parere telegrafico e il parere è così stilato: "O ammissione al Congresso sul medesimo piede delle Grandi Potenze o fin de non recevoir". Che accadrà? Vittorio Emanuele scrive a Napoleone che egli è disposto ad abdicare con tutte le conseguenze relative, Cavour minaccia più gravi risoluzioni .... - ma a nulla servono queste minacce poiché il 18 aprile Napoleone telegrafa a Torino d'accordo con l'Inghilterra, imponendo di accettare il disarmo.
Ma l'Austria, indignata della "petulanza piemontese" rifiuta la proposta dell'Inghilterra e accettata dalla Francia, di far partecipare al ingresso gli stati italiani con voto consultivo e spedisce per conto proprio un "ultimatum" a Torino: il Piemonte deve disarmare entro tre giorni.
E' la guerra per la quale Cavour aveva lavorato con Nigra senza misurare le energie. Il 23 aprile la Camera concede al Re i pieni poteri. Uscendo dalla seduta il Primo Ministro esclama: "Alea jacta est. Esco dalla tornata dell'ultima Camera piemontese; la prossima sarà quella del Regno d'Italia. Abbiamo fatto della storia e ora andiamo a pranzo".
Perché, Signori, ho fatto questa rievocazione? Per illustrare la opera svolta da Costantino Nigra nella preparazione della guerra del 1859, risolutiva per la sorte dell'Italia?
Non per questo; farei torto a lor Signori se supponessi non sia conosciuta la pagina di storia scritta da Cavour e dal suo collaboratore; la ragione è un'altra: nella lunga rievocazione di fatti storicamente accertati si sono incontrate tre donne.
La prima è la Contessa di Castiglione e precisamente Virginia Oldoini Verasis, per gli intimi "Nicchia" (fra questi intimi c'era stato anche Vittorio Emanuele . . . ). La bella e avvenente signora era stata mandata a Parigi da Cavour nel 1856; la Contessa aveva ventun anni e aveva sposato a diciannove il Conte di Castiglione addetto alla Casa di Vittorio Emanuele. Cavour aveva "arruolato nelle file della diplomazia la bellissima Contessa di Castiglione per "coqueter" e per sedurre, ove d'uopo, l'Imperatore" così in una lettera al Conte Cibrario,Ministro degli Esteri; infatti la Castiglione sedusse l'imperatore ma la diplomazia piemontese non ebbe vantaggi di sorta; quando Nigra arrivò a Parigi nel 1858, la fiamma era già spenta. Nigra partiva dunque da zero.
La seconda donna è la Principessa Clotilde; l'assenso al suo matrimonio con "Plon plon" fu determinante per l'alleanza con la Francia; il padre l'aveva lasciata libera di accettare o respingere la richiesta di Napoleone, ma la fanciulla era già abbastanza donna per comprendere che cosa avrebbe significato il suo no e disse un sì che gli storici le accreditarono come uno stoico sacrificio, tenuto presente fra l'altro, che ella, religiosissima, sapeva di andare sposa a un ateo e a un libertino.
La terza rappresentante del gentil sesso è l'Imperatrice Eugenia, la spagnola Contessa di Montijo: noi l'abbiamo scorta solo fra le quinte. Ella pure molto religiosa si sentiva fiera di essere nume tutelare della Chiesa; la presenza delle truppe francesi a Roma che proteggevano il Papa, rappresentavano per lei un titolo di alto merito e pertanto il Piemonte che aveva perseguitato Chiesa ed ecclesiastici, che aveva un Re alquanto spregiudicato ed era diretto in politica da un uomo come il Conte di Cavour, per nulla ossequente ai precetti religiosi, non godeva le sue simpatie. In considerazione di ciò era logico che ella non fosse favorevole alla politica del marito e facesse di tutto per scongiurare 1' intervento della Francia in favore del Piemonte.
Questa è la storia .... Ma, convengo, per un romanziere questo panorama femminile è un pò grigio e non sarò io a misconoscere i diritti della fantasia. . . . ma ritengo che questi diritti, quando si tratta di storia, diciamo così, a portata di mano, vadano usati con parsimoniosa misura.
E la storia dice che nel biennio 1858-59 Costantino Nigra non fece corte di sorta all'Imperatrice, perché egli si muoveva nell'ambiente parigino in veste di personaggio-ombra, il quale aveva tutto l'interesse di lavorare senza dare nell'occhio. In un primo tempo agì con tale circospezione che neppure il nostro rappresentante, il Marchese Pes di Villamarina, lo avvertì.
Afferma il pronipote Dott. Costantino De Rossi Nigra in un discorso pronunciato al Rotary d'Ivrea nel 1964: "Come agente segreto il Nigra si presenta a Saint Cloud solamente nell'agosto del 1858 e conferisce ripetutamente con Napoleone III senza formalità di protocollo fra lo stupore dei cortigiani, ai quali riesce incomprensibile che l'Imperatore tenga in gran conto quel giovanotto che pronuncia tanto male un francese tuttavia correttissimo. L'ufficiale di ordinanza dell'Imperatore scrive segretamente al fratello, Principe Henri de la Tour d'Auvergne, ministro di Francia a Torino, che "un certo signor Nigra, un bel giovane, molto elegante, era stato trattato dall'Imperatore come persona di alto rango. Si serviva di un nome fittizio? " .
Dopo questa citazione il De Rossi Nigra si domanda: "Come pensare che in quell'anno il giovane agente segreto sia stato "d'amor rapito" per colei alla quale certamente non era stato ancora presentato?".
La domanda è a un tempo una risposta al racconto del Gotta: niente idilli segreti, niente incontri clandestini - come abbiamo visto alla televisione - niente abbandoni, che sia detto per inciso, non sarebbero stati facili in un ambiente come quello delle Tuileries dove anche i muri avevano occhi e le porte orecchie.
Non è un mistero per nessuno che Napoleone III aveva una sua polizia personale e l'aveva anche l'Imperatrice perché intendeva essere informata delle imprese più o meno sentimentali del marito. Infatti la tresca con la Castiglione la seguiva nei suoi sviluppi giorno per giorno. Per trovare qualcosa che offra lo spunto per un romanzo e crei una leggenda, bisogna arrivare al 1860.
Cavour che si era dimesso a causa di Villafranca, torna al potere dopo alcuni mesi di lontananza, coperti dal ministero Rattazzi - Lamarmora dimostratosi impari ai tempi ed agli eventi.
Il Conte il 20 gennaio 1860 è dunque di nuovo Presidente del Consiglio e lo sguardo è ancora a Parigi, da dove il suo occhio non si è mai staccato, dove Nigra vi torna in veste di capo della delegazione,anche per sollecitazione del Principe Gerolamo Napoleone, il quale scrive che il Canavesano "è sempre riuscito e riuscirà ancora, farà in tre giorni più che gli intermediari attuali in tre mesi" .
E la conferma di questa verità Cavour la trova in una lettera del 2 maggio nella quale Nigra comunica al suo capo che l'Imperatrice comincia a ricredersi sul di lui conto ed aggiunge: "D'altronde ella si mostra molto amabile per le persone di questa delegazione".
Cavour di fronte a queste linee prende fuoco e risponde: "La sua conversazione con l'Imperatrice mi ha entusiasmato. Evidentemente essa vivuo sedurre. La lasci fare e non sia troppo "Giuseppe". Alla lunga la sua influenza potrebbe nuocere. Non bisogna trascurare nulla per renderla favorevole alla nostra causa. Le ripeta che noi italiani la troviamo seducente. Del resto mi pare che ella non abbia bisogno di lezioni, ma che sappia cavarsela alla Richelieu ed alla Metternich". E' tutto. Per la storia non c'è altro. Cosicché fondatamente il mio concittadino Michelangelo Giorda (che del Nigra ha dato il profilo più obiettivo che io conosca), da storico che non si lascia prendere la mano dalla fantasia commenta: "Noi non sappiamo e nessuno sa veramente se l'Imperatrice abbia subito il fascino del biondo canavesano o viceversa: quello che è certo si è che, da perfetto gentiluomo, il Nigra non parlò né lasciò traccia della sua presunta avventura. Ma il nostro romanziere alla fantasia "ha dato" come si suoi dire corda. Non vi fu tresca - come abbiamo visto - negli anni 1858-59 perché Nigra risiedeva a Parigi in forma quasi clandestina, senza opportunità e senza intenzione di frequentare circoli e salotti e, tanto meno, data la natura della sua missione, la corte imperiale". Sono parole del Dott. De Rossi Nigra che sottoscrivo come sottoscrivo le altre secondo le quali il suo parente, lasciato il Canavese, si può dire pressoché definitivamente dal 1851, allorché entra nella carriera statale, non ebbe amici intimi nella regione; l'unico amico, l'Avv. Antonio Talentino di Castellamonte , morto nel 1895, non risulta abbia continuato la relazione degli anni studenteschi. Poi bisogna tenere presente il carattere ossia il suo "estremo riserbo e la sua ripugnanza per la millanteria".
Una fonte a cui ha attinto Salvator Gotta sarebbe il figlio Lionello, il quale all'età di dieci anni avrebbe assistito nientemeno che a un litigio tra i due amanti; Lionello Nigra era nato nel 1857,il litigio sarebbe avvenuto attorno al 1866; la relazione avrebbe avuto la durata dunque, tenendo presente che Gotta ne parla come fosse già sbocciata nel 1858, all'incirca otto anni. Per otto anni alla Corte di Parigi non ci sarebbe stato né occhio indiscreto né poliziotto in grado di avvertire l'Imperatore del servizio che gli rendeva il canavesano .
E, dato il carattere del Nigra, che sapeva di giocare a Parigi la carta dell'Italia - non quella del suo cuore -, egli avrebbe compromesso la causa per la quale si batteva per un gioco erotico che non poteva non screditarlo e far crollare la sua costruzione diplomatica?
Vogliamo dirla chiara una parola sull'informatore Lionello? La pronuncia con molta misura il Dott. De Rossi Nigra: "Esso (l'episodio) è ancora meno credibile perché uscito dal cervello balzano di Lionello Nigra, un narratore portato spesso a confondere la realtà con la favola".
Credo sia il meno che si possa dire di quel figlio degenere che , scialaquatore e scriteriato, un giorno sposò all'insaputa del genitore una contadina della Val Chiusella, sana e robusta. Tuttavia questo non è stato sufficiente per mettere al mondo un rampollo sano e robusto poiché il padre gli diede sangue guasto, cosicché morì all'età di nove anni, si può dire, senza essere vissuto. Ho del fanciullo un ricordo visivo, a un tempo netto e penoso.
A questo punto apro una breve parentesi: in meno di cento anni(1828-1905) la parabola dei Nigra era conclusa: l'Ambasciatore che nel 1882 Umberto I aveva creato conte, si spense il 1° luglio 1907 a Rapallo; il figlio Lionello moriva l'anno dopo per un attacco cardiaco a Vico Canavese, patria della moglie; il nipote Costantino il 24 aprile 1919 a Nervi. Lo stemma che l'Ambasciatore si era scelto con un motto araldico che bene contraddistingueva il suo carattere: "Aut e drit" ("alto e diritto") è oggi un ricordo. La parentesi è chiusa.
Si è ricamato molto da Salvator Gotta sul regalo dell'Imperatrice al Nigra di uno scrigno appartenuto a Napoleone I; il Dott. De Rossi va più in là e asserisce che l'Imperatrice offrì all'Ambasciatore anche un suo ritratto ad olio, nonché una riproduzione in marmo della mano destra. Ma questi regali, osserva il pronipote, "vennero troppo apertamente conservati dal cautissimo ambasciatore per poter offrire materia di maldicenza".
Mi sia consentita a questo punto una breve rievocazione poetica: riguarda l'anno 1861; si tratta di un componimento che precede di due anni la famosa "barcarola", sulla quale mi fermerò fra poco. Il componimento fu noto solo nel 1875 ma venne composto nel 1861 (come si vede Nigra non era uomo che amasse la pubblicità e la gloria mondana).
E' la "Rassegna di Novara". Il poemetto si compone di 234 versi sciolti. Come dice il D'Ancona "è una specie di leggenda epica; materiata di storia e di fantasia. Immagina il poeta che ogni anno, alla vigilia del giorno dei Morti, Carlo Alberto sorga a mezzanotte dal suo sepolcro di Superga, "appoggiato sulla lunga spada", e d'intorno a lui accorrono i suoi capitani caduti nelle patrie battaglie. Sale in groppo al suo candido destriere di guerra e scende giù a corsa dal colle coi suoi compagni,finché giunge sul campo di Novara e ivi passa a rassegna i suoi morti".
Non darò che un brevissimo saggio, attingendo all' inizio della composizione. Le prime schiere sono quelle dei Carabinieri.
Del Re custodi e della legge, schiavi
sol del dover, usi obbedir tacendo
e tacendo morir ....
Ecco donde l'Arma ha attinto il motto che la contraddistingue .... Non vado oltre perché il tempo mi manca; trascuro i bersaglieri, i fanti, i granatieri, gli squadroni di cavalleria; nessuno è dimenticato. Finita la Rassegna
"col brando
l'ombra regal da l'ultimo saluto
alle spente falangi e si dilegua
nei primi raggi del nascente sole".
Torniamo alle vicende politiche parigine, alla "barcarola".
Questo episodio reca la data del 1863 ma ha un antefatto in quella che possiamo definire la dinamica attività dell'Imperatrice. La quale,trascurata come moglie, si rifaceva come donna politica e, poiché sapeva di essere bella e affascinante,usava questa carta per inserirsi nel gioco diplomatico; di qui i suoi colloqui soprattutto con Metternich, che rappresentando l'Austria, rappresentava in Europa l'antagonista
più pericoloso e, nel contempo, più utile alla causa francese. Per l'Austria Eugenia aveva un debole, il debole derivava dal cattolicismo dell'Impero degli Asburgo che ella sentiva vicino nella difesa dei diritti della Santa Sede.
Scrive lo storico Sencourt che aveva escogitato un piano per trasformare e pacificare l'Europa e quel piano comprendeva, fra l'altro, una Polonia libera, un'Italia padrona della Venezia e altro ancora.
L'Imperatore, che teneva più della moglie i piedi per terra (l'Imperatrice era stata definita da Metternich "tutta fuoco e fiamme"), dichiarava: "Ciò che tu vuoi soprattutto è di poter fare un proclama ai francesi in cui dirai che hai ottenuto con la tua abilità ciò che le armi non potevano realizzare: l'Italia libera fino all'Adriatico, non più un quadrilatero con cui arrestare il più potente esercito del mondo; la Polonia ricostituita a spese dei trattati del 1815; il Reno un fiume francese. Se dopo tutto ciò l'Austria non esiste più, poco importa".
L'Imperatore vedeva chiaro, ma la moglie non desistette e preparò il piano di un'alleanza offensiva e difensiva fra Parigi e Vienna. Metternich naturalmente non prendeva in considerazione simili piani.
I quali, prevedevano che l'Austria dovesse fare le spese della situazione italiana e dovesse garantire l'indipendenza dei Borboni a Napoli e del Papa a Roma; ma Roma e Napoli stavano a cuore agli italiani quanto la Venezia e si spiega pertanto la sorpresa provata da Nigra il 19 maggio 1862 quando, in occasione di un pranzo al Trianon, l'Imperatrice lo invitò a bere insieme con Walewski al trionfo dei suoi progetti. E' bene sottolineare che le simpatie di Walewski per l'Italia non erano superiori a quelle dell'Imperatrice.
Scrive il Sencourt: "Subito dopo il pranzo Metternich le disse che lo scherzo non gli era parso conveniente, ma ella non era donna da ricevere consigli e fece venire a sé l'Ambasciatore italiano..
- Che cosa desiderate da me, signor Nigra? - ella gli chiese.
- Vorrei rivolgervi una preghiera.
- Il momento è mal scelto, comunque sentiamo.
- Vorrei che V. M. fosse un pò meno ostile verso di noi ed usasse la Sua influenza presso l'Imperatore per fargli ritirare le truppe da Roma.
L'Imperatrice montò sulle furie.
- Io mi romperei con Voi piuttosto che dar mano al Vostro brigantaggio. Ah, voi volete che noi Vi accontentiamo sempre in tutto e per tutto . Siete insaziabili. Voi chiamate briganti i sudditi fedeli del Re di Napoli. Come Vi chiamereste Voi? Siete Voi che rubate ciò che è degli altri. Voi volete che noi seguiamo il Vostro esempio. Ma ricordatevi bene: il giorno della vendetta verrà. I Mazzini e i Garibaldi si moltipllcheranno nelle Vostre bande: e il giorno in cui non ne potrete più Vi assicuro che io non verrò a darVi alcun aiuto.
- Francamente V. M. è troppo ingiusta - Nigra esclamò - Ed a mia volta mi permetto domandarvi se il Re non fa oggi in Napoli ciò che l'Imperatore ha fatto ieri in Francia.
Eugenia si irritò anche di più.
- Non dite queste cose a me. Non paragonate l'Imperatore al Vostro brigante: l'Imperatore non ha derubato alcuno; egli ha trovato la Francia abbandonata, il trono vuoto ed ha salvato la Francia schiacciando gli uomini del Vostro stampo. Nigra prese il cappello, si alzò e se ne andò. Ella allora si rivolse al Metternich in tono di scusa spiegando che si era lasciata trasportare dall'odio che le ispirava l'agente di Cavour".
Continua lo storico: "Ma la rottura fu presto accomodata. Un anno più tardi Nigra fu invitato a Fontainebleau e ritornò alla sua carica diplomatica. Insieme con l'Imperatrice e con una dama che aveva conquistata alla sua causa Nigra uscì in gondola sul piccolo lago. La dama di compagnia gli chiese di cantare una "barcarola". Nigra ne intonò subito una, nella quale inneggiava alle grazie ed ai meriti dell' Imperatrice ed accennava alla speranza che a lei l'Italia sarebbe stata in debito della Venezia". Fin qui lo storico francese.
La storia della "barcarola" è stata raccontata dal Nigra stesso con maggior precisione in una lettera indirizzata al veneziano Alberto Cavalletto. "L'Imperatore Napoleone III, negli anni 1862-63, quando studiava le imprese navali di Giulio Cesare, aveva fatto riunire sullo stagno di Fontainebleau un certo numero di imbarcazioni a remo, diverse di origine, di forme e di destinazione. Egli le sperimentava nelle tiepide ore estive navigando sullo stagno ora sull'una ora sull'altra, e l'Imperatrice Eugenia amava anch'essa fare il giro del piccolo lago in barca al chiaro di luna. Ma nessuna di quelle imbarcazioni era abbastanza vasta e comoda per accogliere l'Imperatrice e una parte almeno del suo seguito. Ella fece quindi venire da Venezia nella primavera del 1863 una gondola e un gondoliere. Una bella sera di giugno di quell'anno al gondoliere Luigi Zanitello fu richiesto di cantare, vogando, una canzone veneziana. Ma egli non aveva voce e non sapeva cantare. Io ero quella sera nella gondola imperiale con altri ospiti, tra i quali ricordo la poetica figura della Duchessa Adele Colonna d'Affrey, prematuramente morta di poi. (E' questa dama che, secondo il Sencourt, il Nigra aveva conquistato alla sua causa?). Io dissi all'Imperatrice che se desiderava una canzone io gliel'avrei trovata. La proposta fu accolta. La canzone, che è quella qui scritta, era pronta per la sera seguente e approvata prima da Prospero Merimée, che era uno degli ospiti, la recitai all'Imperatrice in gondola.
L'Imperatore seguiva dappresso in altra barca. Ascoltò la canzone e si allontanò senza parlare".
A questo punto richiamiamo i versi finali della "barcarola", in tutto trentadue settenari:
"Sopra il suo letto d'alghe
posa il leone e aspetta
che il dì della vendetta
lo venga a ridestar.
Donna, se a caso il placido
tuo lago, a quando a quando
teco verrà solcando
il muto Imperator
digli che in riva all'Adria
povera, ignuda, esangue
geme Venezia e langue-
Ma è viva ... e aspetta ancor".
Noi sappiamo dal Nigra che l'Imperatore "ascoltò la canzone e si allontanò senza parlare". E l'Imperatrice a cui il Nigra si era apertamente rivolto come reagì? Nigra non ce lo dice.
Il Sencourt asserisce invece che "l'Imperatrice bruscamente interruppe la serata e aggiunse: "Queste insinuazioni non mi fanno certo piacere" essa esclamò; "fino a quando vivrò non farò certo alcuna pressione sull'Austria". La nota in calce alla pagina dice: Archivio di Vienna.
L'episodio viene di là, si tratta evidentemente di una relazione al suo Governo del Principe Metternich il quale, con tutta probabilità era presente alla festa.
L'Imperatrice dunque, secondo il documento austriaco, non ha cambiato idea sull'Italia, sul suo rappresentante diplomatico - il presunto amante! - sul suo Re. L'Ambasciatore poeta ha fatto del suo meglio ma, si direbbe, trattandosi di un lago, abbia fatto un buco nell'acqua.
Vi è poi l'episodio del settembre 1870 quando cade l'Impero e viene proclamata la Repubblica. L'Imperatrice corse serio rischio di essere aggredita dalla folla inferocita (la stessa naturalmente che qualche anno prima l'aveva osannata) e Gotta dichiara che l'aver fatto il Nigra tutto per sottrarla alla plebaglia è "una prova dello straordinario interessamento di un ambasciatore straniero verso l'Imperatrice dei francesi".
E' vero, Nigra compì quel gesto ma come provano i documenti, non da solo; era in compagnia del suo antagonista Riccardo di Metternich, ambasciatore austriaco, che si dice godesse delle simpatie dell'Imperatrice. I due compirono di comune accordo un gesto di genuina cavalleria, il meno che potessero fare in un frangente del genere per colei che in quel momento rappresentava l'Imperatore, in quanto era reggente, ossia il Capo dello Stato. E si deve a un tratto di spirito del Nigra che ai ragazzacci i quali gridavano "Voilà l'Imperatrice" contrappose: "Voilà les prussiens", e la carrozza potè allontanarsi. Anche questa trovata la dobbiamo mettere in conto dei lontani amori?
L'avere abbandonato l'Imperatrice fu giudicato un atto pusillanime da qualcuno, ma il Nigra nel 1906 ricostruendo l'episodio precisava: "Sua Maestà scesa la gradinata del Louvre al mio braccio, io la misi in una carrozza (un fiacre predisposto) e volli io pure salire sulla stessa carrozza per accompagnarla, ma Essa preferì avere al suo fianco soltanto M. me Lebreton, sua lettrice, per non compromettermi. Io salii in un altro fiacre ed ordinai al cocchiere di seguire quello che portava con sé grande parte della fortuna dell'Impero. Ma la folla ci divise e, malgrado ogni mio tentativo, non potei raggiungerla e non seppi dove l'infelice fuggitiva aveva deliberato di rifugiarsi, se non tre giorni dopo".
I cronisti del tempo, non esclusi gli scandalisti di professione come Maxime du Camp (che nei suoi "souvenirs" non ha risparmiato neppure il Nigra, dirò, uomo d'affari) non hanno alcun cenno sulla presunta tresca né proiettano alcuna ombra sull'onestà dell'Imperatrice; la quale avrebbe avuto più di un motivo per restituire al consorte pan per focaccia. Le avventure dell'Imperatore si susseguivano in serie; nel 1865 la femmina di turno era una certa Margherita Bélanger, una donna di bassa condizione che l'Imperatore aveva installato in una casina a Fontainebleau.
Eugenia ne era disgustata in sommo grado e si espresse con il Walewski nei seguenti termini: "Non supponete che non mi sia mai accorta dell'infedeltà di quest'uomo. Ho fatto di tutto; ho tentato perfino di renderlo geloso. Ma tutto fu vano. Tuttavia questa volta è caduto così in basso con questa "crapula" che io non posso resistere più a lungo". La frase è tolta dal libro del Colonnello Wellesley "L'ambasciata di Parigi".
II Filon, altro memorialista dell'Impero, dice "che non era facile ingelosire Napoleone. Egli conosceva troppo bene la virtù dell'Imperatrice ed era troppo sicuro del suo attaccamento al trono e della devozione per suo figlio. D'altra parte aveva ben saputo che essa aveva avuto molti ammiratori. C'era stato un giovane spagnolo che aveva perduto, per lei, la ragione. C'era stato il Conte Camerata, un parente dei Bonaparte, il quale si era tirato un colpo di rivoltella nel 1853. C'era Caro , il celebre filosofo. C'erano Offembach il musicista e Ottavio Feuillet il romanziere. Cosa più strana, c'erano stati il Ministro degli esteri austriaco, conte Beust e l'ambasciatore prussiano conte von der Goltz. "Il mio povero Goltz", l'Imperatrice era solita chiamarlo.
Il Sencourt non fa cenno alle eventuali simpatie di Eugenia per Nigra. Si limita a dire: "Ella si fece amici anche i quattro ambasciatori:l' italiano Nigra, il Conte Hubner, austriaco, che succedette al Principe Riccardo Metternich e l'inglese Lord Cowley. Con questi signori essa mostrò d'interessarsi alla politica delle varie nazioni, alle rivalità e alle alleanze ed ebbe anche modo di tradire una certa passione per gli intrighi che doveva esserle venuta fin da giovinetta frequentando la Corte spagnola. Abbordava anche gli argomenti più delicati con la maggior arditezza. Quando un ambasciatore cominciava facendole un complimento convenzionale per la sua grazia, ella passava senz'altro a chiedergli informazioni sulle simpatie di una Corte straniera".
Sono interessanti questi altri particolari per colorire meglio la sua figura: "Intorno a lei c'erano molte amabili donne che le erano assai più care degli uomini. L'Imperatrice si compiaceva di affascinare gli uomini ma poco si curava della loro bellezza fisica e meno ancora delle loro attenzioni. Invece la bellezza di una giovane arrestava sempre il suo sguardo. Per essere damigella d'onore dell'Imperatrice la bellezza era un titolo indispensabile e spesso sufficiente........... Eugenia ammise nella sua vecchiaia che essa aveva sempre desiderato di essere circondata di belle donne. Avviene quasi inevitabilmente - osserva il Sencourt - che le donne (o gli uomini) che hanno questo godimento platonico della bellezza del loro sesso, se si sposano, sposano sempre coloro che solleticano più la loro ambizione che i loro sensi. Per l'Imperatrice era quasi incredibile che una donna dovesse sposare un uomo per la sua bellezza. "Belli o brutti, ella disse una volta, gli uomini sono tutti gli stessi alla fine di una settimana". E quando gli istinti della passione provengono non dal sangue ma dall'amicizia e dalla ammirazione, si può essere sicuri che si tratta di una natura più ambiziosa e, qualche volta, più religiosa".
Continua lo storico nella sua analisi e nella sua . . . diagnosi: "Così si spiegano tante cose in Eugenia: il suo disgusto e la sua lunga fedeltà per il primo uomo che ha amato come pure il fatto che nessuno ne prese mai il posto; perché nessuno potrebbe affermare che essa abbia sentito una attrazione naturale per Napoleone III; si spiega come lei non sia mai stata attratta dalla dissipazione sensuale che caratterizza invece la Corte della Regina Isabella; si spiegano i suoi entusiasmi intellettuali e quel potere affascinante che si accompagnava alla sua vivacità. Si spiega, soprattutto, come la mentalità della donna intuitiva e impulsiva si accordasse colla prontezza della decisione, l'ardimentoso coraggio e lo spirito sportivo. Ecco dunque rivelato il mistero della parte che Eugenia rappresentò nella storia della Francia. Essa fu, dal principio alla fine, una donna brillante, di una fenomenale energia nervosa, ma fu anche uno di quei tipi leggermente anormali in cui gli impulsi naturali sono sostituiti da altre passioni, da qualche cosa che sta fra il senso e lo spirito e risiede più negli occhi che nel cuore "per dirla senza giri di parole, come lasciò scritto Lady Ethel Smyth, ella non aveva in sé alcuna sensualità".
Questa Ethel Smyth era una musicista che fu vicino all'Imperatrice per una trentina d'anni e aveva quindi elementi sufficienti per giudicare il carattere, la sensibilità nervosa ed erotica di Eugenia di Montijo.
Nel 1865 Bismark fece una visita in Francia; egli pensava di attaccare l'Austria e voleva tastare il polso del Governo di Parigi e, in particolar modo, della Corte dove sapeva che il Governo di Vienna godeva di particolari simpatie. Al suo ritorno in patria il Cancelliere di ferro dichiarò che in Francia aveva trovato due sole donne piacevoli: la Contessa Walewsky e l'Imperatrice e non un solo uomo; un ministro che lo aveva accompagnato nel viaggio aggiunse che un uomo c'era nel governo francese ed era l'Imperatrice . A questo punto è tempo di tirare i remi in barca. Cercherò di tirarli ricorrendo alle parole della stessa Eugenia: "La mia leggenda è fatta; al principio del regno io fui la donna futile che si occupava solamente di chiffons; verso la fine dell'Impero sono diventata la donna fatale che si vuole rendere responsabile di tutti gli errori e di tutte le sciagure. E la leggenda ha sempre ragione della storia".
Sono parole amare intinte di scetticismo. In un certo senso le potrebbe pronunciare anche Costantino Nigra per la sua vicenda, chiamiamola, sentimentale. La leggenda ha sempre ragione della storia? E' proprio vero? Credo di no.
Comunque mi rifarò a uno storico, a cui la passione non fa veli , a Federico Chabod, che nel secondo volume del suo studio su la "Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896" cosi scrive a proposito della "barcarola": "Non è qui il caso di toccare il punto dei rapporti fra la Imperatrice e Nigra, che è quello in cui la storia svanisce nella leggenda. Basterà ricordare che ad esagerazioni di un genere, si è contrapposta l'esagerazione del Sencourt, secondo cui Nigra avrebbe ispirato ad Eugenia non tenerezza bensì odio. La contraddicono non soltanto il ricordo che il Nigra serbò sempre dell'Imperatrice, la quale gli aveva fatto dono di una sua miniatura bellissima e la visita che Eugenia fece al Nigra a Venezia nell'estate del 1905 (osservo che Nigra ha 77 anni ed Eugenia 79) ma i precedenti giudizi di uomini bene informati come il Mérimée, il generale Fleury, il principe di Metternich, che parlano invece di un Nigra persona grata all'Imperatrice, nonostante i suoi scatti e rabbuffi a proposito delle questioni italiane e, soprattutto, del Papa".
Credo che le serene parole dello studioso Valdostano colgano il segno, e questa è anche la conclusione a cui è giunta la professoressa Barello, la più recente e diligente biografa del diplomatico canavesano: non esagerazioni da un lato non esagerazioni dall'altro; due vite . . . quasi parallele che si sono incontrate sul terreno della stima e, fors'anche, dell'amicizia, che si sono avvicinate fino a un gioco che potremmo chiamare schermaglie di Venere e Cupido senza che i dardi di questi siano andati oltre l'epidermide di quella. Il che, dopo tutto, non potrà spiacere al mio corregionario Salvator Gotta, al quale non va negato il merito di aver richiamato in vita, con il suo prestigio di scrittore, una figura che la polvere del tempo stava appannando.
Signori, la mia chiacchierata, è conclusa; la rievocazione della ipotetica vicenda sentimentale si ferma al 1870 e trascuro certe code veneziane di anni più tardi che non sono storicamente più fondate di quelle sulle quali ci siamo soffermati. Fermandomi al 1870 rinuncio a parlare del Nigra diplomatico dei empi successivi e si tratta di ben trentaquattro anni; queste vicende potrebbero essere materia di un'altra conversazione, poiché è molto vasta e vedremmo di quanta amarezza furono intinti quegli anni per Costantino Nigra. Ci limiteremo a ricordare che dopo Parigi egli fu destinato come Ambasciatore a Pietroburgo (1876 - 1-882), poi a Londra (fino al 1886) e quindi a Vienna dal 1886 al ritiro dalla carriera nel 1904.
Se ancora oggi i politici discutono attorno alle sue voluminose memorie, che non furono trovate e certamente da lui distrutte, e attorno alla sua figura di uomo che può essere investita come tutte le figure umane di ombre e di luci, nessuno discute i suoi studi storici sul Canavese , sulla lingua celtica e tutti ammirano, in patria e all'estero, un 'opera di filologia che onora l'autore e l'Italia: i "Canti popolari del Piemonte" . E' opera di studioso e di poeta, quel poeta che nella traduzione dal greco dell'elegia di Callimaco "La chioma di Berenice" eguagliò, se non superò, il Foscolo. "I canti popolari del Piemonte", a cui attese per molti lustri, è opera che lo classifica primo nello studio della poesia popolare in Italia; è fatto singolare che un politico sopravviva per un'opera di poesia. Potrei concludere che la politica passa e la poesia resta; infatti concludo così.
Costantino Nigra,fra cent'anni,nel campo della politica si perderà fra le pieghe di un'epoca più o meno tormentata e forse negletta, ma nel campo della poesia sarà Costantino Nigra in tutte lettere. La poesia cancella gli intrighi diplomatici e le vicende amatorie e costruisce un piedestallo dal quale egli può guardare ai posteri per dirla con il Manzoni, con "un cantico che forse non morrà".
COMMEMORAZIONE NIGRA di CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON - SENATORE DEL REGNO Pubblicata nell'Edizione del "Corriere diplomatico e Consolare" - Roma, 1928

UN GRANDE DIPLOMATICO: COSTANTINO NIGRA
II centenario della nascita di Costantino Nigra, il collaboratore animoso e sagace della politica cavouriana, è stato celebrato con degna solennità in Torino, il 1° luglio 1928, ad iniziativa d'un Comitato speciale presieduto da Paolo Boselli, e del Comitato Piemontese per la Storia del Risorgimento. A Palazzo Madama, antica Sede della Camera Alta, per la circostanza s'adunò quanto di più eletto la metropoli subalpina vanta in ogni campo dell'attività sociale, e l'imponente accolta vide rialzato il suo prestigio dall'augusto intervento delle LL. AA. RR. il Principe Ereditario ed il Duca d'Aosta.
Presentato dal senatore marchese Ferrero di Cambiano come degnissimo interprete dello Statista Canavesano, S. E. il conte CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON, Senatore del Regno, pronunziò l'orazione ufficiale, ascoltato con religioso interesse, spesso interrotto da fragorosi applausi, che, dopo l'ispirata chiusa, assunsero il tono dell'ovazione.
I Reali Principi e tutte le autorità espressero all'illustratore culto e fervido del Nigra il più vivo compiacimento. Dobbiamo all'estrema amabilità del Quadrumviro della Marcia su Roma di poter pubblicare integralmente il suo poderoso discorso commemorativo, in cui vibra costante il palpito dei più nobili sensi civili e l'amore della Patria ad ogni capoverso in forme austere e nobilissime.
Altezze Reali, Signori,
non so se gli insigni maestri che hanno voluto affidarmi l'incarico di commemorare oggi Costantino Nigra abbiamo fatto buona scelta. Dovrei affermare di no se giudicassi dallo sgomento, dal reverenziale timore che mi ha preso quando mi sono accinto a rivedere, sulle carte vissute e sui libri, la vita del Grande Ambasciatore. Dovrei invece rispondere soltanto con un senso di infinita gratitudine per la gioia che fu riserbata alla mia profonda passione di studioso, di Italiano e di Piemontese, e per l'onore di poter parlare di tanto uomo guardandolo nel tempo in cui visse,
ponendolo tra le figure del suo Signore e Re, del suo grande Maestro e Ministro Camillo Cavour, di un meno fortunato ma pur possente Ministro: Francesco Crispi.
Da così viva gratitudine e dalla gioia immensa di comunicare a voi quanto ha bevuto il mio spirito in questa comunione quasi religiosa, è superato il reverenziale timore del soldato combattente e dell'uomo di Stato che ha già ormai sei anni di vita duramente combattuta fra le più complesse responsabilità, dopo molti altri di aspro travaglio.
Tanto più viva, è la gioia e tanto più consapevole in quanto parlo alla Vostra presenza, o Principi Sabaudi, ed innanzitutto a Voi, Altezza Reale, Principe di Piemonte, mio Augusto Signore.
E ricordo glorie piemontesi, che sono tutte glorie Sabaude, mentre sono glorie Italiane, fondamenta ciclopiche, granitiche, incrollabili, della unità e della grandezza nazionale, o figlio del Re Vittorioso ed integratore della Patria, o pronipote del Gran Re.
Non sia ritenuto atto di superbia dirvi che conosco il vostro cuore, Altezza Reale, e che so come la mia piccola parola che rievoca oggi una grande figura e con essa chiama le grandissime del suo tempo, cada in spirito Augusto che ama questa nostra terra ed i suoi figli ferrigni, e non la dimenticherà.
Ho detto, Signori, che commemorando Costantino Nigra ci accingiamo a riscoprire le fondamenta incrollabili del nostro Regno, e così è.
A chi ne rilegge la vita attraverso le orme della sua immane fatica riappare direi integralmente tuttO lo sforzo compiuto dai nostri maggiori e che ci ha portati ad unità. Altre fondamenta non ha l'edificio nazionale, e, se su quelle non poggiassero sia pure le mura maestre e le chiavi degli archi costruiti di poi, nulla reggerebbe; e noi e prima di noi e dopo di noi si sarebbe costruito o si costruirebbe fatalmente sulla sabbia. Le Nazioni vivono della loro tradizione. L'Italia, dopo Roma e dopo gli splendori della Rinascenza, non trova tradizioni politiche e guerriere unitarie che nel Piemonte nostro, il quale può altamente rivendicare a sé di avere applicata per primo la teoria di
Roma che rinasc e nel Cinquecento per la penna consapevole di Nicolò Machiavelli, nella sua « Arte della Guerra ».
In quest'anno di rievocazioni non sarà mai abbastanza ricordato che Emanuele Filiberto introdusse per primo la coscrizione in Piemonte, prevenendo ogni altro Stato, fondando le gloriose Milizie paesane liberatoci dallo straniero, applicando i luminosi romani principi dell'« Arte della Guerra »!
Se ai nostri fratelli di ogni altra parte d'Italia noi possiamo lasciare il vanto pei loro migliori di tanta parte di pensiero creatore dell'unità Italiana, a noi Piemontesi, alla nostra millenaria Casa di Savoia dobbiamo tenacemente rivendicare tutta, dico senza esitazioni, tutta la arditissima azione costruttiva della Patria, che sembra miracolo a chi non ne conosce i particolari sviluppi, mentre è soltanto figlia della forza, della tenacia e di volontà veggente.
Come l'edificio regge sulle proprie fondamenta, come l'albero vive delle proprie radici, così lo spirito delle Nazioni, unica forza viva di queste, vive unicamente delle proprie tradizioni lontane,
vicine, recenti, contemporanee. Senza salde fondamenta non si costruisce l'edificio, senza robuste radici non cresce l'albero, senza i gradini di base non si sale più alto la scala. Io non credo al rinnovarsi della faccia del mondo con colpi di spugna che cancellino il passato come si cancella il gesso sulla lavagna per scrivere nuove didascalie. Le rivoluzioni stesse sfrondano l'albero delle Nazioni dai rami secchi, non creano alberi nuovi; così fu nei vari secoli della potenza dì Roma, così fu dopo la stessa immensa rivoluzione cristiana tanto che oggi invochiamo a gran voce ancora le pure fonti di Roma. Così fu dopo la rivoluzione francese le cui stesse fronde demagogiche siamo costretti a demolire per ritornare al tronco saldo dello Stato forte ed autoritario. Così è del Risorgimento, dell'opera unitaria della Patria, a cui è a mio avviso assolutamente necessario riallacciarsi oggi, sfrondando tutti i rami sinistri, per riprendere la costruzione del nostro edificio, che, splendido, andiamo innalzando con infinita passione, basandolo sui pilastri che, il Conte di Cavour ideò, e di cui il Conte Costantino Nigra fu uno dei discepoli, degli artefici più possenti, .più veggenti, e più operosi.
Non voglio con ciò richiamare in vita le discussioni di qualche anno addietro, invero deplorevoli, nelle quali gli uomini delle più sinistre deviazioni dalle formidabili fondamenta del Risorgimento credevano di poter ipotecare per tornaconto politico contingente l'opera di questi nostri grandi maggiori, cristallizzandola in banali luoghi comuni, chiudendola nel barattolo di uno o dei partiti, obliando che sulle solide fondamenta, dalle possenti radici possono poggiare o rampollare le più nuove, più vive, più dense di vita e possibilità, forme svariate e leggiadre.
Voglio invece ricordare qui l'episodio significativo coi quale uno storico francese Ambasciatore apre un suo nuovissimo profilo di Cavour, il grande realizzatore. Racconta egli (Maurice Paléologue) che un Principe straniero Altezza Imperiale, poco studioso di storia e per nulla al corrente delle cose nostre, fosse accompagnato in un certo anno dal nostro Augusto Re Vittorio Emanuele III a visitare le vestigia dell'antica Roma e, attraversando i Prati di Castello, e leggendo sopra la caserma il nome di Cavour, abbia chiesto la spiegazione di questo nome, aggiungendo
dovere egli supporre che fosse il nome dell'architetto costruttore, « Certamente — dice lo storico francese — rispose il Re, fu un architetto, un celebre architetto. Fu lui a costruire l'Italia!».
Voglio, sulla Augusta testimonianza, affermare che quanto di ciclopico fu costruito anche col quadriennale immane sforzo di sangue e di passione a Vittorio Veneto, quanto fu conservato da certa rovina, dopo quadriennale immane sforzo e sanguinoso di pochi, con la Marcia su Roma, della quale mi onoro di essere stato uno degli artefici agli ordini del mio Capo ed al servizio del mio Re, perché il nuovo edificio divenga veramente degno della architettura di Roma in tutti i suoi sviluppi, poggia sulle fondamenta costruite da questi nostri formidabili uomini, i quali si sono a loro volta riallacciati alla rupe indistruttibile, eterna della sapienza e dalla potenza di Roma.
La storia di popoli può avere delle soste anche lunghissime, delle deviazioni, dei regressi, non ha mai dei salti, delle soluzioni di continuità, delle creazioni improvvise specialmente pei figli della forza e del diritto di Roma.
E' perciò, Altezze Reali, che, commemorando oggi Costantino Nigra e bevendo un sorso di acqua limpidissima, come a pura sorgente montana, alle fonti inesauribili del nostro Risorgimento, io sono ben certo di cantare, sia pure colla mia piccola voce, un inno di gloria al mio Piemonte incrollabilmente sabaudo e guerriero, e di glorificare insieme il Risorgimento della Patria, il cui spirito unitario, oggi nello ingrandimento di potenza più necessario che mai, riposa nella storia della Vostra Augusta Casa, di questa nostra terra fedelissima, degli uomini che la Unità Italiana costruirono avendo nel cuore e sulla bocca il nome fatidico di Vittorio Emanuele, avendo davanti allo sguardo la visione fatidica di Roma Eterna. Io penso che questa visione storica debba soprastare ad ogni atto della nostra vita civile, guidare la nostra marcia per la difficile via, senza che la visione delle cose inutili o vane della cronaca, ed il frastuono a volte assordante della politica contingente, possa arrestarci, o farci dondolare come un pendolo, senza che i piccoli uomini, creatori delle piccole cose, riescano a farci deviare.
Per trovare le vie nuove Io sono certo che basta proseguire oltre l'antica in senso perfettamente lineare. Terribile sarebbe fermarci nel sonno. Di fianco al sonno vigila la morte. Terribile sarebbe perdere la via e vagare per la boscaglia delle cose vane o delle cose turpi.
Della via antica una delle pietre miliari è Costantino Nigra. E serve benissimo di allineamento per le vie nuove.
LLaa vsiutaa dvii tCa ostantino Nigra è lineare ed è tutta una luce.
Egli nacque a Villa Castelnuovo sopra Castellamonte sulla prealpe ricca di castagni e di sorgenti, nel nostro bel Canavese, dove, come nell'Umbria verde cara al Poeta, con le polle dei fiumi nasce la poesia. Nacque Costantino Nigra l'11 giugno 1828 or fa cent'anni da Ludovico Nigra chirurgo e soldato e da Caterina Revelli. E fu nella sua, ardente anima, pensoso come un filosofo, studioso ed analitico come un ricercatore di scienze esatte. Nacque e fu, finché la giovinezza gli sorrise, di classica bellezza come un Adone.
Compiuti gli studi elementari in Castellamonte e superati quelli classici a Cuorgnè ed .a Torino, riuscì vincitore di una delle Borse del Collegio delle Province ed entrò nella Regia Università dedicandosi alle discipline giuridiche. Quando nel 1848 Carlo Alberto Re concesse lo Statuto lanciando il guanto all'Austria, Costantino Nigra ventenne lasciò l'Ateneo e corse alle armi volontario nella compagnia dei Bersaglieri Studenti comandata da quel Luogotenente Cassinis biellese cui, fatto Maggiore, era riserbata sette anni più tardi una eroica morte in Crimea.
E combatté sotto Peschiera, a Santa Lucia, a Calmasino, ai monti della Corona, e finalmente alla battaglia di Rivoli, dopo essere stato eletto caporale dai suoi compagni che per gli statuti della compagnia ne avevano facoltà, mentre guidando la sua squadra all'assalto rimase ben gravemente ferito al braccio. Rientrato, completò gli studi, e nel 1851 veniva assunto al Ministero degli Esteri come volontario prestando servizio senza soldo per ben due anni. Severo durissimo inizio cui i nostri antichi governi sottoponevano chiunque volesse intraprendere servizio governativo pure in quei tempi di rapide, e talvolta rapidissime, trasformazioni dello Stato e che non impediva di giungere presto ai supremi uffici, come: per altro vi giunse il conte Nigra; ma che costringeva tutti a giungervi senza improvvisazioni, convenientemente preparati, solidissimi nella cultura che giace nei sedimenti dello spirito pronta a creare i sicuri giudizi, le improvvise deliberazioni, senza i pericoli gravissimi che la sola intuizione e l'autodidattismo presentano. Avvenne che nell'estate del 1851 Massimo d'Azeglio, ferito gravemente all'assedio di Vicenza da un proiettile all'addome, doveva per ordine dei medici recarsi ai bagni di mare. Egli, Ministro degli Esteri, chiese in quella occasione al Direttore Generale del Ministero che gli designasse un giovane impiegato il quale gli servisse da
segretario specialmente per il disbrigo della corrispondenza. Fu destinato Nigra, che qui ebbe modo di far brillare in tutta la sua luce le eminenti qualità del suo ingegno e del suo cuore. Di ritorno dai bagni Massimo d'Azeglio continuò a tenere Nigra addetto al suo Gabinetto di Ministro concedendogli affettuosa confidenza; talché, andata sposa una sua figliuola col marchese Ricci, Costantino Nigra scrisse un caldo Epitalamio il quale, oltre che l'approvazione del suo Ministro letterato, ebbe anche la lode di Alessandro Manzoni.
Quando nel 1853 il conte di Cavour entrò a far parte del Gabinetto d'Azeglio al dicastero d'Industria e Commercio esplicò la sua mirabile attività con la stipulazione di molti trattati internazionali.
Essendo la materia di comune competenza degli Esteri e dell'Industria e Commercio, Massimo d'Azeglio incaricò Nigra di mantenere il collegamento fra i due Ministeri. Avvenne così che Cavour più volte consegnasse al giovane diplomatico la grezza materia o, meno ancora, gli esponesse semplicemente il suo punto di vista, e che questi gli redigesse note e progetti in forma diplomatica perfetta di stile e con chiara traduzione dell'idea del grande Statista, tanto che questi ne ebbe tosto viva stima e simpatia. Quando Cavour succedette a d'Azeglio, nella Presidenza del Consiglio e nel Ministero degli Esteri, trattenne presso di sé Costantino Nigra già da lui conosciuto ed apprezzato e
dal d'Azeglio ancora segnalato e raccomandato.
Da allora Nigra diventa il braccio destro del grande Statista e noi lo troviamo ovunque Cavour ha un problema grave da risolvere, ovunque è un documento importante da stilare, ovunque è un pericolo da superare.
Nel 1855 Nigra, segretario, segue il grande Ministro nel viaggio di accompagnamento di S. M. Vittorio Emanuele II a Parigi ed a Londra. Nel 1856 Nigra è a Parigi al seguito di Cavour durante il Congresso e come Capo Gabinetto si moltiplica in modo prodigioso tenendo tutta la corrispondenza. Ritorna a Parigi nel 1856-57 con temporanei incarichi del suo Capo. Nel 1858 Nigra lo accompagna al convegno di Plombières, indi rimane a Parigi quale agente segreto per i rapporti diretti fra l'Imperatore Napoleone III, il Re Vittorio Emanuele e Cavour.
Rientra nel 1859 dopo di aver agito anche al di fuori ed al di sopra del Ministro a Parigi marchese di Villamarina ed assiste al tragico dolore di Cavour, alle sue discussioni col Re nello incidente tempestoso di Monzambano ed allo intrecciarsi stranissimo degli avvenimenti dopo la pace di Villafranca. Nel febbraio del 1860 già Incaricato d'Affari, gli viene affidata la reggenza della Legazione di Parigi, Legazione che non lascerà più, fatto più tardi Ministro Plenipotenziario e quindi Ambasciatore, fino al 1876. Nel frattempo durante la prima occupazione provvisoria di
Napoli sarà alla testa dell'amministrazione quale Presidente del Consiglio dei Ministri.
Durante i suoi sedici anni di permanenza a Parigi, sotto l'Impero e sotto la Repubblica, rese all'Italia nostra servizi incalcolabili che verrò a grandi tratti descrivendo per quanto la brevità riassuntiva di una conferenza di commemorazione lo può consentire. Nel 1876 la Sinistra storica dava, e non per ventura delle sorti d'Italia, la scalata al potere; ed Agostino Depretis trasferiva l'Ambasciatore Nigra a Pietroburgo. Dopo sei anni di permanenza a Pietroburgo Nigra passava a Londra e di qui a Vienna, che, colla stipulazione della Triplice Alleanza, era diventata per l'Italia la capitale ed il centro diplomatico più importante d'Europa.
Lasciò in verde vecchiezza la carriera diplomatica dopo cinquantanni di opera gloriosa nel periodo del Risorgimento e del consolidamento del Regno.
Morì a Rapallo il primo luglio 1907, nell'età di 79 anni, quando la sua vecchiezza pareva ancora rinverdire e doverlo conservare lungamente, come le cose sacre, alla nostra ammirazione, al nostro fervido amore di piccoli discepoli, di Italiani; e sopratutto alla nostra orgogliosa passione di Piemontesi, fieri di lui come di tutti gli artefici principali del nostro Risorgimento.
Aveva meritato i massimi onori e la benevolenza dei nostri Re glie li aveva concessi. Oltre che Ambasciatore era stato fatto Conte con titolo trasmissibile agli eredi ed insignito dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata , le cui sole insegne lo accompagnarono fino all'estrema dimora benché il suo medagliere, fosse ricco di oltre ottanta decorazioni. Dalla dolce riviera ligure la sua salma gloriosa fu trasportata per l'estremo riposo in Villa Castelnuovo, ritornando così alla terra fresca di fonti e di poesia che aveva uditi i suoi primi Vagiti, che era stata il suo sogno
nostalgico durante le più aspre e pericolose fatiche, che aveva rappresentato, insieme col ritmo delle nostre canzoni, a lui tanto care, l'oasi di riposo dal tumulto delle passioni in mezzo alle quali aveva trascorso combattendo la vita.
INl iPgroae tfau. un poeta.
La terra del Canavese dove egli nacque, la terra di Giuseppe Giacosa, di Guido Cozzano e di Salvator Gotta, è ricca di poeti. Fu un poeta che sentì la infinita armonia che sale verso il cielo da questa nostra contrada irta di monti e d'armi, fragorosa di fiumi balzanti per le rupi in fiocchi di spume ed in potenza di energie, come il suo, come il nostro « Orco » magnifico e possente; fragorosa di canti, che segnano il passo ai battaglioni o nel ritmo lento e nostalgico carezzano nel più profondo la nostra malinconia di montanari. Lascio le cose minori e ne cito tre sole possenti e bastevoli a non lasciar morire nel tempo la poesia mirabilmente nostra, tutta nostra, di Costantino Nigra ; « La Rassegna di Novara »; « Gli Idillii ». La pubblicazione dei « Canti popolari del Piemonte ».
La Rassegna di Novara non può essere letta da qualunque soldato del Re senza che il cuore acceleri così forte nel petto il ritmo dei propri palpiti da non esservi più contenuto; e senza che la gola si chiuda, tanto profonda è l'emozione che suscita. Io stesso, figlio della guerra, non so, rileggendolo, trattennero le lacrime. Non vi è una riga di retorica in tutto il canto che esalta la sacrificale eroica figura di Re Carlo Alberto, il quale nella notte precedente il dì dei Morti, passa sui campi della vendicata Novara, in fantastica rassegna, le ombre dei soldati della indipendenza d'Italia. E' mirabile la invocazione che il poeta fa all'anima della Patria, ormai unita per una sua così vasta
collaborazione con Roma capitale, e per sempre. Anima eterna ;
Del mio paese! A me nell'arso fianco
II tuo possente anelito trasfondi,
Fammi udir dalle schiuse sepolture
La tua gran voce; e tu m'inspira ,il verso
Che fa santa la tomba, ed immortale
II lauro ai forti per la Patria estinti.
Tanto è viva ancora questa poesia che, rileggendola, i figli di Vittorio Veneto non possono se non rivedere i settecentomila che, morendo, Vittorio Veneto crearono, e fecero l'Italia degna di Roma per la gloria del Re.
E' celebre di questo canto la esaltazione dei Carabinieri Reali, che non fu mai fatta con così poche parole né prima né poi e con tanta completa e definitiva efficacia:
Del Re custodi e della legge, schiavi
Sol del dover, usi ubbidir tacendo
E tacendo morir, terror dei rei
Modesti ignoti Eroi, vittime oscure
E grandi, anime salde in salde membra,
Mostran nei volti austeri, nei securi
Occhi, nei larghi lacerati petti,
Fiera, indomata la virtù Latina.
Risonate, tamburi; salutate,
Aste e vessilli. Onore, onore ai prodi
Carabinieri!
Formidabile poesia militare del combattente del 1848-49, de] ferito di Rivoli Veronese, e che il nostro grande maestro Carducci ebbe a lodare senza riserve anche attingendovi largamente. « Gli Idillii » furono pubblicati nel 1893 sulla Nuova Antologia e raccolti poi in un fascicoletto a parte edito dalla tipografia della Camera dei Deputati. Sono i mesi di giugno, di settembre, di novembre nella nostra terra. E' la raffica della tempesta, sono le Alpi e risaie con le montanine alla monda del riso, è la campagna Romana con la maestà del suo silenzio, dei suoi ricordi, dei suoi pastori e dei suoi butteri. C'è tanto umanesimo in questa poesia classica e piena di vita, c'è tanta passione e c'è tanto cuore, espressi in impeccabile correttezza di stile, e c'è tanto respiro di piena italianità da lasciare profondamente pensoso ed ammirato il lettore. Ecco il nostro pastore a novembre :
Ritto, appoggiato sul bastone,
come sentinella fantastica:
sta il pastor col cappuccio in su le chiome
immoto all'intemperie.
Nella tasca ha la povera sua .mensa,
dura ha la faccia ed ebete,
non favella, non opera, non pensa,
guata stupido ai nuvoli.
Ma dalla pieve suona il vespro.
Ei piega nel fango le ginocchia
e si fa il segno della Croce e prega.
Cade lenta la pioggia.
Ed io sono certo che quel pastore era il maggior fratello del soldato ignoto.
I Canti popolari Questo volume p udbebl lPiciaetmo odnatl eN. igra nel 1888, contiene una raccolta che oserei chiamare completa di tutti i canti popolari della nostra regione. L'averli riuniti, studiati, trascritti, pubblicati ed
esaminati nelle fonti, sia alla storia, sia dello spirito popolare, costituisce alta opera di letterato poeta ed atto di appassionato amore al nostro Piemonte.
Rileggendoli, per seguire in tutte le sue espressioni l'opera fervida del Grande Piemontese, io vi ho ritrovato tutti i canti della mia giovinezza; dalle cantilene infantili, alle rime ed ai giochi di quando ero fatto più grande, alle cantate in campagna delle fienaiole e della spigolatrici della pianura torinese « dalle guance fresche e dalle chiome ricce » care anche a Pastonchi, fino alle montanine pastorelle delle nostre valli tutte, del suo bel Canavese pieno d'amore, del mio forte Monferrato.
E come il vento delle valli, come il profumo dei pini, e dei ciclamini, e del fieno fresco, e come il canto del rusignolo, e come il frinire delle cicale, ci sono le storie della nostra Casa di Savoia, e le Sue e le nostre glorie, e le canzoni di guerra, e quelle della passione amorosa che, in alto ed in basso, scuote, squassa, schianta i cuori degli uomini. Io vorrei bene portarle qui tutte oggi perché respiraste con me lo stesso intenso profumo di poesia come Egli l'ha respirato e ce l'ha trasmesso per la nostra gioia, per i nostri ricordi, per gli Dei Lari della nostra terra, per lo studio vivo nella tradizione della nostra storia. Non lo posso e me ne duole.
Ma qualcuna debbo pure rievocarne di queste poesie. Il ritorno del soldato. (Com'è eterna e sempre uguale nel suo rinnovarsi la vita!).
Lu Re j'à scrii na litra: an guera venta andè.
La povra mitressa ni fa che tant piurè!
Piurè pa tant mitressa, piurè pa taut de nui
Al fin de la campagna si spuzeran nui dui.
Ma al ritorno dalla campagna il soldato rientra e batte alla porta.
Mi dorbo 'pa la porta, la porta dorbo 'pa,
I vu spetà óet ani, con n'aut son mariclà;
ed il soldato Piemontese... si rassegna!
Da già ch'sei marideja, tucàime ancur la man
Mi turnerò a la guera, mai pi nui se vedraii.
Un'altra volta a sostituire il padre vecchio in guerra va la bella figliola; ed anch'essa vi sta sette anni e ritorna, la vergine guerriera, onusta di gloria, fiera di aver servito. Anche qui :
Lu Re jà scrit uà litra, na litra sigila:
bun ve; de sesantani l'à ct'andè a fé '1 salda.
Qosa -piureivo pare, cosa piureivo vui,
Piursi, d'andè a la guera? n'andarò mi per vui.
Deime 'n cavai morelo ch'am posa ben porte.
E la vergine guerriera combatte e sospettata del suo sesso, è sottoposta a tutte le prove e le supera,
ed al fine, vinta la guerra :
Bela munta a cavalo, s'a s'è butà a c-antè:
— Fieta travestia, servì set ani al Re. —
E l'amore? L'amore, per la bella montanina, risponde a tutto. Nigra, bellissimo e
fortunatissimo, se ne intendeva :
Mare maridaìme cust'an, ma maridaì-me daime Giuan.
Ma Giuan l'à nin del pan. Tra nui dui n'an faran.
Ma Giuan l'à nin dal vin. E beivran al funtanin.
Ma 'Giuan l'à nin 'di ca. Durmiran an s'la travà.
Ma Giuan l'à nin d'iinsoi. Durmiran sui canavoi.
Ma Giuan l'à nin 'd'vestì. Na saran tant pi ardì.
Bellissime sono le rievocazioni dell'assedio di Verrua Savoia, che quello più antico del 1387 gloria di Savoia ai tempi del conte Rosso :
Quando questo crino pigliarà 'l'uva
il Marchese di Monferrato piglierà Verruva.
E la canzone popolare raccolta e tradotta dal Nigra recita :
Castello de Venia s'a l'è tant bin piantà
piantà su cule roche ch'ai pasa l' Po da là.
La bela a la finestra an bas l'a risguardà
l'a vist venì na 'barca carià de gent armà
cun 'l'arme ch'ai lüzio ch'a smiavo n'dorà.
La bela tira na pera, la barca l'è sperfundà
Na füssa d'cula pera Verüa saria pià
Saria pià Verüa castel dal Monferà.
E' ben nota la. storia del Principe Tommaso di Savoia ed è noto il suo primo contrasto per togliere la Reggenza a Madama Reale Cristina di Francia donde la guerra che desolò la terra Piemontese fra il 1639 ed il 1642, e della quale, nelle ansie e nei consigli, sembrano ancora risuonare le sale di questo Augusto Palazzo, come è noto che egli, nato dal sangue di Grandi Guerrieri e di Grandi Re quali erano Emanuele Filiberto, Francesco I e Carlo V, rionciliatosi colla Duchessa Reggente, diventò poi generalissimo delle forze riunite di Savoia e di Francia in Piemonte, e fu uno dei
migliori Capitani del suo tempo. Ma, ai tempi della guerra civile, il Piemonte, sempre legittimista, sosteneva la Duchessa Reggente. Il canto trasmessoci da Costantino Nigra ci prova come in mezzo alle miserie dei tempi, non venisse mai meno, nella serena e paziente nostra razza, il buon umore nativo :
Prinse Toma ven da Milan cun na brlgada da scausacan
scausavo da dsà, scausavo da dlà. Viva la brigada d'Prinse Toma.
Prinse Toma ven da Versei cun na brigada da spaciafurnei
spaciavo da dsà, spaciavo da dlà. Viva la brigada d'Prinse Toma.
Prinse Toma ven da Civass cun na brigada da sciapasass
sciapavo da dsà, sciapavo da dlà. Viva la brigada d'Prinse Toma.
Prinse Toma ven da Brandiss cun na brigada d' ramassamniss
ramaso da dsà, ramaso da dlà. Viva la brigata d'Prinse Toma,
Prinse Toma rüva da Turin cun na 'brigada da spaciacamin
spaciavo da dsà, spaciavo da dlà. Viva la brigaida d'Prinse Toma.
Parlando di Nigra poeta ed interprete fedelissimo dell'anima Piemontese, l'argomento mi porterebbe troppo lontano, tanto ne sono preso e tanto domina il mio spirito, ma ho ancora da dirvi di Nigra cooperatore al grande edificio dell'unità d'Italia, di Nigra diplomatico, discepolo di Camillo di Cavour.
Il miracolo dell'Unità Quest'aula, Altezze Re aNlia, zSioignnaolrei., deve prima ricordare alla nostra reverente devozione i due fatti salienti della unità nazionale a cui Costantino Nigra cooperò colla pattuglia di punta, aiuto primo del suo grande Ministro e maestro, servitore fra i primi dei suo gran Re. In quest'aula risonò il grido di dolore che Re Vittorio Emanuele II raccolse nel suo discorso gigante del gennaio 1859. In quest'aula, fatta sacra alla storia, fu proclamato nel 1861 il Regno d'Italia e furono, Altezze Reali, consacrati quei legami fra Re e Nazione che la gloriosa Vostra Dinastia mantenne intatti fra ogni fragore d'armi, fra ogni turbinare delle più opposte passioni e delle più alterne vicende della storia.
Quest'aula, Signori, che non è una anticamera, sia pure storica, fu testimone di un gesto di tanta grandezza, preparatore immediato e certo della conquista dell'Urbe fatale, dove Savoia matura nel tempo e nella fatica, e pel veggente sacrificio della nuova recentissima Marcia, i destini del nuovo Impero. Matura nel tempo e nel sacrificio, Altezza Reale, i destini di Roma che saranno rinnovati nel nome di Savoia.
Concedete, Signori, al soldato fedele del Re, al Quadrumviro della Marcia su Roma, al senatore fascista mutilato immeritatamente fatto Consigliere della Corona, l'onore di esaltarsi in questa certezza, parlando in questo luogo Augusto, dopo di avere servito Re e regime per lunghissimi anni lontano. E concedetegli di rievocare qui, oggi, i fantasmi del passato così grandi, se anche egli è di troppa pochezza per esserne degno.
Perché la commemorazione di Costantino Nigra richiama tutti gli spiriti del passato, da quello del Re Padre della Patria, a quello di Camillo di Cavour, a tutti gli altri minori coi quali del guanto lanciato per la guerra del 1859, della formazione del Regno nel 1861, della stessa prima conquista di Roma fu stretto indispensabile collaboratore.
Molto opportunamente la molto benemerita Commissione Reale Editrice del Carteggio Cavour-Nigra, presieduta da S. E. il senatore Boselli, lo divise finora in tre volumi organicamente raggruppando le lettere intorno a tre avvenimenti fondamentali: 1° Plombières; 2° la Campagna del 1859; 3° la cessione di Nizza e della Savoia, le annessioni e da proclamazione del Regno d'Italia. In
questi tre periodi la stessa figura gigante di Cavour e del suo Re non possono essere disgiunte dalla luminosa e veggente figura del Nigra. Prima di Plombières e dopo il viaggio di Re Vittorio a Parigi ed a Londra che avevano avuto grande successo, il Generale della Rocca, mandato a Parigi in speciale missione, si era dimostrato non perfetto diplomatico. L'Imperatore gli aveva tenuto un linguaggio forte dopo l'attentato Orsini con incarico di ripeterlo a Re Vittorio Emanuele. Chiedeva misure, restrittive e di duro governo al Piemonte, minacciava quasi senza veli di unirsi strettamente all'Austria, pronunciava parole appena rispettose nella forma. E' di questo tempo (febbraio 1858) la
formidabile risposta del Gran Re che Cavour trovò modo di far leggere più o meno riservatamente allo stesso Imperatore. Quella risposta, portata fino all'epilogo di pugno del Conte di Cavour, ha la sua chiusa coi caratteri di Costantino Nigra, segretario e consigliere, che la scrisse certamente sotto la dettatura di Re Vittorio e che è di per se sola un poema del Sovrano Sabaudo :
« Dopo quanto vi ho detto, caro La Rocca, l'Imperatore deve essere ben persuaso delle mie buone intenzioni e deve vedere che i fatti hanno avuta una esecuzione prima che egli me ne facesse domanda. Se egli mi chiedesse qui delle violenze io perderei tutta la mia forza ed egli la simpatia e l'affetto di una generosa e nobile Nazione.
Non fate l'imbecille, caro Generale, ditegli tutto ciò da parte mia e se le parole che voi mi trasmettete sono le parole testuali dell'Imperatore ditegli nei termini che crederete migliori che non si tratta così un fedele alleato, che io non ho mai tollerato violenza da alcuno, che io seguo la via dell'onore senza macchia, e che di questo onore io non rispondo che a Dio ed al mio popolo, che sono 850 anni che noi portiamo alta la testa e che non vi sarà alcuno che ce la farà abbassare; e che dopo tutto ciò io non desidero altra cosa che essere, suo amico ».
Fierissime parole, che Nigra ebbe la ventura e l'onore di raccogliere colla sua penna, e che portarono dopo la dettatura la firma dell'Augusto Re. L'Imperatore che le lesse non se ne ebbe per male ed il linguaggio forte e fermo di Re Vittorio non dispiacque al terzo Napoleone, che da indi innanzi fino al '70 usò termini accettabili da un Savoia.
Ma dopo Plombières della Rocca e Villamarina non bastavano più ed a Parigi rimase, negoziatore segreto, Costantino Nigra; per il quale, allora non più che trentenne, una così alta precedente scuola aveva dati i suoi frutti. E' supremamente interessante ed istruttivo seguire il carteggio Nigra-Cavour nel periodo preparatorio della guerra del 1859, sia per l'importantissima parte che « quel segretario Nigra », come ebbe a chiamarlo allora Re Vittorio Emanuele, vi ebbe, sia per le doti che questi vi rivelò di infinita abilità non disgiunta da ardimenti che oggi potrebbero anche essere chiamati temerari; sia per gli sviluppi e per le rivelazioni degli avvenimenti storici in quel tempo verificatisi, sia infine per l'esame delle grandi figure del tempo. Una delle più importanti prove di stima e di
affetto del suo Ministro se la ebbe Costantino Nigra quando, oltre a tutti gli altri problemi relativi all'intervento francese e specialmente alla scelta del momento, gli fu affidata la trattazione di quello fondamentale per Napoleone III del parentado fra le due Case e che portò al nobilissimo e sacrificale gesto di offerta alla Patria della Principessa Clotilde, nuova santa di Savoia e d'Italia. Il 28 novembre 1858 scrive Cavour a Nigra :
« Raccomando in specie di non lasciar venire Niel (il Generale) colla missione di trattare apertamente il matrimonio. Si correrebbe il pericolo di rovinare ogni cosa. Ciò sarebbe crudele mentre siamo ad un presso certi della riuscita ».
E più sotto :
« Stante le proposte che Niel deve farci e l'indole del negoziatore, divido pienamente l'opinione sua sulla necessità di avere, mentre questi sarà a Torino, una persona a Parigi che possa mantenersi in continua comunicazione coll'Imperatore. Questo individuo deve godere tutta la nostra fiducia, ed ispirare confidenza all 'Imperatore, essere sommamente abile e del pari devoto alla causa Italiana. Malgrado i rari e numerosi requisiti che esso deve avere io non ho alcuna fatica a ritrovarlo; senza che io meni vanto per ciò di molta perspicacia, giacché questo individuo lo avevo sotto le mani, nella persona di lei, mio carissimo Nigra. Poiché è una necessità mi rassegno a lasciarla a Parigi
finché non siano spianate le difficoltà che le negoziazioni faranno sorgere. Questo sacrificio mi costa molto; poiché quando ella è lontano da me, mi sento mancare il più valido mio appoggio, ma lo faccio senz'esitazione, qualunque ne siano le conseguenze per me. Dal suo canto sacrifichi la modestia e le considerazioni personali al supremo interesse del Paese ».
E Nigra naturalmente ubbidisce. Ho voluto qui far parlare direttamente, per la sua penna, il Conte di Cavour per precisare quali fossero già sulla fine del 1858 i rapporti fra il grande statista ed il suo trentenne valoroso segretario, e quale fosse l'apprezzamento che il primo faceva del secondo. Vi sarà alcuno che si domanderà come potesse coesistere un tale negoziatore a Parigi, che godeva la piena ed intera confidenza del Ministro degli Esteri e Presidente del Consiglio, con la presenza nella stessa Capitale del Ministro di Sardegna che era allora il marchese di Villamarina. Rispondo subito che questi fenomeni sono sempre avvenuti in tutti i tempi di opere intense, di febbrili costruzioni, di creazioni geniali, e, richiamandomi a quanto ho avuto l'onore di dire poco fa, aggiungo che chi se ne scandalizza o eleva mormorio e clamori, prima di ogni altra qualità negativa dimostra quella di non conoscere la storia; la quale i Romani conoscendo assai bene erano indotti a dire che niente vi ha di nuovo sotto il sole. E qui non era Cavour che agisse soltanto di sua iniziativa magari alla insaputa del Re. Anche ciò avrebbe potuto perfettamente esistere nell'ordine delle cose perché più volte Cavour agì di sua iniziativa e più volte Re Vittorio Emanuele fece la stessa cosa in senso parallelo o divergente dall'opera del suo Primo Ministro. Ma qui invece la presenza di Nigra a Parigi e la sua altissima missione erano contemporaneamente volute da Cavour, dal Re e dall'Imperatore; e come tutta la battaglia combattuta per decidere la Francia all'intervento a Torino aveva un nome solo: Cavour, donde al servizio del Re promanava l'intera azione; a Parigi aveva un nome solo: Nigra. Tutte le altre figure erano dominate e soverchiate. Il Marchese di Villamarina era addirittura all'oscuro della parte che stava compiendo Nigra in assoluta segretezza, tanto che le stesse lettere di istruzioni, di scuola e di consigli che Cavour gli mandava con grandissima
frequenza, venivano a periodi restituite al Ministro.
« Le rimando qui tutti i dispacci e tutte le lettere che V. E. mi scrisse, a seconda delle di lei istruzioni. Nel separarmi da questi documenti pericolosi, parmi che un grave peso mi si tolga dalle spalle. I segreti dei Re sono come certi liquori venefici, che spesso rompono il fragile vetro che li rinserra ».
E venne il giorno in cui il Nigra, nell'epoca del discorso della Corona del gennaio 1859 concordato fra i due Sovrani alleati, ed in cui si stringevano i nodi per la sublime offerta di se stessa alla Patria della Principessa Clotilde, dovette pur richiedere al suo Ministro che qualcosa di quanto si passava volesse far conoscere al Ministro del Re a Parigi. Il Marchese di Villamarina, che era d'altronde un ben degno gentiluomo, naturalmente se ne adontò, e Camillo di Cavour lo calmò con una lettera che è di per se stessa un monumento e che venne comunicata in copia anche al Nigra con queste espressioni :
« Le mando copia della lettera, che scrivo a Villamarina perché ella sappia regolarsi. Ella la conserverà perché io non ho creduto opportuno di farne copia qui. Se per caso pensasse di insistere io lo richiamerei senz'altro. Il Re è furibondo contro di lui, egli voleva per forza che io impiegassi con lui la famosa frase di cui Sua, Maestà si è servito col Generale « la Rocca»: «Non fate l'imbecille». Ella vedrà che io sono stato molto più dolce ».
Ed al Marchese di Villamarina scriveva :
« Caro Marchese, debbo dirle che il suo telegramma del 1° dell'anno mi ha altrettanto sorpreso che afflitto. Io non posso capire e non capisco ancora come dopo le confidenze senza riserve che le ho fatto ella possa vedere con occhio suscettibile e geloso la missione che il Re ha confidato al Signor Nigra. Io le ho partecipato che l'Imperatore aveva voluto trattare direttamente le questioni del matrimonio, del trattato di alleanza e della guerra col Re e con me. Io non discuto se sia bene o male, ma questo è certo che dal momento che egli ha manifestato a questo proposito una volontà noi dovevamo uniformarvici». E la lettera si chiude così: «Ella può contare sulla mia amicizia come io conto sulla sua devozione al Re ed al Paese. Io sono pronto a fare quanto è nelle mie possibilità per aderire ai di lei desideri, dirò alle di lei esigenze; ma io non posso e non debbo mettere in pericolo un'opera immensa alla quale noi lavoriamo da molto tempo, per una questione di amor proprio ».
E Villamarina, nobilissimo, ubbidì e rimase.
Intanto si era maturato il discorso della Corona che fu redatto nella prima minuta in accordo con Re Vittorio Emanuele II dal Conte di Cavour ed al quale pose mano Costantino Nigra per la parte che riguarda i progetti di legge da esaminarsi in Parlamento. Questa prima minuta autografa di Cavour fu trasmessa al Nigra a Parigi che la rimise a sua volta all'Imperatore. Questi trovò troppo ardita la chiusa, che, dopo la famosa frase: "e confortati dall'esperienza del passato aspettiamo prudenti e decisi le eventualità dell'avvenire", suonava precisamente così :
« Qualunque esse siano ci trovino forti per la concordia e costanti nel fermo proposito di compiere, camminando sulle orme segnate dal Magnanimo mio Genitore, la grande missione che la Divina Provvidenza ci ha affidato ». Napoleone III propose una nuova versione la quale fu adottata ed alla traduzione della quale si provarono Gavoni e Rattazzi con testi ben noti che sono lontani dalla vibrante efficacia dell'ultima versione a correzione autografa di Re Vittorio. « Quest 'avvenire sarà felice la nostra politica riposando sulla giustizia, l'amore della libertà e della Patri. Il nostro Paese piccolo per territorio acquistò credito nei Consigli dell'Europa perché grande per le idee che rappresenta, le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli. Giacché nel mentre noi rispettiamo i trattati non siamo insensibili al grido di dolore che da tante partì d'Italia si leva verso di noi. Forti per la concordia, fidenti nel nostro buon diritto aspettiamo prudenti e decisi i decreti della Divina Provvidenza ».
Fiere e sublimi parole queste che ci prendono ancora di più nell'ambiente nel quale sono state allora per la Regale Bocca pronunciate, ma come ognun vede il testo parigino ed imperiale, così efficacemente tradotto e già opportunamente ritenuto come il guanto di sfida dall'Austria, era di gran lunga meno ardito, meno vibrante del primo testo nel quale il Gran Re avrebbe proclamato alto e forte davanti al mondo il suo fermo proposito dì riprendere la marcia per la stessa strada sulla quale era caduto il Re Martire, marcia che veniva chiamata la grande missione affidata dalla Divina Provvidenza. Questo, con una frase che io conosco bene e che ha avuto grande fortuna, si chiamerebbe oggi : Gettare l'anima oltre il reticolato nemico. E fu gettata con l'anima del Re, con l'anima di questi grandi, l'anima d'Italia, e venne raccolta undici anni più tardi sui sette colli di Roma.
Napoleone III tergiversava, le sue tergiversazioni avevano le stesse fondamenta che crearono più tardi la improvvisa e tanto deprecata pace di Villafranca. Troppo lungo sarebbe descrivere qui tutte le oscillazioni, tutti i timori, tutte le preoccupazioni di Cavour a Torino e di Nigra a Parigi. Il carteggio di questo periodo fra i due grandi, il Maestro ed il discepolo, è come la grande luce di un sole che percorre l'arco del cielo in una giornata d'estate.
Tutto viene messo in opera al servizio della Patria per raggiungere un sogno e renderlo realtà, per operare il miracolo. In questo combattimento politico è fra gli assalitori in primis-sima linea persino l'amore. Si vince; ma quante ansie, quanta passione sacra, quanto dominio degli avvenimenti e degli uomini di Francia indubbiamente meno forti e minori dei nostri grandi! Quanto ardimento guerriero, pure in questo sottile gioco di diplomazia nella Corte di Francia! Nel marzo 1859 il discepolo, combattente contro l'opinione pubblica francese ostile alla guerra,
scrive al Maestro:
« Non vi è che un modo per mutare questa opinione pubblica, e questo modo bisogna cercarlo non nei giornali, non nelle pubblicazioni più o meno favorevoli alla guerra, ma nei fatti. Il modo mirabile con cui si comportano i popoli d'Italia fece di già ottima impressione in Francia. Come le dissi in altra lettera si nota qui un miglioramento nella opinione. Anche in Inghilterra l'orrore della guerra si va calmando. Io credo che senza attendere oltre istruzioni e concerti, appena scomparse le truppe Austriache dalle Romagne convenga promuovere una formale dichiarazione d'unione al Piemonte, una specie di pronunciamento sia a Modena che a Bologna, sia nelle sole Legazioni se a Modena non si può. Che ne accade? O l'Austria interviene, ed allora il Piemonte occupa gli Appennini e dichiara la guerra. O lascia fare ed allora si accetta e si sostiene a spada tratta il fatto compiuto. Non ne dubiti, e nell'uno e nell'altro caso la Francia è con noi e l'Inghilterra non sarà contro di noi ».
E' la parola della decisione e dell'ardimento, è la passione dei fatti, caratteristica precisa dei costruttori. I fatti sono sempre stati maschi per la vita degli uomini come per la vita dei popoli, le ciancie verbali e giornalistiche hanno sempre lasciato una fuggevole traccia che non va oltre il clamore della cronaca; clamore, o Signori, che:
cotal vestigia in terra di sè lascia qual polve in aere od in acqua la spuma.
Ancora una volta la decisione vince, la volontà dei nostri uomini vince sulle tergiversazioni altrui e le domina ai nostri fini. Ad un articolo pacifista del « Moniteur Parigino » si risponde in Piemonte coi primi atti della mobilitazione. Mazzini, nemico acerrimo e palese di questa guerra, è disarmato.
Garibaldi a Medici che gli diceva presente Cialdini : « Se voi vi prenderete parte vi troverete probabilmente in faccia a Mazzini e questo potrebbe imbarazzarvi ». « Affatto — rispondeva Garibaldi — è al contrario quanto io di più desidero al mondo; perché la farei una volta finita con quell'uomo che considero come il maggior nemico d'Italia! ».
Nigra a Parigi continuava a spingere Cavour a far trovare fatti concreti. « Così è fatto l'Imperatore.
Bisogna pigliarlo com'è e costringerlo coi fatti a non deviare od a rientrare nella nostra via ». I nostri uomini erano ormai padroni della loro sorte e la iniziativa delle operazioni era nelle loro mani. Nigra ben sapeva che ormai la parola d'ordine che doveva determinare il grande avvenimento non doveva partire da Parigi ma da Torino, e che le fila che scappavano dalle mani dell'Imperatore dovevano essere raccolte e riunite da Camillo Cavour. E lo spronava rispettosamente, e gli faceva coraggio assicurandolo ancora che la Francia era ormai troppo impegnata per poter lasciar solo il Piemonte.
Questa prima battaglia politico-diplomatica fu vinta, e fu questo, io penso, il più grande miracolo compiuto per l'unità italiana. Venne la guerra. Guerra con bataille de soldats come dice uno storico francese in contrapposizione al telegramma di Napoleone III alla graziosa Imperatrice Grande bataille et grande victoire! (Se l'avessi detto io di qualcuna delle nostre quattordici Vittorie sarei andato per lo meno in fortezza!) Battaglia di soldati come nel 1866, anno in cui Nigra scrive a questo proposito parole roventi. Battaglia sanguinosa che costò quarantamila perdite e della quale, per la incertezza del comando supremo del nipote non affatto simile nelle armi allo zio gigante, non furono raccolti i frutti.
Vittoria senza inseguimento, con tranquillo ripiegamento degli austriaci battuti dal valore dei soldati nostri e francesi sotto i cannoni della fortificata Verona. Durante la ritirata l' esercito francopiemontese non si muove dopo di avere date nella battaglia prove di valore al disopra di ogni umana credibilità.
Dopo la vittoria; l'armistizio : Villafranca.
Nigra è a fianco di Cavour a Torino. Quando giunge la notizia il fedelissimo segretario interrogato dal Capo risponde : « E' la pace! ». Cavour vi crede subito e furibondo parte con lui per il campo nella speranza di giungere ancora in tempo. Sono di allora le bellissime escandescenze di Cavour col suo stesso Re impetuoso, apparentemente impulsivo nei suoi gesti talvolta, ma sempre presente a se stesso, sempre padrone dei suoi centri inibitori a Novara, a Villafranca, a Roma. Nigra assiste alle scene drammaticissime e sublimi fra il Re ed il più eccelso dei suoi servitori fatto arditissimo, forse anche insolente, nella sua opera di Costruttore per la Patria e per la Corona, di accanito difensore della intemerata gloria Sabauda. Vittorio Emanuele II, che ancora nell'aprile durante le indecisioni Napoleoniche scriveva a Cavour :
« Caro Conte, parmi che siamo a mal partito, quel cane d'Imperatore si burla di nostra figura... se si disarma facciamo la topica completa.... Coraggio però tutto non è ancora terminato e talvolta vi arriva la fortuna mentre che uno se la aspetta di meno », egli che aveva considerato il campo e la battaglia come massima fortuna, assume qui davanti al suo Ministro, irruente e disperato, la parte di temperatore.
Nigra era presente e serve da tramite. Il 10 giugno col treno e con una carretta Cavour seguito da Nigra piombava a Monzambano sul Mincio al Quartier Generale e giungeva alla presenza del Re a villa Melchiori. Re Vittorio spiegava, illustrava, segnava che le condizioni di pace sarebbero dure, durissime; Cavour aumentava la sua collera durante il proseguire del discorso. Lo stesso Nigra prudentissimo dovette dire e lasciar scritto che era stata una scena Shakespeariana; « Se noi dobbiamo morire, almeno moriamo con la testa alta! ».
Re Vittorio gli faceva considerare che per lo meno la Lombardia era presa e che non era il caso di turbarsi colla Francia col pericolo di rientrare a Torino come dopo Novara, ma Cavour non si conteneva più: "Allora Maestà cha abdica. — Ca staga citu, cha 's ricorda che mi son al Re — No Maestà al Re sun mi. La responsabilità a l'è la mia. — Chiel al Re? Ch'an fouta al camp! Chiel l'è mac an birichin".
II giorno dopo il Re fa chiamare di nuovo Cavour. La discussione riprende sui preliminari di pace copiati da Nigra e mostrati a Cavour e questi ritorna sul concetto della abdicazione gettando la carta sulla tavola, ma il Re interrompe : « Ah basta, io non le lascerò ripetere le insolenze di ieri! ».
Cavour si dimette. Il Re trova che Cavour non sta bene ed ordina a Nigra, presente, di accompagnarlo a letto e di condurgli il Generale La Marmora. E con La Marmora che mormora: «Fanno i pasticci poi mi chiamano a scioglierli », ripete il gesto fatto a Cavour, e, dopo avergli ordinato di comporre il Ministero, lo manda a letto accompagnato da Nigra. Diverse sono state le versioni su queste grandi scene di eroica passione nazionale svoltesi fra il Gran Re ed il Grande Ministro, ma il senatore Orsi qui presente che ebbe ad udirne la narrazione dalla viva voce di Costantino Nigra potrà confermare se io dico bene.
Venne la pace, più complessa della breve guerra, difficile come la preparazione della guerra, col continuo timore dell'abbandono e del tradimento, coll'Impero francese tornato in calda armonia coll'Austria.
Ai primi di febbraio del 1860 Cavour, ritornato più che mai forte al potere, affida a Nigra,
Incaricato di Affari, la gestione provvisoria della Legazione di Parigi, gestione che Nigra conserva, salvo breve interruzione, fatto prima Ministro nel marzo 1860 stesso, e poi Ambasciatore, fino al 1876.
E', sfrondati i,particolari, l'epoca delle annessioni, della marcia trionfale della idea unitaria e Sabauda per tutta la Penisola. Nigra opera ad attrarre ed a riunire i vari movimenti con un ardimento che ha del prodigio e della temerarietà, tutto il passato cade, tutto si stringe intorno al Re, la fucina lavora, lavora a creare l'enorme mirabile edificio di cui Cavour fu il più sublime degli architetti. Il Re opera e cammina, sempre ancora avanti-mano del suo Ministro, col quale bisticcia di quando in quando e che adora. Nigra dopo essere stato a Napoli dove ci lascia, mirabile documento, la sua relazione, lavora a Parigi a far digerire alla Francia del secondo impero, e per essa alle altre Potenze, la marcia miracolosa che ha ormai non soltanto più nel grido di guerra ma nei fatti la formula: « Italia e Vittorio Emanuele ». Italia e Savoia, due parole che si fondono per sempre in un solo pensiero unitario di ieri, di oggi e di domani; fondamenta delle Vittorie, base dell'ordine nuovo che oggi ci pone alla testa delle Nazioni datrici di civiltà, barra sicura del nostro domani Latino e Romano!
Nigra consiglia le annessioni contro la timida e talvolta imperiosa volontà della Francia.
« Io non so che cosa farà l'Imperatore, ma questo è certo che egli non potrà farci più male che non ce ne saremmo fatto colle nostre mani seguendo i suoi timidi consigli», scrive Nigra a Cavour.
E' l'opera tenace per la cessione della Savoia e di Nizza alla Francia, è l'assistenza instancabile e battagliera durante il periodo della conquista del Meridione della Penisola da parte di Garibaldi spinto ed aiutato da Cavour, è la cooperazione intelligentissima per giungere alla proclamazione del Regno, trionfo di Cavour, peana di gloria per Vittorio Emanuele, prima di tutte le nostre mete oramai raggiunta! Presto l'annessione! Dopo la gloriosa impresa di Garibaldi, « bisogna sopratutto scartare ogni idea di protettorato « Inglese o di Muratismo »! « L'Imperatrice è furibonda contro Garibaldi, scrive Nigra nel maggio del 1860, l'Imperatore è costretto egli stesso a prenderne le
difese contro le violenti escandescenze della sua Augusta Sposa ». E si osa e si vince. E l'Italia è fatta.
Dopo la Ho volu tmo oilrltues tdrai rCe amvoeuglri.o di ogni altra parte questa più alta e più gloriosa epopea non soltanto perché è meglio descritta nei documenti finora pubblicati ma anche perché costituisce il pieno meriggio della mirabile epopea del nostro Risorgimento, dove le altissime virtù di Costantino Nigra brillano vividissime anche se egli opera a fianco, ma all'ombra, del suo sublime maestro pur sempre, comunque sia, primo fra i numi tutelari della Patria. Ma, Nigra non era uno di quegli uomini, come purtroppo ce ne sono sempre stati e ce ne saranno sempre, che vivono come servì al fianco delle grandi figure della storia, ed, anziché apporto a loro di collaborazione e di forza, ne sottraggono quasi, cosicché per queste eccelse figure costituiscono ancora zavorra al pesante cammino, uomini che, quando scema o si offusca la luce del Maestro, rimangono fatalmente ed inevitabilmente al buio. Nigra diede invece apporto formidabile di potenza e di veggenza a Camillo di Cavour, e, quando la vita del grande artefice si spense, la luce di Nigra direi che brillò più viva. Certo la sua parola si fece con tutti, specie coi governi, più alta e spesse volte più dura, sempre cristallina e sincera, talora fino alla brutalità. Alla morte di Cavour Nigra non aveva ancora trentacinque anni; ma, da discepolo, si era fatto maestro, ed era perfettamente consapevole delle sue possibilità e della sua missione. Bisogna rivederlo al tempo di Mentana,
attaccato da tutti; anche dal suo Ministro, come si difende! Bisogna rileggere le parole profetiche colle quali egli antivede la guerra Franco-Prussiana e la successiva politica Francese ferocemente avversaria all'Italia; parole che egli ricorderà più tardi a Francesco Crispi quando il grande statista, dopo la grave tensione colla Francia nel marzo del 1894, fa proporre dal Ministro Blanc e propone egli stesso al Nigra di lasciare l'Ambasciata di Vienna per fare ritorno a quella di Parigi, proposta che l'Ambasciatore rifiuta. E' necessario anche ricordare come egli, fin quando è in piedi l'Impero, assicuri il suo Governo, e con pieno fondamento, che neppure per la questione di Roma l'Imperatore
e la stessa bionda Imperatrice si schiereranno decisamente contro l'Italia per la questione di Roma; neppure la cattolicissima Imperatrice, così ammansita che dona al bellissimo Ambasciatore la sua mano di fata scolpita nel più candido marmo!
Vi fu chi rilevò come Costantino Nigra negli ultimi anni della sua carriera, pur non perdendo nessuna delle stupende attività della sua mente poliedrica, parve troppo invaso da fosco pessimismo sull'avvenire d' Italia. Voglio bene crederlo, Signori, e non me ne meraviglio. Se io sono un poco riuscito in questa commemorazione che, anche troppo lunga, è necessariamente monca ed assolutamente manchevole, a rievocare ed a presentarvi nel quadro del suo tempo questa potente figura d'Italiano, ditemi voi, conoscendola, se sarebbe mai possibile che questo uomo vi approvasse la sinistra e decadente politica che trascina miseramente l'Italietta da Adua alla grande guerra? Dove
erano i lauri rampollati al tempo della sua giovinezza appassionata ed operosissima? Non più alto che a terra.
E quella non era certamente la continuazione della tradizione che egli aveva con tanta forza contribuito a creare!
Era desolato durante gli scioperi del 1904 tanto che nella espansione del dolore narrò, a quel fedelissimo Italiano e Piemontese che è Delfino Orsi, alcuna delle vicende epiche cui aveva assistito 45 anni prima? Niente di più naturale del suo pessimismo e del suo sconforto senile. Desolati eravamo noi, allora ventenni, tanto che durante quello sciopero io sono ben fiero di aver compiuto, inquadrato nei ranghi dei soldati del Re, la mia prima azione fascista! Bene tu hai veduto, Maestro, i tempi più tristi! Ma oggi noi, Italiani nuovi ed antichi, possiamo cantare alto e forte la tua gloria ricordandoti in quest'aula.
0 nostro grande maggiore fratello, o figlio della terra di Piemonte, dove si respirano coi profumi dei tuoi boschi, dove si bevono con l'acqua delle tue fontane e colla musica mesta e solenne dei tuoi canti, che sono i nostri boschi le nostre fonti, i nostri canti, le virtù guerriere e la fedeltà incorruttibile al Re Sabaudo.
Possiamo cantare alto la vostra gloria, o maggiori, perché da quella discende la nostra forza; e siamo felici di poterla cantare a coscienza tranquilla ed a fronte alta, con tutta la reverenza davanti a voi nostro Signore Principe di Piemonte; davanti a voi, Duca Sabaudo di Aosta, nostro Principe Condottiero.
La fierezza ci viene dalla certezza che, avendo, come l'ombra che è qui presente, in Senato per la sua glorificazione, servito e sparso il nostro sangue, sapremo tutti continuare a servire. In umiltà, sacrificalmente, la nostra Patria Romana, seguendo il nuovo grande Capo che la Provvidenza ci ha dato e per la maggior gloria di un Re che ha scritte e scrive nella storia pagine non meno grandi di quelle del suo Avo, per la potenza Italiana e Romana, Altezze Reali di Savoia, che è il nostro sole.
la tomba Nigra nel cimitero di Villa Castelnuovo (TO)
DISCORSO PER LA PARTENZA DI COSTANTINO NIGRA DA PARIGI NEL 1876 pronunciato dal Cavalier Angelo Toffoli a nome della Giunta della Società di Beneficienza creata dal Nigra per dare pane e lavoro ai poveri della Colonia Italiana in Francia - 28 giugno 1876
ECCELLENZA,
fu nel 1865 quando la provvidenza divina ispirò in Voi la santa idea di fondare in Parigi la Società di Beneficienza Italiana; e siccome, Egregio Ministro, la idea Vostra aveva per base la carità, così non poteva che prosperare a vantaggio dei poveri della nostra Colonia, pei quali Vi siete occupato particolarmente fin dal primo giorno che qui veniste a rappresentare e difendere l'onore e gli interessi della grande Nazione Italiana.
L'appello che Voi faceste agli uomini di buona volontà per coadiuvarvi nella santa idea, ed il pronto soccorso di questi, provarono, qual leva possente sia nel cuore umano la parola carità, e come sotto l'egida dell'illustre nome di Vostra Eccellenza essa sia giunta ad alleviare gli annui bisogni di tante povere famiglie, la più parte operaie, le quali prive di pane e lavoro, ed anche malate, ricorrono per soccorso al nostro Consolato.
Oh! come è bello il giorno in cui l'uomo può asciugare le lacrime di un povero padre di famiglia, ridotto alle volte senza pane e senza tetto pei suoi figli, nella mancanza di lavoro! E Vostra eccellenza, ispirata da Dio, che è la carità stessa, le ha asciugate queste lacrime le cento volte nel lungo tempo che dimoraste a Parigi.
Tali fatti Vi accompagneranno dovunque con quella gioia morale che Dio solo dona in premio a fa discendere nel cuore dell'uomo che ha esercitata la vera beneficienza.
Ma ahi ! non tutti sanno, nè sono penetrati del dolore e dell'avvilimento che l'operaio onesto sente nell'animo quando in sua vita fu sempre avvezzo a nutrirsi del pane guadagnato col sudore onorato della sua fronte, nel vedersi poi costretto, per mancanza di lavoro a chiedere l'elemosina!
Oh quante volte Eccellenza ebbi ad osservare discendere le scale del nostro Consolato, padri di famiglia operai avviliti, bagnando con grosse lacrime il soccorso ricevuto! .......
Fu dunque da tali fatti che dopo cessate le tremende catastrofi di onta e di sangue in Parigi dove i nostri poveri ebbero tanto a soffrire, sebbene assistiti in parte anche dal nostro Governo, che mi venne l'idea di creare una giunta, scelta fra i nostri colleghi della Società di Beneficienza i quali appartenendo alle varie industrie ed al
commercio, per le estese loro relazioni nei molti opifizi, potessero coadiuvarmi coll'impiegare quegli onesti operai soccorrendoli in tal modo col pane del lavoro. essi così evitavano l'avvilimento di questi infelici; mentre all'uomo che sente e soffre, la elemosina ammala l'intelletto, toglie le forze fisiche, e la compassione diventa una vera amarezza. Sottoposto il pensiero alla E.V. Voi con gioia l'accoglieste rispondendomi commosso: "Ah! Si la vera carità è di dare loro lavoro! Non indugiate e scegliete subito gli uomini di cuore che compagni vi siano in questa santa e sublime vostra idea".
Eccellenza Voi sempre promotore del bene, m'incoraggiaste ed io trovai i generosi che pronti accettarono, non solo impiegando molti derelitti, ma anche procurando lavoro alle mogli loro, e perfino vestendo quelli che ne bisognavano per poter essere accolti e la carità giunse fino a mandare nelle famiglie le più povere, da noi designate, e nel crudo inverno di che coprire le mogli ed i teneri figlioletti che molto pativano! Eccellenza ! Dopo cinque anni di aiuto prestatomi da questi miei colleghi in opera sì umanitaria permettete che io abbia l'onore di presentarveli, sicuro che Voi li accoglierete come discepoli Vostri. Loro a me uniti vengono ad esprimere il dolore nostro sentendovi prossimo ad abbandonare la nostra Colonia. Ma noi, Eccellenza, Vi seguiremo sempre col cuore riconoscente e col pensiero dovunque sarete; non solo pel bene immenso che faceste ai poveri di questa nostra Colonia, ma ben anche per quello che, mercé l'alta Vostra scienza politica, sapeste fare alla nostra Nazione, difendendo i diritti, e procurando il rispetto dovuto a quella Italia, che per lunghi anni fu schiava, e divisa, e che ora si chiama una Grande Nazione.
Cav. Angelo Toffoli
cav. Sully Seymour cav G. Morgantini
B.T. Ferrari I. Fontana
G.Hendle H. Lovengard
