ARTICOLO DI ALESSANDRO VITALE BROVARONE
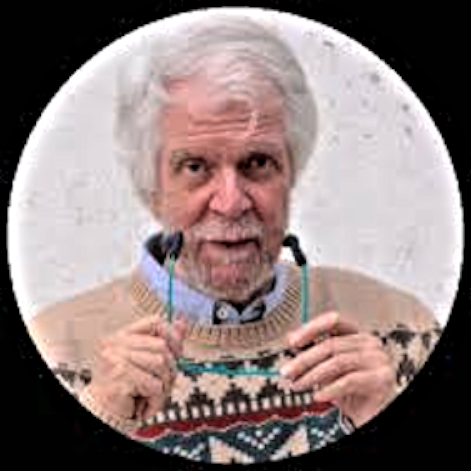
Sia pure in una angusta prospettiva critica e metodologica, l'attività di ricerca e studio dei canti popolari dell'Italia nordoccidentale precedette di parecchi anni la pubblicazione dei Canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra e ne accompagnò la stesura e l'elaborazione, protrattasi almeno dal 1854 al 1888.
Di questa attività, cui il Nigra riconosce il suo debito, è rimasta soltanto, a quanto mi consta, una tenue traccia di Canti popolari Umbri, Liguri, Piceni, Piemontesi e Latini di Oreste Marcoaldi.
Il Marcoaldi, marchigiano, si servì a sua volta principalmente, per la parte ligure e piemontese, di una raccolta manoscritta di Domenico Buffa, risalente approssimativamente agli anni '40. Tale raccolta, sappiamo ancora dal Marcoaldi, era passata attraverso le mani del Tommaseo, che stava allora raccogliendo materiali per una raccolta di canti popolari di tutte le province italiane.
Ma i debiti e le riconoscenze del Nigra vanno oltre: « Un'altra parte considerevole della collezione [oltre quella costituita dai canti raccolti personalmente], mi fu trasmessa o rimessa da molti collaboratori, alcuni dei quali portano un nome ben noto in Italia. Giovanni Picchia, l'illustre professore di sanscrito nell'Università torinese, mi diede, fin dal 1853, una raccolta di canzoni da lui trascritte in Torino sotto la dettatura di Giuseppina Morra-Fassetti. Domenico Carbone, già compagno di studi e d'armi, non mai abbastanza compianto, mi diede, nel 1858, le canzoni da lui raccolte nel suo nativo villaggio di Carbonara presso Tortona. Domenico Buffa, noto non solo nel campo letterario, ma ben più nella storia politica del nostro paese, mi fece dono, egualmente nel 1858, del suo manoscritto di canti popolari piemontesi e liguri da lui raccolti, dal 1842 al 1845, dal quale Oreste Marcoaldi trasse tutta la parte ligure e piemontese della sua collezione, e in cui mi rimase pur qualche cosa a spigolare. Parenti, amici e colleghi trascrissero per me molte lezioni in varie parti del Piemonte: Teresa Croce, già nominata, in Sale-Castelnuovo nel Canavese; Emerenziana Nigra-Vegezzi-Ruscalla, e Adele Bolens sulla collina di Torino; Enrichetta Cassone in Moncalvo-Monferrato; Felice Oddone in Era; Luigi Bassi in Mondovì, Torino e Pinerolo; Carlo Franchelli, morto sui campi di battaglia a San Martino, nella campagna di Torino; G. B. Gandino in Era e Mondovì; Bernardo Buscagliene in Graglia presso Biella; Garnerone in Lanzo Torinese; D. Monello in Montaldo di Mondovì; Gaudenzio Caire in Pinerolo e Novara; Giuseppe Rossi in Saluzzo; Pietro Fenoglio in Bene-Vagenna di Mondovì; G. B. Amidei in Paesana, Lagnasco, e Val di Po, circondario di Saluzzo; Annibale Strambio in Rocca d'Arazzo, circondario d'Asti. E finalmente due buone collezioni mi furon trascritte, una da Nicolo Bianco in Val-fenera d'Asti, e una da Tommaso Borgogno a La Morrà, circondario d'Alba in Monferrato, mentre egli era colà giudice di mandamento. Qualche canzone mi fu pure trasmessa da Giuseppe Regaldi da Parma, da A. Berti da Venezia, da Cristoforo Pasqualigo da Lonigo nel Vicentino, da Gabriele Rosa da Brescia, da Alessandro D'Ancona da Pisa; altre da altrove »
L'ingresso, a mio giudizio molto proficuo, in questa « zona d'ombra » della cultura piemontese pre-unitaria, ci è reso possibile dal Nigra stesso che si preoccupò, con l'onestà scientifica che ha lasciato grande impronta nei Canti popolari del Piemonte, di render pubblico il materiale di cui si era servito. Il Nigra infatti inviò in dono alla Biblioteca Nazionale di Torino un pacco contenente una buona parte delle raccolte manoscritte che gli abbiamo visto ricordare. I fascicoli e i fogli inviati dal Nigra furono poi legati e sono tuttora conservati tra i manoscritti della Biblioteca Nazionale con la segnatura R III 7.
Il materiale è preceduto da una lettera di accompagnamento di mano del Nigra:
Signor Prefetto Venezia 24 Febb. 1904
Mi pregio di mandare in dono alla Biblioteca Nazionale di Torino un piccolo pacco di Canti popolari principalmente dell'Alta Italia, manoscritti, raccolti da: Giovanni Flechia - E.a Cassone - Regaldi Dal Medico - Gaudenzio Caire - Cav. Strambio - Dott. Nicolo Bianco - Domenico Buffa - Domenico Carbone - Herm. Kestner. Furono questi canti in massima parte pubblicati da me e da altri. Alcuni sono inediti, o almeno presentano varianti inedite. Ad ogni modo sono documenti sinceri, utili a consultarsi da chi si occupi di studj folklorici; e sarebbe ora diffìcile il trovarli ancora, in parte almeno, sulla bocca del popolo. Gradisca, Signor Prefetto, l'espressione della mia distintissima considerazione C. Nigra
II quadro presentatoci dal Nigra — ma, teniamo conto, un Nigra ormai molto avanti con gli anni - è, a mio avviso, pessimistico. Infatti, come ho potuto constatare attraverso uno spoglio integrale del materiale ed un confronto con i testi editi dal Nigra e dal Marcoaldi, una buona parte del materiale è inedita. Il manoscritto è composto da:
a) 1 lettera d'accompagnamento (ined.) — b] 4 quaderni di Canti popolari in varii dialetti d'Italia raccolti per opera di Domenico Buffa (rispettivamente: 1) Genova: 5 canzoni, 2 edite dal Marcoaldi e 2 edite dal Nigra; di esse una è edita dal Nigra e dal Màrcoaldi; inedite 2. - 2) Porto Maurizio: 29 strambotti dei quali 6 editi dal Màrcoaldi; inediti 23. - 3) Orba: 122 strambotti e 1 canzone; 28 editi dal Màrcoaldi, 7 editi dal Nigra; inediti 88 e 1 canzone. — 4) Ovada: 108 strambotti e 8 canzoni; degli strambotti 28 sono editi dal Màrcoaldi, 10 dal Nigra; inediti 70. Delle canzoni 4 sono edite dal Màrcoaldi, 2 dal Nigra; inedite 2. Inoltre si hanno 2 strambotti raccolti ad Ovada, ma da un informatore Veneto, inediti. - 5) Alessandria: 79 strambotti e 17 canzoni. Degli strambotti 22 sono editi dal Nigra, 37 dal Mar-coaldi, 1 dal Nigra e dal Màrcoaldi; inediti 21. Delle canzoni 2 sono edite dal Nigra, 9 dal Màrcoaldi, ma senza le varianti date dal Buffa; inedite 6. -6) Oleggio: 7 canzoni di cui 6 edite dal Màrcoaldi; 1 inedita. - 7) Rocca di Corio (Canavese): 9 strambotti e 1 canzone. Degli strambotti 5 sono editi dal Màrcoaldi, 1 dal Nigra; inediti 3. La canzone è edita dal Nigra. - 8) Rocca d'Arazzo: 1 canzone inedita). — e) Canson Piemonteise raccolte da Giovanni Flechia e da lui trasmesse a me. C.N. (1853): 27 canzoni, 14 edite dal Nigra; inedite 14. — d) Strambotti (detti notturni) raccolti in Moncalvo, Basso Monferrato da Enrichetta Cassone. 17, di cui 7 editi dal Nigra; inediti 10. — e) Donna lombarda raccolta a Parma da Regaldi. Edita; inedita la lettera di accompagnamento. — /) Donna lombarda raccolta a Venezia da Dal Medico. Edita; inedita la lettera di accompagnamento. — g) Canzoni popolari di Novara, raccolte da G. Caire. 12, di cui 7 edite dal Nigra; inedite 5. — h) Canzone veneziana raccolta da G. Vallo. Inedita. •— i) « Strambotti che si cantano dai contadini di Rocca d'Arazzo, provincia d'Asti » racc. dal Cav. Strambio (1850-1860). 144 strambotti, di cui 6 ripetuti, 50 editi; inediti 88. — ;) Strambotti - Valfenera (Asti) racc. dal Sig. D.r Nicolo Bianco (1850-1860). 24, di cui 6 editi dal Nigra; inediti 18. — k) Lettera di H. Kestner contenente alcune melodie, con lettera d'accompagnamento di Bunsen, da Torino. Segue altra comunicazione di H. Kestner a Nigra. Alcune delle melodie mi risultano inedite. — /) Canzoni e strambotti raccolti da D.co Carbone a Tortona. 17 canzoni, di cui 11 edite dal Nigra, 6 inedite; è allegata una lettera di Silvio Lessona. — m) Strambotti, Carbonara presso Tortona. D. Carbone. 76 strambotti, di cui 42 editi dal Nigra; 34 inediti.
Risultano in questo modo inediti, nel complesso, 38 canzoni, 357 strambotti e alcune melodie. È lecito, a questo punto, chiedersi come mai il Nigra abbia indicato come editi tanti testi che risultano invece inediti. Osservando innanzi tutto come la maggior parte dei testi inediti contenuti nelle nostre raccolte sia costituita da strambotti, e soprattutto di provenienza monferrina, possiamo proporre diverse interpretazioni: innanzi tutto che il Nigra ritenesse, anche implicitamente, il concetto di « variante » come proprio della canzone epico-lirica, e non estendibile allo strambotto, e vedesse dunque come esaurienti le raccolte del Marcoaldi, del Ferraro e la sua; che vedesse, scendendo via via per il Monferrato, attenuarsi le sue competenze a vantaggio del Ferraro; che infine ritenesse « scomoda » la grande quantità di strambotti, raccolta dal Buffa, ai fini della dimostrazione della sua tesi, che, come è noto, indica la canzone epico-lirica come tipica del canto popolare del settentrione, attribuendo invece al canto lirico mono-strofico, e dunque anche allo strambotto, una origine meridionale.
Certamente la validità del lavoro del Nigra non viene posta in discussione da queste omissioni, d'altra parte riconosciute implicitamente dal Nigra stesso[2]; tuttavia mi pare che si imponga, a questo punto, una ricognizione, il più possibile completa, sia sul terreno, sia sui documenti lasciatici da raccoglitori del secolo scorso e depositati in biblioteche o archivi pubblici, come i nostri, o privati, come quelli segnalati dal Costa.
Un ampio lavoro di raccolta orientato in questo senso credo possa chiarire, oltre che il problema dello strambotto in sé, anche i più generali problemi di tradizione, diffusione e invenzione del canto popolare: attraverso un confronto morfologico e tematico di canti popolari raccolti in momenti diversi e, almeno nel nostro caso, con la certezza della non dipendenza dalla fonte ottocentesca scritta dei canti registrabili ora (come potrebbe essere successo per alcuni tra i Canti popolari del Piemonte del Nigra) sarà possibile individuare due status successivi che potranno dare positive indicazioni sulle linee di trasmissione e sulle innovazioni nel canto popolare.
È certo comunque che i dati fornitici dai raccoglitori ottocenteschi non sono di per sé confrontabili con quelli raccolti ora: le diversità sia di prospettiva storico-critica, sia di metodo di rilevazione, possono da un lato aver guidato scelte e esclusioni ora non accettate, e d'altro lato possono aver compromesso sensibilmente il dato linguistico. Si pone dunque la necessità di una riscoperta, il più possibile completa, delle nostre più antiche raccolte di canti popolari, intesa a porre in luce, oltre che una buona quantità di materiali, tutto un complesso di atteggiamenti che devono essere tenuti presenti ai fini di un corretto impiego, in prospettive critiche diverse da quelle ottocentesche, dei materiali stessi. A questo vuoi contribuire la pubblicazione di una parte dei testi che ho segnalati.
Dovendo trarre qualche dato che possa illustrare la qualità dei materiali reperibili nel manoscritto notato, mi pare che la scelta debba cadere (come ritengo si possa avvertire dalle pagine precedenti) sulla raccolta del Buffa, per diversi motivi: innanzi tutto per la sua ricchezza; per la zona che essa prevalentemente copre (dalla Liguria fino all'Alessandrino e al Monferrato meridionale), zona fra le meno esplorate dal punto di vista folklorico e dialetto-logico; infine, e soprattutto, perché da questa raccolta emerge la figura di un ordinatore che, sia pure con molte ingenuità, ha dato prova di un impegno certamente non episodico e superficiale. Fra la grande quantità di materiale raccolto dal Buffa è necessario però operare una ulteriore scelta e credo sia opportuno limitare la nostra attenzione agli strambotti raccolti ad Ovada che mi pare possano porre in rilievo l'importanza di una zona di incontro e di scambio culturale e linguistico.
Riporto ora i testi raccolti dal Buffa presso Ovada, con le sue note a carattere linguistico e culturale, compresi quelli già inseriti nelle raccolte del Marcoaldi e del Nigra, sia per mantenere intatto l'aspetto storico-culturale della raccolta del Buffa, sia per sanare i guasti di trascrizione, un po' italianizzata dal Marcoaldi, e invece piemontesizzata dal Nigra. Riporto inoltre i criteri di trascrizione usati dal Buffa, che oltre alla loro utilità pratica, possono risultare un ottimo punto di riferimento per la conoscenza degli strumenti del raccoglitore.
pagg. 1-2
AVVISO - Tutti i vari dialetti a' quali appartengono i canti seguenti prepongono al verbo certe vocali, che fanno le veci di pronomi personali: talché questi possono essere omessi, e lo sono infatti il più delle volte nel parlar comune. Non tutti però questi dialetti usano le stesse vocali, ma a un dipresso le stesse. Eccole:
Sing. Plur.
a diggu (dico) a dimmu (diciamo) altri dialetti i
i 't dixi (in alcuni dialetti a 't) i dì
u dixe, e nel femm. a dixe i dixu (altri a)
Se queste vocali siano una corruzione degli stessi pronomi, non so: certo l'i della 3a persona plurale par che venga dal latino itti e più immediatamente dal francese ih: e ne da pure indizio il dialetto piemontese che nella la persona sing. usa i' invece di a. Quel che io so dire si è che esse non possono mai essere tralasciate, neanche quando si usano i pronomi.
Per la più facile intelligenza de' dialetti nota anche l'uso che essi hanno frequente di por due esse dove nell'italiano cade la zela, e l'altro di mutar spessissimo l'o in «, specialmente nelle finali. Perché ad ogni dialetto non si mutasse ortografia (il che avrebbe impicciato non poco i lettori) fui obbligato a farmene una generale, da applicarsi a tutti, ed è la seguente:
«, si pronuncia all'italiana. — u, alla francese. — e, come un'e molto larga. — o, come la eu francese. Quando la vocale che ha sopra le due virgolette richiede accento, io muto quelle in due accenti, così amè * (amare), virtù (virtù), andrò (anderò). — se**, come la eh francese. Qualcuno penserà che a tal uopo avrei dovuto, usare la eh francese, come già conosciuta: ma l'inconveniente sarebbe stato maggiore, perché, come avrei dovuto allora scrivere la eh italiana? per es. nella parola masc-cbe (guancie)? l'accento circonflesso che servisse d'unione fra le due consonante era anche necessario perché ad ogni poco non nascessero dubbi sulla pronunzia, come in scacca, scurté, tasctu, ed infinite simili. — x, come la /' francese. — 's, come la s italiana nella parola rosa. Questa esse è in molti dialetti sostituita sovente alla zeta italiana.
È anche da notarsi che i dialetti dell'Orba e d'Ovada (i quali, provenendo dal genovese, hanno come questo la più parte dei vocaboli non tronchi) usano troncarli tutti senza distinzione qualora cadano in parte del periodo che dette intiere allungherebbero troppo, o non renderebbero armonia. Perciò ne' lor canti s'incontreranno talvolta parole che parranno nuove e non saranno che le già vedute e spiegate altrove, colla sola differenza del mancarci la finale.
Canti popolari del basso Monferrato, Palermo, 1888; Canti popolari monferrini, Torino-Firenze, 1870; / canti popolari del Monferrato, Firenze, 1872; Superstizioni, usi e proverbi monferrini, Palermo, 1866.
C. nigra, op. cit,, p. xxix: « La raccolta si chiude con una piccola raccolta di Strambotti e Stornelli, nello scegliere i quali mi studiai di escludere quelli che fossero già stati pubblicati da altri, salvo poche eccezioni giustificate da varianti meritevoli di qualche attenzione ».
Come quella compiuta da F. Castelli, nella sua tesi di laurea Canti popolari dell'Alessandrino, discussa presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Torino, relatore il professor E. Bonora. Nella sua tesi, ancora inedita ma in fase di rielaborazione, il Castelli, dopo una premessa metodologica, che condivido pienamente, da una abbondante quantità di strambotti (100 più varianti) e di stornelli (95 più varianti), con abbondanti riscontri con canti di altre zone; raccoglie un buon numero di schemi musicali; compie infine uno studio morfologico sullo strambotto piemontese che, oltre a costituire un ottimo status quaestionis, pone, in base ai risultati, nuovamente in discussione tutto il problema dell'origine e della diffusione dello strambotto.
E. costa, Tommaseo, Nigra e la « Raccolta di canzoni popolari » di Domenico Buffa, in « Archivio Storico del Monferrato», 1 (1960), pp. 107-141. Il Costa, che per altro non da le referenze del suo materiale (« Tra i manoscritti dello studioso ovadese abbiamo trovato un ampio fascicolo intitolato Raccolta di canzoni popolari, 1840 », p. 107, senza ulteriori indicazioni), traccia una storia del nostro materiale, senza però averlo sotto mano, e ne documenta i successivi passaggi dal Buffa al Tommaseo, di nuovo al Buffa, al Marcoaldi, al Tommaseo, al Buffa e infine al Nigra.
Ovviamente non intervengo per correggere il dato manoscritto, neppure nel caso di oscillazioni nella grafia della stessa parola. Tra parentesi quadre do riferimento ai testi editi dal Marcoaldi (M) e dal Nigra (N), indicando il numero della pagina seguito dal numero della composizione
